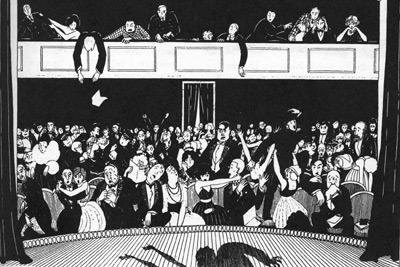Ad alzo zero
 Ho chiesto all’Einaudi l’ultimo libro di Vitaliano Trevisan, Il ponte – Un crollo, subito dopo avere letto un’intervista allo scrittore vicentino su “Il Venerdì” di Repubblica. In quell’articolo, pubblicato due o tre settimane fa, Trevisan sparava a zero su tutto e tutti, con una lucida rabbia che mi aveva davvero sorpreso. Vorrei essere più preciso, ma purtroppo ho buttato quella copia del giornale.
Ho chiesto all’Einaudi l’ultimo libro di Vitaliano Trevisan, Il ponte – Un crollo, subito dopo avere letto un’intervista allo scrittore vicentino su “Il Venerdì” di Repubblica. In quell’articolo, pubblicato due o tre settimane fa, Trevisan sparava a zero su tutto e tutti, con una lucida rabbia che mi aveva davvero sorpreso. Vorrei essere più preciso, ma purtroppo ho buttato quella copia del giornale.
Non appena ho iniziato a leggerlo ho pensato a due cose. La prima: voglio intervistare Trevisan. La seconda: ho paura di farlo. Non mi capita spesso di avere paura di fare qualcosa: sul lavoro, al massimo, ho avuto una sorta di timore reverenziale nel telefonare o incontrare qualcuno.
E più andavo avanti nella lettura più questi due sentimenti contrastanti aumentavano, alimentandosi l’uno con l’altro.
Il ponte è una sorta di lunga confessione mentale di un uomo, nato a Vicenza, ma che ha lasciato da una decina d’anni l’Italia e tutto lo schifo che la forma. Trevisan, attraverso le sue parole fitte (nella parte centrale del romanzo, più di cento pagine, c’è solo un salto di paragrafo e due “a capo”, alla faccia della presunta “poesia delle pagine bianche” di cui parlavo qualche settimana fa) esprime qualcosa che è più di un generico disprezzo del nostro paese: in fondo, chi è che non si lamenta di come vanno le cose in Italia? La rabbia di Thomas, il protagonista del libro, è diretta e cristallina come quella espressa da Trevisan in quell’intervista, nonostante Thomas parli continuamente di una malattia, che forse lo eleva a diverso e lo stacca dalla massa dalla quale ha tentato di isolarsi fisicamente trasferendosi in Germania. Nel suo lungo monologo, il narratore si interroga sulla scrittura, sulla famiglia, sulla politica, sulla società e sulla cultura italiana, sul suo cedimento ormai definitivo, già preannunciato, con la consueta brillante lungimiranza, da Pier Paolo Pasolini trenta e passa anni fa.
E non è un caso che Pasolini torni come punto di riferimento, come unico possibile interlocutore italiano, oltre a Thomas Bernhard. Ma non “da morto”, bensì da vivo, attraverso le sue parole, che possono essere solo rilette, senza riesumazioni di sorta.
A questo proposito Trevisan fa dire al suo protagonista delle parole lapidarie a proposito della morte, il vero tema centrale del romanzo:
“(…) i morti sono tutti uguali, si è detto, e dunque vanno onorati tutti nello stesso modo, ed è così: i morti sono tutti uguali, ma il giudizio dovrebbe riguardare solo quanto hanno fatto, o non hanno fatto, da vivi. I morti sarebbe meglio lasciarli dormire, e invece essi vengono riesumati e ricomposti di continuo, e usati di continuo per gli scopi più bassi e meschini, col risultato che si continua a raccontare sempre e soltanto la storia di un fallimento dopo l’altro, a cui manca sempre la parola fine, cioè manca sempre un responsabile. In fondo, pensai, è esattamente quello che faccio anch’io. Cercare di dare un senso al mio proprio frammento di presente in quanto presente in cui il passato non smette di crollare“ (Vitaliano Trevisan, Il ponte – Un crollo, Einaudi 2007, pag. 115)
Ecco l’intervista a Vitaliano Trevisan!