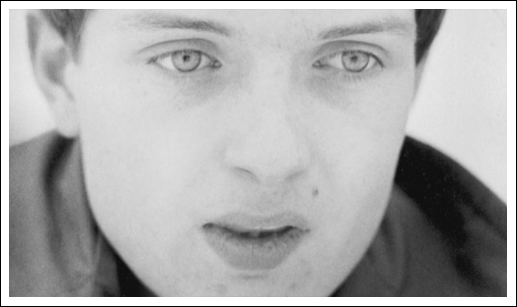You Speak My Language
Mi ricordo benissimo quando ho sentito per la prima volta i Morphine: era l’estate del 1995 e un amico mi passò Yes, uscito qualche mese prima. Avevo appena diciassette anni, eppure quei brani mi colpirono tantissimo: erano liberi, del tutto originali, unici nel loro genere. Poco alla volta recuperai la discografia dei Morphine, conclusa con il cd masterizzato di The Night, nel 2000, quando Mark Sandman era già morto da un anno abbondante. Diciassette anni dopo penso ancora che le canzoni dei Morphine siano una specie di unicum.
I Morphine sono ormai per me un metro di paragone inevitabile: non arrivo a dire “se ti piacciono sei mio amico, se no no”, però mi trovo in sintonia con chi li ama. Un po’ come faccio con i Monty Python. In fondo, per capire bene la band di Boston e il gruppo di matti per lo più britannici, bisogna comprendere il loro modo di comunicare e, cosa non da poco, la loro ironia.
I Morphine sono stati, con “Have a Lucky Day”, la sigla finale di Monolocane (la trasmissione notturna che ho condotto tanti anni fa), con “Honey White” (la traccia che apre Yes) il ritorno a quell’estate di metà anni Novanta, con “The Night” il suggello tremendo di qualcosa di meraviglioso che avrebbe potuto essere e che non sarà mai.
Quando, qualche mese fa, ho scoperto che la Gatling Pictures aveva prodotto un documentario sul leader della band, Cure for Pain – The Mark Sandman story, ho sentito che volevo e dovevo fare qualcosa su questo film che ancora neanche possedevo. E ho contattato subito la casa di produzione, il produttore Jeff Broadway e il sassofonista dei Morphine, Dana Colley. Non lo faccio mai: prima di parlarne per lavoro voglio ascoltare, vedere e leggere. Ho rischiato, perché sentivo che il documentario era qualcosa di buono: quando l’ho visto, nonostante tutti questi pregiudizi positivi, il mio stupore è stato grande. I registi di Cure for Pain sono riusciti a realizzare un bel film, da ogni punto di vista, adottando una prospettiva rischiosa (quella della tremenda storia dei Sandman) e portando lo spettatore ad appassionarsi a una storia unica e per lo più misconosciuta.
Finalmente lo speciale su Cure for Pain – The Mark Sandman story è pronto: va in onda questo pomeriggio in Maps e, da domani, potrete riascoltarlo andando qua. Come “regalino” per voi fedeli lettori, vi anticipo il contenuto delle interviste che hanno trovato posto nello speciale, trascritte in forma integrale. Se non volete rovinarvi la sorpresa perché preferite sintonizzarvi su RCdC intorno alle 16 di questo pomeriggio, vi basta non cliccare qua sotto. Per tutti gli altri, buona lettura. Per gli altri che amano alla follia i Morphine, spero che l’ascolto e la lettura siano emozionanti quanto per me preparare questo lavoro; in fondo, tutto questo è che anche per voi: “you speak my language”.