La visione della RAI da vicino
 Dovevo andarci martedì, invece, causa sciopero dei treni, è stata la giornata di ieri a farmi vedere la Rai da dentro, per la prima volta.
Dovevo andarci martedì, invece, causa sciopero dei treni, è stata la giornata di ieri a farmi vedere la Rai da dentro, per la prima volta.
Come un vero professionista, ho preso il mio bell’Eurostar da Bologna alle dieci meno un quarto, per arrivare a Roma alle dodici e trenta.
Come un vero professionista, l’Eurostar ha ritardato di dieci minuti.
Come nei film, c’era la coda per i taxi.
Come un vero professionista, ho varcato le soglie di via Asiago 10 alle tredici e ventinove esatte. Ho detto il mio nome, hanno fatto una scansione della mia carta d’identità, mi hanno dato un pass (che però si dice passi, congiuntivo ottativo?), ho provato a passarlo nel lettore perché si aprissero le porte, dopo qualche tentativo, finalmente, sono entrato in Rai. Detta così sembra che avessi in mano un contratto. In realtà avevo in mano solo il passi, che, non so per quale motivo, aveva scritto sopra “scadenza alle 1334”. Per un momento ho pensato che avrei finito il resto dei miei giorni nelle stanze dell’azienda, tipo The Terminal.
In Rai tutti ti guardano con interesse, forse perché pensano che tu sia qualcuno di famoso. No, lo dico perché anche a me sembrava di avere già visto da qualche parte le facce che ho incrociato: cosa assurda, visto che, con ogni probabilità, era tutta gente che lavora in radio.
Comunque, sono salito al quarto piano e lì ho incontrato Violetta e la redazione di Atlantis. Qualche chiacchiera, poi abbiamo registrato i miei pezzi, che andranno in onda la prossima settimana, credo.
Alle due del pomeriggio ero già con Violetta a mangiare un tramezzino.
Alle due e cinquanta ero già sul treno per Bologna, sì, come i veri professionisti.
Trenitalia, però, ha surclassato il professionismo dell’andata, e quindi l’Eurostar è arrivato con mezz’ora di ritardo. Non ventinove minuti, trenta: scatta il lauto rimborso, per una cifra, presumo, intorno ai nove euro.
 La stessa, guarda un po’, che serve per portarvi a casa questo.
La stessa, guarda un po’, che serve per portarvi a casa questo.
Io lunedì parto per la Slovenia, come annunciato. Ma spero, prima di regalarvi una puntata di Referrers. Non assicuro niente, anche perché se continua questo caldo mi fonderò con la tastiera, come in una versione aggiornata de Il pasto nudo.
Statemi bene.


 Brian Wilson non ce la fa. E qui scatta la commozione, perché uno dei veri geni della musica americana non ce la fa più, nonostante sia coetaneo di McCartney, Bowie, Jagger, gente che salta, canta, balla. Lui non ce la fa, e si vede. Sta seduto, agita le mani come farebbe un vecchio nonno un po’ rimbambito, legge le parole sugli schermi che ha davanti.
Brian Wilson non ce la fa. E qui scatta la commozione, perché uno dei veri geni della musica americana non ce la fa più, nonostante sia coetaneo di McCartney, Bowie, Jagger, gente che salta, canta, balla. Lui non ce la fa, e si vede. Sta seduto, agita le mani come farebbe un vecchio nonno un po’ rimbambito, legge le parole sugli schermi che ha davanti. prima, probabilmente, per il peso di un padre-padrone-manager ossessivo. Poi, per i Beatles: diciamocelo, ma vi rendete conto, soffrire per i Beatles? Voglio dire, hanno provato questo lui, Pete Best (il loro primo batterista) e Stuart Sutcliffe (mollato prima di incidere il primo disco). Wilson soffre perché sente che, dall’altra parte dell’oceano, c’è qualcuno che fa musica in maniera geniale. Esce Rubber Soul, nel 1965, e lui dice: “Minchia!” (probabilmente). E poi aggiunge: “Adesso vi faccio vedere io.” E sforna quel capolavoro che è Pet Sounds. Tre mesi dopo i Beatles fanno uscire Revolver. Dieci mesi dopo ancora, Sgt. Pepper’s. E Brian crolla, letteralmente.
prima, probabilmente, per il peso di un padre-padrone-manager ossessivo. Poi, per i Beatles: diciamocelo, ma vi rendete conto, soffrire per i Beatles? Voglio dire, hanno provato questo lui, Pete Best (il loro primo batterista) e Stuart Sutcliffe (mollato prima di incidere il primo disco). Wilson soffre perché sente che, dall’altra parte dell’oceano, c’è qualcuno che fa musica in maniera geniale. Esce Rubber Soul, nel 1965, e lui dice: “Minchia!” (probabilmente). E poi aggiunge: “Adesso vi faccio vedere io.” E sforna quel capolavoro che è Pet Sounds. Tre mesi dopo i Beatles fanno uscire Revolver. Dieci mesi dopo ancora, Sgt. Pepper’s. E Brian crolla, letteralmente. Tutto questo, badate bene, scrivendo canzoni che, perdonatemi la banalità, appena iniziano fanno spuntare sorrisi e bermuda a chiunque.
Tutto questo, badate bene, scrivendo canzoni che, perdonatemi la banalità, appena iniziano fanno spuntare sorrisi e bermuda a chiunque.
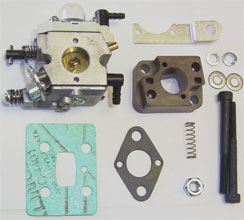
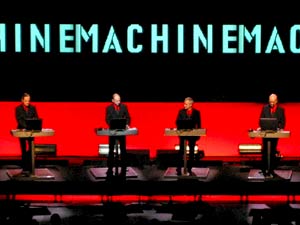
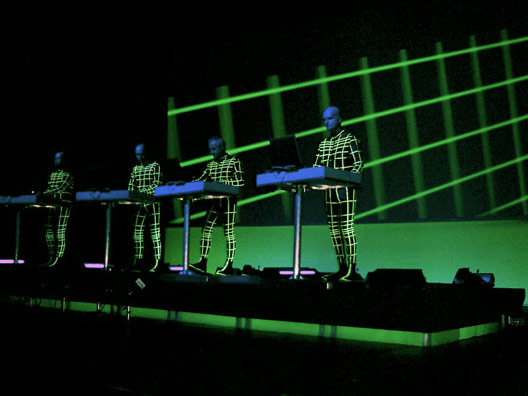
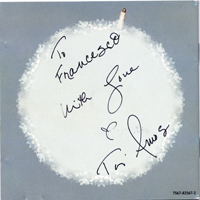 fissa negli occhi, quando parla. Ora voi, miei piccoli lettori, mi direte: “Ma come, ti fissa negli occhi e tu riesci a scrivere queste cose? Dovresti essere morto più di ventiquattro ore fa”. E invece no. Perché è come si dice, ve lo giuro. Questa donna è speciale. Ti mette a suo agio senza apparentemente fare niente, anche se è stanca è attenta a quello che le viene detto, ci pensa prima di rispondere ad una domanda (e per quanto mi sia sforzato, è improbabile che le mie domande le risultino del tutto inedite). Tant’è che mi sblocco dal mio mutismo adorante e inizio a conversare con lei, e la sento vicina come l’ho sempre sentita. (Ogni tanto una voce mi ripete “Ma ti rendi conto? Tori Amos è seduta qui davanti a te e state parlando”, ma le dico che deve studiare per il compito di mate e lei torna buona nei miei diciassette anni.)
fissa negli occhi, quando parla. Ora voi, miei piccoli lettori, mi direte: “Ma come, ti fissa negli occhi e tu riesci a scrivere queste cose? Dovresti essere morto più di ventiquattro ore fa”. E invece no. Perché è come si dice, ve lo giuro. Questa donna è speciale. Ti mette a suo agio senza apparentemente fare niente, anche se è stanca è attenta a quello che le viene detto, ci pensa prima di rispondere ad una domanda (e per quanto mi sia sforzato, è improbabile che le mie domande le risultino del tutto inedite). Tant’è che mi sblocco dal mio mutismo adorante e inizio a conversare con lei, e la sento vicina come l’ho sempre sentita. (Ogni tanto una voce mi ripete “Ma ti rendi conto? Tori Amos è seduta qui davanti a te e state parlando”, ma le dico che deve studiare per il compito di mate e lei torna buona nei miei diciassette anni.)