Dagli archivi: MiceCars – A S I M O / I
MiceCars – A S I M O / I (Black Lodge), 24 febbraio 2014
7
 Dieci anni fa un ep, quindi l’album I’m the Creature, premio Fuori dal Mucchio per il migliore esordio. Poi nulla fino allo scorso giugno, quando è comparsa “Volunteer”, ora posta a chiusura di A S I M O / I, l’atteso ritorno dei MiceCars. “You should not play with my heart tonight / And praise our love with another lie”, dice la canzone: le parole e il cantato in falsetto rimandano al 2004, ma Little P. e Peter T. (che suonano insieme ad Andrea Mancin, Oliviero Farneti, Pasquale Citera e Marco Caizzi) sono ancora più disillusi e amaramente ironici sin dall’apertura “Mutual Destruction Assistance”, che riporta alla sfera intima e relazionale l’annientamento reciproco paventato nell’era nucleare richiamato dal titolo.
Dieci anni fa un ep, quindi l’album I’m the Creature, premio Fuori dal Mucchio per il migliore esordio. Poi nulla fino allo scorso giugno, quando è comparsa “Volunteer”, ora posta a chiusura di A S I M O / I, l’atteso ritorno dei MiceCars. “You should not play with my heart tonight / And praise our love with another lie”, dice la canzone: le parole e il cantato in falsetto rimandano al 2004, ma Little P. e Peter T. (che suonano insieme ad Andrea Mancin, Oliviero Farneti, Pasquale Citera e Marco Caizzi) sono ancora più disillusi e amaramente ironici sin dall’apertura “Mutual Destruction Assistance”, che riporta alla sfera intima e relazionale l’annientamento reciproco paventato nell’era nucleare richiamato dal titolo.
Nell’album, prodotto dal duo insieme a Andrea Sologni, si percepisce un senso di isolamento e abbandono nei confronti di se stessi e dell’umanità. Un concetto su cui i MiceCars sperimentano a modo loro, per fortuna: se alcuni finali sono prolissi e stride un po’ il rap di “In da Ghetto”, convincono gli arrangiamenti su “Interlude”, i richiami “mellotronici” alla “Mr Kite” beatlesiana in “Sloth” e quel senso di torpore psichedelico à la MGMT, mischiato con l’Albarn più agrodolce, di cui il disco è intriso. I MiceCars sono tornati più disincantati, consapevoli della vita e della loro musica; questa maturazione in A S I M O / I si sente tutta. Attendiamo quindi il secondo capitolo, sempre simbolicamente ispirato al robottino della Honda.
Recensione pubblicata originariamente sul numero di aprile 2014 de Il Mucchio Selvaggio

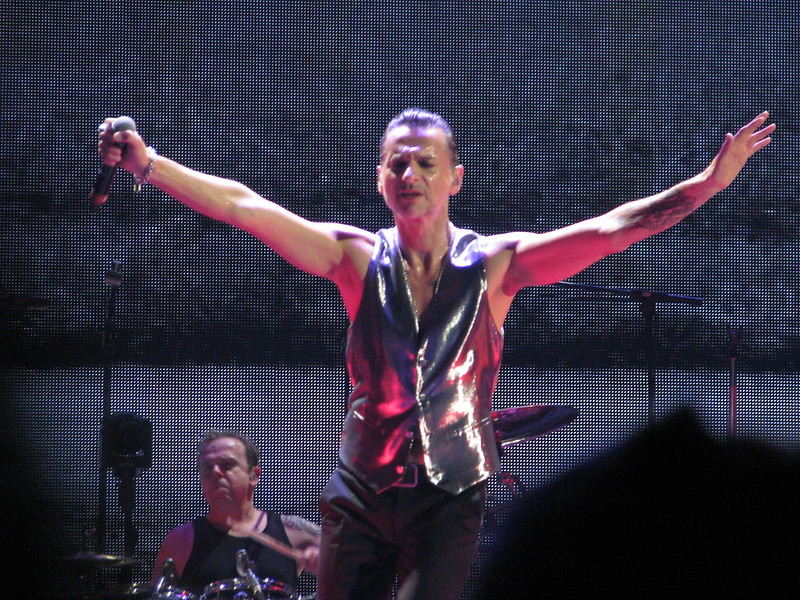


 Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista.
Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista.