Dagli archivi: Scott Walker and Sunn O))) – Soused
Scott Walker and Sunn O))) – Soused (4AD)
8,5
 “Tonight my assistant will pass among you. His cap will be empty. The most intimate, personal choices and requests central to your personal autonomy will be sung”: Soused si chiude con queste parole, contenute in “Lullaby”, già scritta per Ute Lemper. Siamo spettatori paralizzati da uno spettacolo di magia, spesso nerissima, che rapisce i sensi fino a scuoterci nel profondo; sul palco il gran mago Walker e i suoi due assistenti incappucciati. Il trio si sarebbe dovuto già incontrare per Monoliths and Dimensions, ultimo album firmato da Stephen O’Malley e Greg Anderson, che volevano la voce inconfondibile dell’ex pop star per “Alice”. Qualche anno dopo Walker li ha chiamati per arrangiare e suonare questi cinque lunghissimi pezzi che seguono quel gioiello di Bish Bosch.
“Tonight my assistant will pass among you. His cap will be empty. The most intimate, personal choices and requests central to your personal autonomy will be sung”: Soused si chiude con queste parole, contenute in “Lullaby”, già scritta per Ute Lemper. Siamo spettatori paralizzati da uno spettacolo di magia, spesso nerissima, che rapisce i sensi fino a scuoterci nel profondo; sul palco il gran mago Walker e i suoi due assistenti incappucciati. Il trio si sarebbe dovuto già incontrare per Monoliths and Dimensions, ultimo album firmato da Stephen O’Malley e Greg Anderson, che volevano la voce inconfondibile dell’ex pop star per “Alice”. Qualche anno dopo Walker li ha chiamati per arrangiare e suonare questi cinque lunghissimi pezzi che seguono quel gioiello di Bish Bosch.
Il risultato è sorprendente perché Soused contiene la musica più accessibile prodotta negli ultimi anni dai tre. Evitiamo fraintendimenti: questo è un disco minaccioso, oscuro, pesante, violento, difficile, che unisce il lirismo straziante di Scott Walker ai muri di suono e ai rumori dei Sunn O))); come se non bastasse aggiunge alla tavolozza sonora moog, fruste, sveglie digitali, altri suoni indecifrabili ma “reali” e strati di effetti. Tutto è finalizzato a una perfetta costruzione spaziale del suono per un album che unisce la fisicità di un live del duo statunitense all’incredibile perizia che Walker dimostra da anni nello stravolgere e superare il concetto di canzone, dal punto di vista lirico, melodico e armonico. Il contributo dei Sunn O))) è in questo senso perfetto: riveriscono Walker e si adattano alla sua visione artistica, innalzandola e senza compromettersi. Un miracolo? No, semplicemente uno dei dischi più stupefacenti di questo 2014.
Recensione pubblicata originariamente sul numero di dicembre 2014 de Il Mucchio Selvaggio

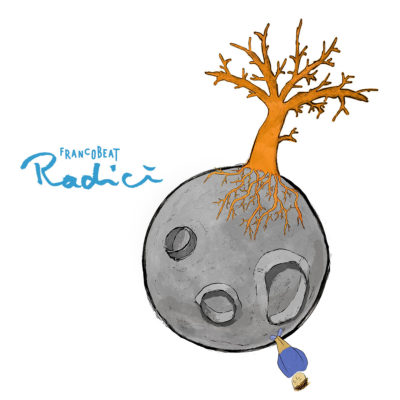 Si chiama “Radici” la comunità per disabili mentali nei pressi di Riccione i cui ospiti hanno scritto i testi del terzo album di Francobeat, nome d’arte di Franco Naddei. Un lavoro di due anni, insieme a John De Le, Sacri Cuori, Giacomo Toni, Santobarbaro e Moro (solo per citare alcuni degli ospiti del disco) per un album che tocca ogni genere e forma musicale, che racconta storie dalla forza rivoluzionaria di quelle narrate da Rodari (intorno a cui era centrato il progetto precedente di Naddei). Il poeta, in una filastrocca, diceva che “il più matto della terra vuole fare la guerra”: ci sembra l’unica definizione di “matto” accettabile, che ben poco si applica agli autori delle liriche di questo album unico, coloratissimo e fantasioso.
Si chiama “Radici” la comunità per disabili mentali nei pressi di Riccione i cui ospiti hanno scritto i testi del terzo album di Francobeat, nome d’arte di Franco Naddei. Un lavoro di due anni, insieme a John De Le, Sacri Cuori, Giacomo Toni, Santobarbaro e Moro (solo per citare alcuni degli ospiti del disco) per un album che tocca ogni genere e forma musicale, che racconta storie dalla forza rivoluzionaria di quelle narrate da Rodari (intorno a cui era centrato il progetto precedente di Naddei). Il poeta, in una filastrocca, diceva che “il più matto della terra vuole fare la guerra”: ci sembra l’unica definizione di “matto” accettabile, che ben poco si applica agli autori delle liriche di questo album unico, coloratissimo e fantasioso.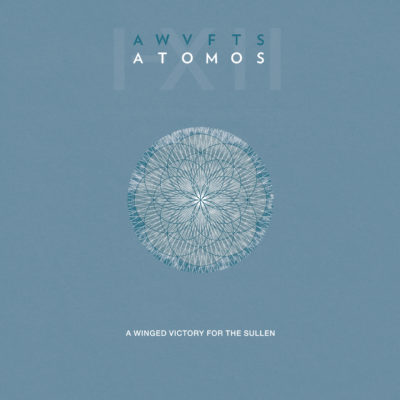 Dustin O’Halloran e Adam Witzie hanno scritto la musica, poi diventata il secondo LP a nome A Winged Victory for the Sullen, per una coreografia del Royal Ballet di Londra, andata in scena un anno fa. Tuttavia Atomos è godibilissimo anche di per sé: undici tracce (da “Atomos I” a “Atomos XII”: sì, manca un numero e nell’interno del cd, ironicamente, si scrive “Whatever Happened to IV”) costruite per lo più su violini, viola, violoncelli, pianoforte e synth modulare, suonato da Francesco Donadello, responsabile anche dell’efficace mixing del disco e di parte delle registrazioni.
Dustin O’Halloran e Adam Witzie hanno scritto la musica, poi diventata il secondo LP a nome A Winged Victory for the Sullen, per una coreografia del Royal Ballet di Londra, andata in scena un anno fa. Tuttavia Atomos è godibilissimo anche di per sé: undici tracce (da “Atomos I” a “Atomos XII”: sì, manca un numero e nell’interno del cd, ironicamente, si scrive “Whatever Happened to IV”) costruite per lo più su violini, viola, violoncelli, pianoforte e synth modulare, suonato da Francesco Donadello, responsabile anche dell’efficace mixing del disco e di parte delle registrazioni.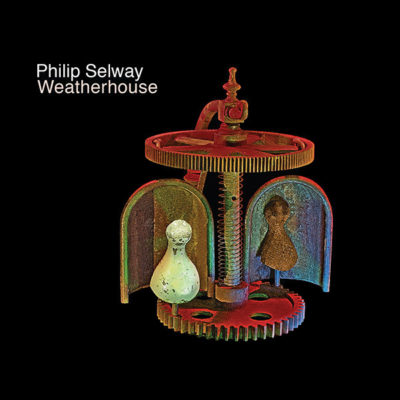 Weatherhouse
Weatherhouse Il secondo disco è sempre difficile: se il primo vince premi ovunque e i suoi brani vengono usati nei promo della BBC; se arriva (dopo l’acclamazione) l’ovvio boomerang critico mentre supera il milione di copie vendute, e se (poco prima dell’inizio del lavoro sulle nuove canzoni) uno dei membri fondatori esce dalla band, ecco che il secondo disco può diventare più che difficile. Eppure gli alt-J rimangono quasi all’altezza del debutto, apertamente richiamato da This Is All Yours.
Il secondo disco è sempre difficile: se il primo vince premi ovunque e i suoi brani vengono usati nei promo della BBC; se arriva (dopo l’acclamazione) l’ovvio boomerang critico mentre supera il milione di copie vendute, e se (poco prima dell’inizio del lavoro sulle nuove canzoni) uno dei membri fondatori esce dalla band, ecco che il secondo disco può diventare più che difficile. Eppure gli alt-J rimangono quasi all’altezza del debutto, apertamente richiamato da This Is All Yours. 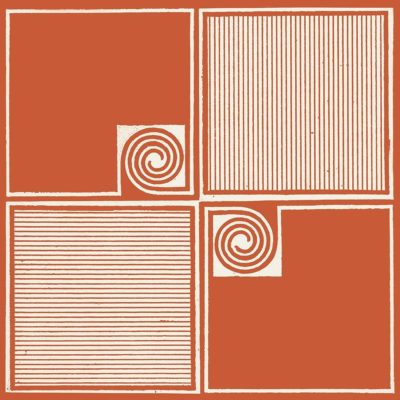 Diciamolo subito: se vi siete crogiolati sull’esordio self-titled di Matthew Correia (batteria), Spencer Dunham (basso), Miles Michaud (voce e chitarra) e Pedrum Siadatian (chitarra), godrete anche dei quaranta minuti di Worship the Sun. Altrimenti, passate oltre: perché la formula è sempre composta da psichedelia 60’s, surf e garage, mischiati a quel suono indolente e rilassato tipico delle band che provengono dalle lande soleggiate della West Coast.
Diciamolo subito: se vi siete crogiolati sull’esordio self-titled di Matthew Correia (batteria), Spencer Dunham (basso), Miles Michaud (voce e chitarra) e Pedrum Siadatian (chitarra), godrete anche dei quaranta minuti di Worship the Sun. Altrimenti, passate oltre: perché la formula è sempre composta da psichedelia 60’s, surf e garage, mischiati a quel suono indolente e rilassato tipico delle band che provengono dalle lande soleggiate della West Coast. Chissà qual è l’“altro linguaggio” che dà il titolo al terzo album in studio del quartetto texano: ad ascoltare le otto tracce di Another Language si potrebbe immaginare che quell’“another” non indichi un’alternativa, ma piuttosto un’aggiunta. I This Will Destroy You, infatti, arricchiscono sonorità e ritmiche dell’ultimo Tunnel Blanket pur rimanendo nell’ambito di un post-rock d’atmosfera che gioca moltissimo con le dinamiche (per descrivere certi passaggi si dovrebbero usare i ppp e i fff della musica classica) e accentuano ancora di più le componenti malinconiche e inquietanti dei lavori precedenti.
Chissà qual è l’“altro linguaggio” che dà il titolo al terzo album in studio del quartetto texano: ad ascoltare le otto tracce di Another Language si potrebbe immaginare che quell’“another” non indichi un’alternativa, ma piuttosto un’aggiunta. I This Will Destroy You, infatti, arricchiscono sonorità e ritmiche dell’ultimo Tunnel Blanket pur rimanendo nell’ambito di un post-rock d’atmosfera che gioca moltissimo con le dinamiche (per descrivere certi passaggi si dovrebbero usare i ppp e i fff della musica classica) e accentuano ancora di più le componenti malinconiche e inquietanti dei lavori precedenti. Il deserto, due synth modulari, due sequencer, un mixer: ecco gli ingredienti di Whorl, registrato nella zona del Joshua Tree in tre giornate dello scorso aprile. Le dodici tracce derivano da due solitarie session live sotto il sole californiano e dal successivo concerto tenuto davanti a novecento persone accorse a uno sperduto locale country&western proprio per sentire in anteprima il nuovo lavoro dei Simian Mobile Disco. Pur continuando a indugiare nei territori ombrosi che battono da un po’, James Ford e Jas Shaw (che hanno abbandonato la Wichita per la Anti-) superano Unpatterns.
Il deserto, due synth modulari, due sequencer, un mixer: ecco gli ingredienti di Whorl, registrato nella zona del Joshua Tree in tre giornate dello scorso aprile. Le dodici tracce derivano da due solitarie session live sotto il sole californiano e dal successivo concerto tenuto davanti a novecento persone accorse a uno sperduto locale country&western proprio per sentire in anteprima il nuovo lavoro dei Simian Mobile Disco. Pur continuando a indugiare nei territori ombrosi che battono da un po’, James Ford e Jas Shaw (che hanno abbandonato la Wichita per la Anti-) superano Unpatterns. “Se la stampa dice che non è quello che si aspettava, be’, l’avete chiesto voi”, ha dichiarato all’NME Sebastien Grainger riferendosi al secondo album dei Death from Above 1979, The Physical World. Ammesso e non concesso di avere domandato a gran voce il ritorno del duo canadese (insieme a Grainger alla batteria e voce c’è Jesse F. Keeler ai synth e basso), dieci anni dopo il debutto You’re a Woman, I’m a Machine: ci meritavamo un disco così? Questa seconda uscita, infatti, ha un problema basilare e non da poco: suona vecchia e stanca, sia considerata nel contesto del panorama odierno, che (soprattutto) messa a confronto col tiro della band di dieci anni fa.
“Se la stampa dice che non è quello che si aspettava, be’, l’avete chiesto voi”, ha dichiarato all’NME Sebastien Grainger riferendosi al secondo album dei Death from Above 1979, The Physical World. Ammesso e non concesso di avere domandato a gran voce il ritorno del duo canadese (insieme a Grainger alla batteria e voce c’è Jesse F. Keeler ai synth e basso), dieci anni dopo il debutto You’re a Woman, I’m a Machine: ci meritavamo un disco così? Questa seconda uscita, infatti, ha un problema basilare e non da poco: suona vecchia e stanca, sia considerata nel contesto del panorama odierno, che (soprattutto) messa a confronto col tiro della band di dieci anni fa. Dopo le collaborazioni con Lloyd Miller e Melvin Van Peebles, splendidi viaggi tra l’Oriente e lo spazio, gli Heliocentrics tornano all’Africa. Qualche anno fa hanno lavorato con Mulatu Astakte, questa volta la trasferta a Londra, negli studi rigorosamente analogici di Malcolm Catto e soci, tocca al grande sassofonista e cantante Orlando Julius (uno dei padri riconosciuti dell’afrobeat), che per Jaiyeide Afro rimette mano ad alcune delle sue prime composizioni, mai registrate prima.
Dopo le collaborazioni con Lloyd Miller e Melvin Van Peebles, splendidi viaggi tra l’Oriente e lo spazio, gli Heliocentrics tornano all’Africa. Qualche anno fa hanno lavorato con Mulatu Astakte, questa volta la trasferta a Londra, negli studi rigorosamente analogici di Malcolm Catto e soci, tocca al grande sassofonista e cantante Orlando Julius (uno dei padri riconosciuti dell’afrobeat), che per Jaiyeide Afro rimette mano ad alcune delle sue prime composizioni, mai registrate prima.