Dagli archivi: The Work of Director (2003)
 Attenzione: leggere questo post vi farà immediatamente spendere un sacco di soldi. Già, perché in questo mondo di ladri, dove si scarica gratis di tutto, esistono ancora dei prodotti che ha senso comprare.
Attenzione: leggere questo post vi farà immediatamente spendere un sacco di soldi. Già, perché in questo mondo di ladri, dove si scarica gratis di tutto, esistono ancora dei prodotti che ha senso comprare.
Qui non stiamo parlando di un DVD che contiene un documentario, no. Qui i DVD sono sette: ognuno di essi è dedicato a un regista. Ma scordatevi, almeno in buona parte, i manuali di storia del cinema. I registi in questione, infatti, hanno principalmente diretto videoclip, tra i più belli di quest’arte che ha qualche decina d’anni di vita.
È il 2003 quando la Palm Pictures fa uscire la prima serie di The Work of Director: i primi tre DVD sono dedicati a Spike Jonze, Chris Cunningham e Michel Gondry. Come mai loro tre? Ehm, perché sono loro a ideare questa collana.
Ogni uscita consiste in un DVD stracolmo di materiale (in media una quindicina di clip, tra video, installazioni, corti e spot televisivi) e in un libretto di una cinquantina di pagine che racconta il mondo del regista in questione, con interviste, riproduzioni di appunti, fotografie e storyboard. In più ci sono speciali, making of, documentari.
Il terzo della prima infornata, quello di Gondry, è particolarmente allettante, considerando soprattutto la ormai lanciata carriera cinematografica del geniale regista francese: chi di voi ha amato Human Nature, Eternal Sunshine e L’arte del sogno, troverà pane per i suoi denti e un film/diario imperdibile. Due anni dopo, la Palm Pictures si ripete: questa volta i nomi sono quelli di Mark Romanek, Jonathan Glazer, Anton Corbijn e Stéphane Sednaoui. La formula, però, non cambia. Libro, video musicali, spot televisivi e altre gustose amenità.
Il consiglio che vi diamo è di prendervi tre ore di tempo e godervi ogni DVD in una volta sola: il perché di questa istigazione alla maratona audiovisiva (che vi ripagherà, ne siamo certi), è presto detta dal titolo stesso della serie.
L’approccio della Palm Pictures a questa enorme e variegata quantità di materiale fondamentalmente di origine commerciale o promozionale è quella di una sorta di politica degli autori, che rivoluziona il modo di concepire i videoclip. Di solito i video musicali sono raccolti per autore, vedi le uscite con i videoclip di Bowie, altre con tutti i video dei Radiohead, eccetera.
Raggruppando però questi prodotti per autore si scopre qualcosa di eccitante: c’è un trait d’union evidente tra le immagini scelte per commentare “Red Guitar” di David Sylvian e quelle di “Liar” di Henry Rollins: la firma di Anton Corbijn, tanto per citare un altro che è passato al cinema.
Le ossessioni di Cunningham si ritrovano tanto dei deliri ritmati dall’electro di Aphex Twin quanto in video raggelanti creati per Madonna e Björk. E ancora, il senso apocalittico di Romanek è visibile nello spot per Levi’s intitolato “Odyssey” quanto nell’insostenibile videoclip per “Rabbit in your headlights” degli U.N.K.L.E.
Per ora i DVD di The Work of the Director si fermano qua: ci sono voci di una possibile terza serie, che comprenda registi nuovi, ma anche aggiornamenti di nomi già esaminati. Tuttavia per ora non vi è nulla di certo. Ora non vi rimane altro che mettere mano alla carta di credito e regalarvi un giorno intero di pura estasi audiovisiva.
Recensione pubblicata originariamente sul blog di Pampero Fundacion Cinema nel gennaio 2011

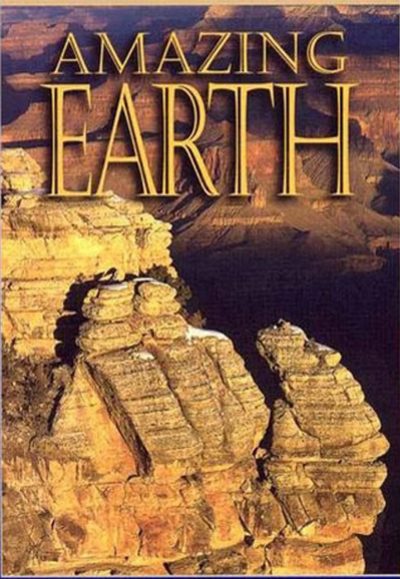 In questo post si parla di Amazing Earth, un documentario per la televisione prodotto nel 1998, diretto da Brian Skilton e con la voce fuori campo di Patrick Stewart. Sì, il professor Xavier di X-Men, il capitano Picard di Star Trek, lui.
In questo post si parla di Amazing Earth, un documentario per la televisione prodotto nel 1998, diretto da Brian Skilton e con la voce fuori campo di Patrick Stewart. Sì, il professor Xavier di X-Men, il capitano Picard di Star Trek, lui. Innanzitutto dividiamo voi lettori in due parti: chi ha visto Il terzo uomo e chi non ha mai visto il capolavoro di Carol Reed del 1949. No, non vale il solo sapere a memoria la famosa frase degli “orologi a cucù” di Orson Welles: è roba da bignami del cinema.
Innanzitutto dividiamo voi lettori in due parti: chi ha visto Il terzo uomo e chi non ha mai visto il capolavoro di Carol Reed del 1949. No, non vale il solo sapere a memoria la famosa frase degli “orologi a cucù” di Orson Welles: è roba da bignami del cinema. A quanto pare, Romina Power si faceva le canne, e se ne faceva pure parecchie.
A quanto pare, Romina Power si faceva le canne, e se ne faceva pure parecchie. Mi parlano spesso di
Mi parlano spesso di  Tutto ciò mi preoccupa in maniera inversamente proporzionale a quanto mi sorprende: non c’è neanche l’idea, molto radicata nella tradizione americana, più che anglosassone in genere, del miglioramento del proprio stato attraverso l’impegno, il lavoro, la dedizione. No: il miglioramento è possibile unicamente se interviene un deus ex machina, che si Xbit o Alessandro Borghese poco importa. Meglio ancora se questo fattore esterno interviene in un ambiente già pieno di soldi.
Tutto ciò mi preoccupa in maniera inversamente proporzionale a quanto mi sorprende: non c’è neanche l’idea, molto radicata nella tradizione americana, più che anglosassone in genere, del miglioramento del proprio stato attraverso l’impegno, il lavoro, la dedizione. No: il miglioramento è possibile unicamente se interviene un deus ex machina, che si Xbit o Alessandro Borghese poco importa. Meglio ancora se questo fattore esterno interviene in un ambiente già pieno di soldi.