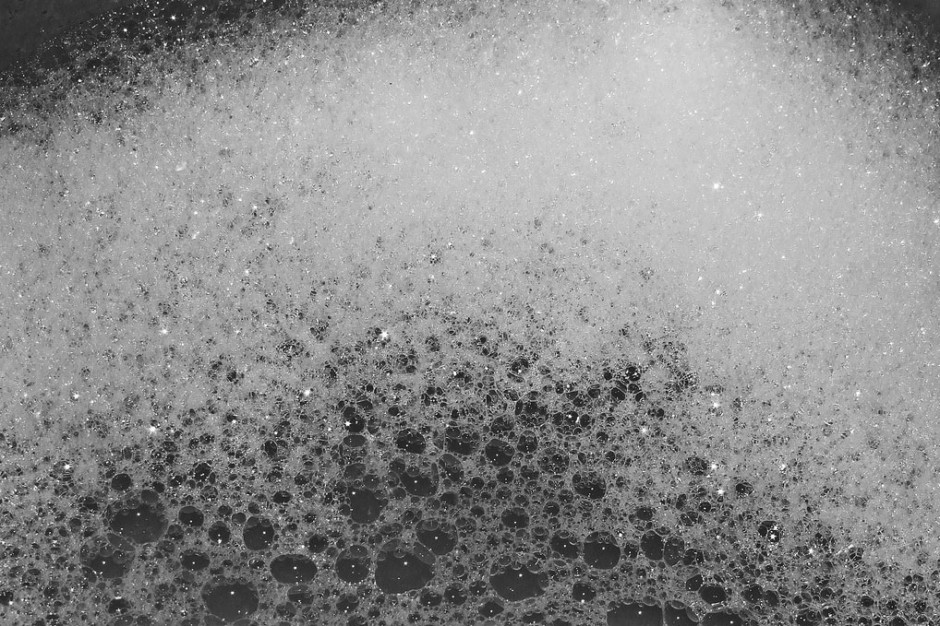Docciaschiuma
Il nuovo docciaschiuma l’ho odorato al supermercato, prima di comprarlo. Ho sentito qualcosa, ma al momento non ho capito.
Poi, alla prima doccia, mi sono reso conto che il bagno sapeva dello studio del mio medico di base. Un luogo di attesa, talvolta sofferente o preoccupata, ma che porta a una persona quasi sempre accogliente e garbata.
Sono andato da lui a luglio, l’ultima volta. Tra le altre cose, mi ha detto “La vita, talvolta, è così”, in modo pacato, calmo, consapevole.
Adesso, quando faccio la doccia, mi sforzo di tornare a quella calma. Cerco di fare stare in silenzio i pensieri e lascio che nella doccia risuoni solamente il mio “trentatré”.