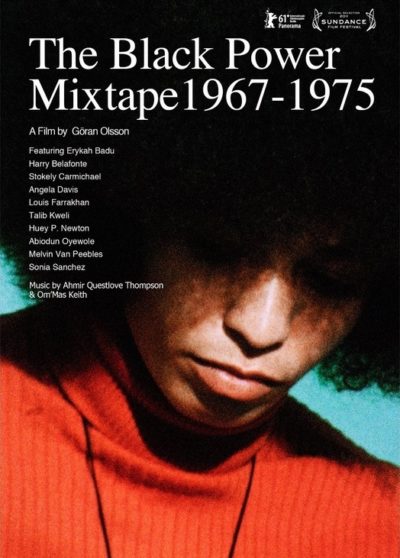 Tra i tanti capitoli da esaminare e riesaminare della storia contemporanea c’è sicuramente quello che ha portato all’emancipazione (almeno sulla carta) della popolazione afroamericana statunitense. Il movimento di liberazione, però, ha avuto tante sfaccettature, spesso in aperta contraddizione tra loro: come spesso capita in ambito storico, è quindi complesso stabilire la verità oggettiva di determinati processi sul lungo periodo o i risvolti e i retroscena di singole azioni dimostrative.
Tra i tanti capitoli da esaminare e riesaminare della storia contemporanea c’è sicuramente quello che ha portato all’emancipazione (almeno sulla carta) della popolazione afroamericana statunitense. Il movimento di liberazione, però, ha avuto tante sfaccettature, spesso in aperta contraddizione tra loro: come spesso capita in ambito storico, è quindi complesso stabilire la verità oggettiva di determinati processi sul lungo periodo o i risvolti e i retroscena di singole azioni dimostrative.
Sicuramente uno dei mezzi che abbiamo per saperne di più è il documentario The Black Power Mixtape 1967-1975, di produzione svedese, presentato all’ultima edizione del Sundance Festival, che nei prossimi giorni verrà proiettato per la prima volta in patria.
Un film svedese per comprendere il Black Power? La prospettiva geografica, oltre che culturale, storica e temporale, aiuta.
È proprio per capire meglio che stava succedendo negli USA alla fine degli anni ’60 che alcuni giornalisti svedesi si recarono negli Stati Uniti per realizzare dei reportage. Il materiale, rimasto proverbialmente nascosto in qualche soffitta, archivio o cantina, è stato riscoperto dal regista e produttore Göran Olsson che l’ha usato come base per questo documentario, organizzato per anno e, come vedremo, con radici ancorate anche nel presente.
Non sono solamente i grandi nomi del movimento a comparire sullo schermo: certo, c’è Angela Davis, ci sono membri delle Pantere Nere, poeti, scrittori e attivisti. Ma in TBPM sentiamo le voci degli abitanti di Harlem, l’Harlem di quegli anni, ben lontana dai processi di riqualificazione urbanistica che l’hanno investita negli ultimi decenni. Sentiamo le voce della base, si direbbe oggi, della comunità di colore, interrogate sui valori e le azioni esposte dai “dirigenti”.
Olsson, però, non dimentica la prospettiva temporale, come si è detto. Fa quindi commentare alcuni estratti e dichiarazioni dagli stessi protagonisti dell’epoca al giorno d’oggi, affiancandoli a nomi preminenti della cultura afroamericana contemporanea, come, ad esempio, Erykah Badu, forse uno dei personaggi più coerenti e convincenti di quello che, un tempo, si sarebbe chiamato panafricanismo. La distanza fa risaltare alcune cose e ne oscura altre: si percepisce la violenza esplicita delle Black Panthers da un lato e il sentimento genuino egualitario dall’altro; si comprende il razzismo all’interno di un processo orrendo e globale che pare non possa avere fine e ci si indigna per la sua costante presenza nella storia dell’uomo. Insomma, si capisce un po’ di più di quello che abbiamo vissuto e che viviamo: per un film non è poco.
Recensione pubblicata originariamente sul blog di Pampero Fundacion Cinema nel marzo 2011

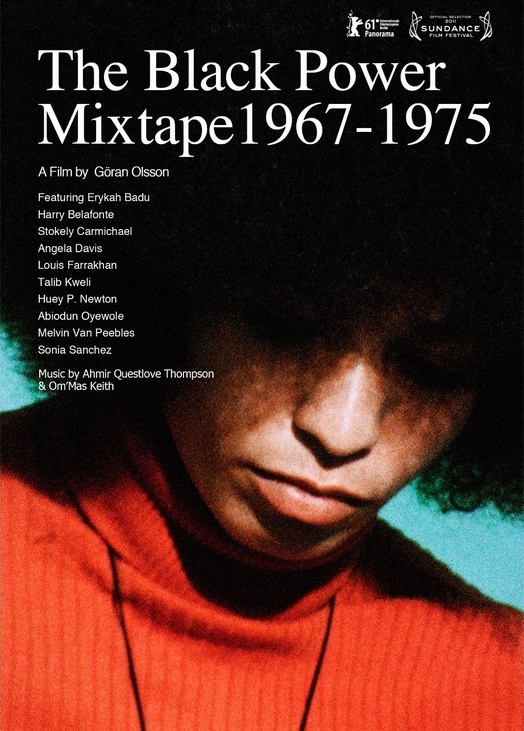
Scrivi un commento