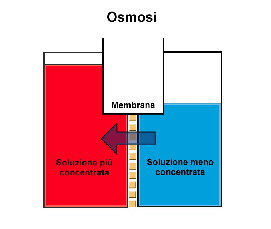Trattamento di fine rapporto

Un’immagine usata per una campagna della Volkswagen può assumere altri sensi oltre che l’imperativo “comprate le nostre auto”
Sul sito di Repubblica si parla dell’ultima indagine di EURES sui suicidi in Italia. I risultati (che possono essere scaricati qua) parlano di un nesso sempre più evidente tra aumento di suicidi (con un’inversione di tendenza rispetto al passato) e crisi economica. Insomma, la gente (soprattutto gli uomini) si uccide per motivi legati alla perdita dell’impiego, sempre di più. Questo dato (provato con cifre e statistiche) segna un ulteriore risultato tangibile di quello che succede in Italia in questo periodo. Ma davvero da questo periodo di crisi bisogna partire, quando si analizzano le relazioni tra un fenomeno di disagio sociale come il suicidio, e uno dei pilastri del vivere sociale, il lavoro, appunto?
Non solo, a mio avviso. Il punto è che è cambiato da tempo il rapporto con il lavoro e con il denaro, nel nostro Paese come in altri. Il meccanismo di creazione di bisogni (assai più antico della crisi economica ma ad esso strettamente legata), intanto, è sfuggito di mano sia da un punto di vista materiale (si produce troppo) sia psicologico, nel senso che è ormai impossibile “stare dietro” a ciò che è lì per essere desiderato. Nessuno, ovviamente, si toglie la vita perché non ha i soldi per l’iPhone, ma di certo alcuni oggetti (nonostante la crisi) continuano a essere venduti e quindi, prima ancora, bramati. Ci si arriva a indebitare, talvolta, per accessori.
Ma non è tutto: è importante pensare anche che si lavora molto di più, o meglio, si è costretti a lavorare più ore per portare a casa uno stipendio decente. Certo, ci si può interrogare su cosa sia il livello di decenza, senza parlare delle “soglie” fissate (ad esempio) dall’ISTAT, ma a prescindere dai bisogni di cui sopra si guadagna meno di prima. Ecco quindi lo scollamento psicologico (e il logoramento fisico) che deriva da un attrito tra desideri, potenzialità e tempo.
La mia storia lavorativa, abbastanza tipica nella sua atipicità, non è più lunga di dodici anni: ciononostante io stesso ho percepito, nel mio piccolo, la frustrazione che deriva (per esempio) dal non vedere raggiunti degli obiettivi minimi di indipendenza economica, sulla quale – a un certo punto, se si ha qualcuno alle spalle – è bene anche passare sopra, proprio per una questione di salute.
E quando mancano alcuni fattori e altri ben più gravi si sommano? Non me la sento di dire che la solitudine (c’è notoriamente una maggiore incidenza di suicidi tra gli uomini separati o vedovi), la mancanza di prospettive, la frustrazione e l’umana debolezza non siano probabilmente ragioni terribilmente sufficienti a uccidersi.