Dagli archivi: Zun Zun Egui – Shackles’ Gift e intervista a Kushal Gaya
Zun Zun Egui – Shackles’ Gift (Bella Union)
7
Altri ascolti raccomandati
Zun Zun Egui – Katang
Melt Yourself Down – S/T
Talking Heads – Fear of Music
 Anche nel secondo disco gli Zun Zun Egui spostano il baricentro della loro musica lontano dall’Europa, pur non dimenticandosi della terra britannica che li ha fatti incontrare. Kushal Gaya (voce e chitarra), Matthew Jones (batteria e percussioni), Yoshino Shigihara (tastiere), e i nuovi acquisti Adam Newton (basso) e Stephen Kerrison (chitarra) riversano nelle nove tracce dell’album tantissime suggestioni, come era accaduto nel primo disco, ma con maggiore maturità e consapevolezza. Da un lato c’è un passo avanti rispetto a Katang (Bella Union, 2011), dall’altro Shackles’ Gift soffre di alcuni momenti di pesantezza.
Anche nel secondo disco gli Zun Zun Egui spostano il baricentro della loro musica lontano dall’Europa, pur non dimenticandosi della terra britannica che li ha fatti incontrare. Kushal Gaya (voce e chitarra), Matthew Jones (batteria e percussioni), Yoshino Shigihara (tastiere), e i nuovi acquisti Adam Newton (basso) e Stephen Kerrison (chitarra) riversano nelle nove tracce dell’album tantissime suggestioni, come era accaduto nel primo disco, ma con maggiore maturità e consapevolezza. Da un lato c’è un passo avanti rispetto a Katang (Bella Union, 2011), dall’altro Shackles’ Gift soffre di alcuni momenti di pesantezza.
Le chitarre sono in primo piano: spesso tendono al noise, con corde tiratissime e suoni distorti appoggiati su ritmiche massicce e serrate, che vagano tra sapori tropicali, quadrature rock e fantasie venate di dub e “irregolarità” africaneggianti. Si sente la mano del produttore Andrew Hung dei Fuck Buttons nell’uso dei tempi e, chiaramente, quando compare l’elettronica (vedi il finale di “The Sweetest Part of Life”). Tuttavia il vero motore della band è il dotatissimo leader Gaya, in prima linea anche nei Melt Yourself Down. Il musicista, nato e cresciuto in Madagascar, ha fatto tesoro della prospettiva unica che si acquista tornando nei luoghi della formazione dopo avere vissuto altrove per diversi anni, nel suo caso tra Londra e Bristol (vedi intervista a pag. XX). La distanza ha permesso di scoprire nuove storie del suo popolo e nuove musiche, prontamente incluse nell’album.
“Soul Scratch” è una canzone seggae, un neonato genere musicale dell’arcipelago tra Africa e Asia che mette insieme la sega (musica popolare mauriziana) e il reggae. “Late Bloomer” è uno degli episodi più trascinanti del disco, dove la matrice tropicale è in primo piano. Tuttavia ci sono episodi decisamente più “occidentali”, come “Ruby” o il secondo singolo “African Tree”, dove, a dispetto del titolo, tornano momenti quasi stoner che facevano parte anche del ricettario dell’esordio.
Il debutto degli Zun Zun Egui, Katang(Bella Union, 2011), è stato uno dei dischi più interessanti usciti di recente. Inclassificabile dal punto dei vista dei generi, mischiava rock, dub, afro, indie con risultati sorprendentemente omogenei e personali: la band portava l’ascoltatore in lande riconosciute e riconoscibili solo in apparenza. Le canzoni erano il risultato di ingredienti noti, ma mischiati in maniera sapiente al fine di dare risultati inediti e freschi. Ecco un aggettivo ambitissimo che la band, originariamente di base a Bristol, può fare suo senza discussioni: un obiettivo raggiunto in maniera assai poco scontata, considerando che la pratica del crossover è ormai comune da tempo nella musica in toto. Eppure gli Zun Zun Egui sono riusciti a mescolare in maniera convincente la musica ascoltata e vissuta dai singoli componenti del gruppo, cosmopolita come non mai. La pratica è stata mantenuta nel nuovo album con qualche abilità in più dettata sicuramente dalla produzione di Andrew Young, metà dei Fuck Buttons, così come dall’esperienza che i musicisti hanno fatto tanto insieme, quanto lavorando ad altri progetti musicali: in particolare il cantante, Kushal Gaya, fa anche parte dei Melt Yourself Down, un altro prodotto musicale di Sua Maestà Elisabetta II, ma che sa di isole britanniche così come di altre terre che i sudditi della Regina hanno raggiunto per mare, visitato e, talvolta, conquistato e soggiogato. Abbiamo parlato del nuovo disco degli Zun Zun Egui proprio con Gaya, nato e cresciuto alle Mauritius, un arcipelago di confine sperduto nell’Oceano, tra Africa e Asia, che, lo vedremo, ha influenzato molto Shackles’ Gift.
Cosa avete fatto tra la fine della promozione di Katang e la registrazione di Shackles’ Gift?
La band ha cambiato parte della formazione e ci è voluto del tempo per scegliere i nuovi membri: volevamo che il gruppo prendesse forma in maniera appropriata. Alla fine abbiamo voluto Adam Newton al basso e Stephen Kerrison alla chitarra. Ora sono membri a tutti gli effetti e scriviamo i pezzi insieme. Siamo persino andati a suonare in Vietnam e alle Mauritius, posti poco comuni per un tour, ma queste esperienze hanno davvero contribuito a plasmare il nuovo disco. Infine, per quanto mi riguarda, sono stato impegnato con i Melt Yourself Down e altri progetti.
Perché avete scelto Andrew Hung dei Fuck Buttons ? Com’è andata?
Tutto è stato abbastanza diretto, naturale. Conosco Andrew di persona, amo la sua musica e andiamo molto d’accordo. Sono stato a un concerto a Brixton, credo che tra gli altri suonasse Luke Abbott, e ho visto Andy: lo conoscevo perché eravamo di spalla ai Fuck Buttons in un tour britannico nel 2009. Abbiamo cominciato a chiacchierare prima del concerto e ci siamo raccontati i piani che avevamo per quell’anno. Ho accennato al fatto che stavamo cercando qualcuno che ci aiutasse a produrre il disco e lui ha immediatamente replicato: “Ci penso io”. Non sapevo neanche che fosse un produttore, ma per qualche ragione mi piaceva tantissimo l’idea che supervisionasse le registrazioni. La sua presenza è davvero bella: è discreto, ma può essere molto diretto in ciò che pensa. Quindi ci siamo incontrati un po’ di volte e questa sensazione positiva si è fatta ancora più forte: alla fine ci siamo detti “Sì, prenotiamo qualche sessione in studio”.
Con quali basi di partenza avete iniziato a lavorare al nuovo disco?
Eravamo alle Mauritius per i concerti a cui ho accennato e, in un giorno libero, ho incontrato questo vecchio pescatore, col quale ho cominciato a parlare della musica del posto. Mi ha raccontato una storia meravigliosa, spiegandomi che una parte della nostra musica locale era stata creata dai lavoratori delle piantagioni ascoltando il rumore che facevano le canne da zucchero nello zuccherificio quando venivano spezzate, e usando il ritmo della fabbrica per una nuova forma di musica. Per me era incredibile: ho vissuto per tanto tempo là, ma non avevo mai saputo nulla di ciò. Ho pensato quindi che si trattasse di una delle più antiche forme di musica industriale… Questo mi ha molto influenzato per dare forma al suono del nuovo disco. Volevamo anche che il disco avesse delle controparti dub e che il tutto fosse molto ritmato. Il nostro scopo era che gli oggetti suonassero come macchine e noi, invece, che apparissimo molto umani. Ci ha aiutato notevolmente in questo un tipo di motore, il Fairbanks Morse Diesel [un motore a due pistoni sviluppato negli anni ’30 e nei decenni immediatamente successivi, montato su sottomarini elettrici e nucleari statunitensi, NdR]. Inoltre, scrivere i testi e avere per le canzoni un punto di partenza diverso da un riff di chitarra sono state sfide sulle quali ho voluto mettermi alla prova. Volevo essere più concentrato e preciso in quello che stavo facendo, e questo processo è ancora in corso: non vedo l’ora di scrivere nuove canzoni!
Il disco suona molto più “British” del precedente: è una scelta conscia?
Davvero? Oh, be’, non so se si tratti di una scelta precisa, non ho mai pensato “Devi suonare più britannico…”. Ormai è tredici anni che vivo nel Regno Unito, quindi penso di avere raccolto, strada facendo, elementi che hanno un suono “British”… Sicuramente da un punto di vista vocale e dei testi. Tre componenti della band sono britannici, quindi era destino che il disco suonasse così. Ma, in fondo, in cosa consiste quest’identità? C’è un tale flusso e movimento nel Paese e specialmente a Londra, dove vivo da due anni e, a essere sincero, la società mista è il pane quotidiano, una cosa bellissima. Non sarei sorpreso se nel futuro il Primo Ministro britannico fosse cinese o indiano: il suonare britannici è qualcosa che si definisce e ridefinisce tutto il tempo, è un processo di improvvisazione infinito.
Ho notato un maggior peso delle chitarre nella composizione delle canzoni, con suoni che talvolta si avvicinano al noise. Cos’è cambiato nei nuovi pezzi da questo punto di vista?
Con Stephen [Kerrison, nuovo acquisto della band, NdR] ci siamo divertiti a lavorare con le chitarre e a fare esperimenti con suoni e grane. Il suo stile è unico e si mescola molto bene con il mio: abbiamo prima pensato di lasciare una chitarra e togliere l’altra, poi di toglierle entrambe, infine di creare più dinamiche e più momenti noise. In questo disco mi sono dedicato meno alle chitarre e più al canto.
Un’altra cosa interessante è l’uso dei pieni e dei vuoti nel disco: si va dalla ricchezza di tanti arrangiamenti al minimalismo del finale. Come avete lavorato in questo senso?
Abbiamo deciso scientemente di creare spazi nel disco, non volevamo un album sempre pieno come il precedente. Penso che questo faccia parte del processo di miglioramento del nostro lavoro e della prospettiva che abbiamo adottato rispetto all’esordio. Molto è stato fatto al momento del missaggio: è lì che ci siamo resi conto che c’era un sacco di roba. Quindi ce ne siamo sbarazzati, sai, semplicemente premendo il tasto “mute” su alcune tracce per vedere come suonavano. Eli Crews, che ha mixato il disco, è stato eccezionale. Gli abbiamo anche dato carta bianca nello sperimentare con i delay tipici del dub e con alcuni effetti: cose che desideravamo da subito! Liberarsi di alcuni elementi e andare all’essenziale è stata una delle esperienze più esaltanti che abbia fatto in vita mia.
Ci sono dei temi che legano i testi del disco?
Sì, l’esplorazione della propria natura e il darle piena voce. Probabilmente il tema ricorrente è il conoscersi. Penso che il disco parli del rivolgere al meglio situazioni nelle quali pensi di essere spacciato. Ha a che fare con la sopravvivenza e con il mantenimento di un lato selvaggio in tutto e tutti. E… c’è anche una canzone d’amore! [ride]
Ancora una volta il disco è anche un bellissimo viaggio tra i generi: ce n’è stato uno su cui Shackles’ Gift si è appoggiato più di altri?
Nella band facciamo tutti rock e, l’hai notato anche tu prima, ci sono un sacco di chitarre pesanti e rumorose. Tuttavia, per quanto mi riguarda, la maloya e la sega, le musiche delle Mauritius, La Réunion, Rodrigues e del Madagascar hanno inciso per sempre la mia pelle e la mia anima, al punto che affiorano comunque, in qualunque cosa sia coinvolto da un punto di vista musicale. C’è anche molto ritmo e un’attitudine dance nei pezzi.
I componenti della band vengono dai quattro angoli del mondo, ma gli Zun Zun Egui nascono a Bristol, una città molto importante, musicalmente parlando, per le commistioni che ha visto nascere. Quanto dovete alla scena musicale cittadina?
Abbiamo tutti deciso di vivere a Bristol, quindi immagino che ognuno di noi le debba qualcosa… Inoltre abbiamo avuto molto sostegno e aiuto dal pubblico e dai promoter della città, dalla Qu Junktions [agenzia musicale di Bristol. NdR], da Fat Paul dell’Exchange e prima ancora da The Croft [locali di musica dal vivo della città, NdR]. Vivendo là, inoltre, sono stato esposto moltissimo alla dance e al dub. Sebbene non siano esattamente i generi che suoniamo, andare a concerti davvero illuminanti e che ci hanno divertito sono stati fattori che ci hanno spinto a decidere di fare la nostra musica. Questo è sicuramente un modo in cui siamo stati aiutati dalla scena musicale di Bristol: se qualcosa ti spinge a creare, a suonare la chitarra e scrivere canzoni, be’, è un aiuto esterno enorme.
Parlando l’anno scorso a Londra con Peter Wareham, prima del live dell’agosto 2013 dei “tuoi” Melt Yourself Down, mi raccontò che lo stimolo per il disco d’esordio era stato l’ascolto di un cd della Rough Trade di world music. Cosa pensi del recente nuovo interesse da parte di musicisti britannici ed europei della musica che arriva da quel continente?
Mi sa che si stanno rendendo conto che c’è qualcosa di diverso al mondo, oltre alla cassa in quattro… Sebbene anche io ami la techno e la musica elettronica, per me è diverso: io guardo alla musica europea da una prospettiva “afro-asiatica”. Ho avuto un rinnovato interesse per la musica europea. Europa e America dominano il mondo, nei termini di prodotti culturali e della loro distribuzione, ma penso che in futuro si sentiranno sempre di più stili musicali europei visti attraverso prismi africani o asiatici. Non solo: penso che presto europei e americani sperimenteranno un cambio nei ritmi e nelle melodie, ma non attraverso qualche orrida fusione. E infine: credo che la musica sia qualcosa di universale e unificante; queste definizioni non fanno altro che cercare di spiegare la naturale evoluzione che il pianeta vive oggi.
Melt Yourself Down
Nati esattamente due anni fa, inglesi, di base a Londra. Due sassofoni, basso, batteria, percussioni ed elettronica. Nel curriculum dei membri della band, nomi come Heliocentrics, Zun Zun Egui, Acoustic Ladyland, Polar Bear, Sons of Kemet, Mulatu Astakte, Hello Skinny, Transglobal Underground. Anche solamente passando in rassegna questa scarna carta di identità è chiaro che i Melt Yourself Down fanno della mescolanza una cifra stilistica. L’ha dimostrato benissimo l’esordio del 2013, un fulminante self-titled da poco ristampato con un bonus disc che contiene un concerto, registrato l’anno scorso alla New Empowering Church di Londra. Ed è proprio nella dimensione live che la band raggiunge il suo massimo: i Melt Yourself Down dal vivo sono una forza mostruosa, nel vero senso del termine. Producono uno spettacolo che parte da strumenti, suoni, elementi noti per portare l’ascoltatore alla meraviglia assoluta, allo stupore di trovarsi di fronte a qualcosa di nuovo e sconosciuto. In questi tempi di rimasticazione continua, una novità. Così come è inusuale il recupero, da parte del leader Peter Wareham, della musica nubiana, appartenente alla cultura di un popolo che sta scomparendo, ma la cui stirpe regnò in Egitto per secoli. Quel tipo di ritmiche e timbri, allargati alla musica nordafricana in senso ampio, è il “germe” che si trova nella decina di canzoni che finora i Melt Yourself Down hanno prodotto. La band ci ha detto che sta registrando il secondo disco: lo attendiamo con ansia.
Contenuti pubblicati originariamente sul numero di gennaio 2015 de Il Mucchio Selvaggio

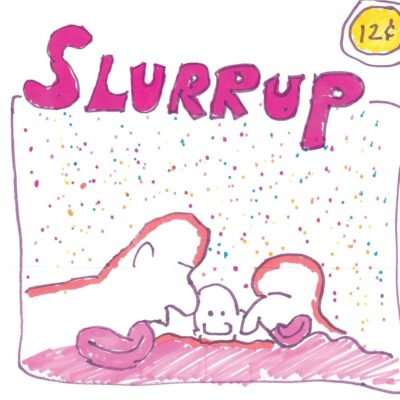 Da vent’anni Liam Hayes sperimenta con il pop e la forma canzone, talvolta aderendo ai suoi canoni, altre volte cercando delle rotture totali con i modelli di riferimento. Lo status di culto ottenuto con il nome d’arte Plush lo ha portato davanti alle macchina da presa (Alta fedeltà) e, recentemente, a scrivere la colonna sonora dell’ultimo film di Roman Coppola.
Da vent’anni Liam Hayes sperimenta con il pop e la forma canzone, talvolta aderendo ai suoi canoni, altre volte cercando delle rotture totali con i modelli di riferimento. Lo status di culto ottenuto con il nome d’arte Plush lo ha portato davanti alle macchina da presa (Alta fedeltà) e, recentemente, a scrivere la colonna sonora dell’ultimo film di Roman Coppola.

 Due tributi diversi, nei modi e nei risultati, per omaggiare due figure mitologiche. Deludente “The Art of McCartney”, prodotto da Ralph Sall, in cui una trentina di musicisti si cimentano con una selezione di successi di Macca, dai Beatles agli anni recenti. La scaletta è scontata, ma maggiormente preoccupante è che due terzi delle canzoni sembrino una sorta di karaoke di lusso, più divertente sulla carta (“Ehi, Alice Cooper canta Eleanor Rigby…”), che nei fatti (“… uguale all’originale”). Compare ogni tanto un barlume di interesse, non tanto negli arrangiamenti, per lo più pedissequamente filologici, quanto nelle interpretazioni vocali: il meglio arriva sul finale con le ruvidezze di Alain Touissant e Dr John, e le tinte black di Dion e B. B. King, a ricordarci quanto certi suoni abbiano educato i quattro di Liverpool. C’è anche Bob Dylan, che rifà (abbastanza svogliatamente) You’ve Got to Hide Your Love Away, pubblicata in origine esattamente un anno dopo il suo primo incontro con i Beatles.
Due tributi diversi, nei modi e nei risultati, per omaggiare due figure mitologiche. Deludente “The Art of McCartney”, prodotto da Ralph Sall, in cui una trentina di musicisti si cimentano con una selezione di successi di Macca, dai Beatles agli anni recenti. La scaletta è scontata, ma maggiormente preoccupante è che due terzi delle canzoni sembrino una sorta di karaoke di lusso, più divertente sulla carta (“Ehi, Alice Cooper canta Eleanor Rigby…”), che nei fatti (“… uguale all’originale”). Compare ogni tanto un barlume di interesse, non tanto negli arrangiamenti, per lo più pedissequamente filologici, quanto nelle interpretazioni vocali: il meglio arriva sul finale con le ruvidezze di Alain Touissant e Dr John, e le tinte black di Dion e B. B. King, a ricordarci quanto certi suoni abbiano educato i quattro di Liverpool. C’è anche Bob Dylan, che rifà (abbastanza svogliatamente) You’ve Got to Hide Your Love Away, pubblicata in origine esattamente un anno dopo il suo primo incontro con i Beatles. Il legame tra i due titoli di cui parliamo finisce qua; infatti “Lost on the River” è la messa in musica di alcuni testi scritti da Dylan coevi ai Basement Tapes, al buen retiro tra Woodstock e dintorni del 1967. I manoscritti sono stati consegnati dal loro autore a T-Bone Burnett, che ha preso in mano il progetto come produttore. Insieme a lui, nientepopodimeno che Elvis Costello, Jim James (My Morning Jacket), Marcus Mumford (Mumford & Sons), Rhiannon Giddens (Carolina Chocolate Drops), Taylor Goldsmith (Dawes) e un cameo alla chitarra di Johnny Depp. Il risultato è piacevole, non sorprendente, ma con un pugno di canzoni che colpiscono, soprattutto quando è Costello a cantare i versi (musicalmente efficacissimi) perduti e ritrovati.
Il legame tra i due titoli di cui parliamo finisce qua; infatti “Lost on the River” è la messa in musica di alcuni testi scritti da Dylan coevi ai Basement Tapes, al buen retiro tra Woodstock e dintorni del 1967. I manoscritti sono stati consegnati dal loro autore a T-Bone Burnett, che ha preso in mano il progetto come produttore. Insieme a lui, nientepopodimeno che Elvis Costello, Jim James (My Morning Jacket), Marcus Mumford (Mumford & Sons), Rhiannon Giddens (Carolina Chocolate Drops), Taylor Goldsmith (Dawes) e un cameo alla chitarra di Johnny Depp. Il risultato è piacevole, non sorprendente, ma con un pugno di canzoni che colpiscono, soprattutto quando è Costello a cantare i versi (musicalmente efficacissimi) perduti e ritrovati. “LAMENT”, ammoniscono le note del disco, è la documentazione di un’installazione-spettacolo legata ai temi della Prima Guerra Mondiale messa in scena in Belgio in questi primi giorni di novembre. Tuttavia, anche “solo” ascoltata, l’ultima pubblicazione dei tedeschi travolge da subito per la potenza espressiva: Kriegsmachinerie, “La macchina della guerra” è un fragore metallico crescente, puro rumorismo Neubauten, sì, ma anche la “corrispondenza sonora” dell’aumento di spesa per gli armamenti dei Paesi poco prima dell’inizio delle carneficine.
“LAMENT”, ammoniscono le note del disco, è la documentazione di un’installazione-spettacolo legata ai temi della Prima Guerra Mondiale messa in scena in Belgio in questi primi giorni di novembre. Tuttavia, anche “solo” ascoltata, l’ultima pubblicazione dei tedeschi travolge da subito per la potenza espressiva: Kriegsmachinerie, “La macchina della guerra” è un fragore metallico crescente, puro rumorismo Neubauten, sì, ma anche la “corrispondenza sonora” dell’aumento di spesa per gli armamenti dei Paesi poco prima dell’inizio delle carneficine. Tranquilli, potete ascoltare questo disco con la famiglia riunita intorno all’albero: neanche alla fine, quando un pianoforte accenna a “Jingle Bells”, qualcuno viene mandato a quel paese. Il titolo del disco di Natale di Mark Kozelek (Sings Christmas Carols), è veritiero: si va da “O Christmas Tree” a “Silent Night”, arrangiate quasi tutte per chitarra e voce, con il canto inconfondibile del musicista, ma senza deviazioni sostanziali dagli originali. “Tra tutti i Kozelek del mondo, tu sei il più Kozelek di tutti, Mark”, si sente in una cover tratta da uno speciale natalizio dei Peanuts. Una briciola di ironia, forse l’ultima che il musicista ha da spendere, dopo l’acrimonia sparsa generosamente negli ultimi mesi. A Natale siamo tutti più buoni?
Tranquilli, potete ascoltare questo disco con la famiglia riunita intorno all’albero: neanche alla fine, quando un pianoforte accenna a “Jingle Bells”, qualcuno viene mandato a quel paese. Il titolo del disco di Natale di Mark Kozelek (Sings Christmas Carols), è veritiero: si va da “O Christmas Tree” a “Silent Night”, arrangiate quasi tutte per chitarra e voce, con il canto inconfondibile del musicista, ma senza deviazioni sostanziali dagli originali. “Tra tutti i Kozelek del mondo, tu sei il più Kozelek di tutti, Mark”, si sente in una cover tratta da uno speciale natalizio dei Peanuts. Una briciola di ironia, forse l’ultima che il musicista ha da spendere, dopo l’acrimonia sparsa generosamente negli ultimi mesi. A Natale siamo tutti più buoni? Il quarto LP dei Twilight Sad arriva dopo un anno in cui il cantante e autore dei testi James Graham si è trovato nel tipico momento di riflessione, con annesse domande esistenziali: il “fermarsi per ritrovarsi” si è concretizzato in questo “Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave”, registrato negli studi dei Mogwai. L’idea era quella di rappresentare le anime musicali espresse in dieci anni di carriera su disco e dal vivo: ecco quindi le scelte di autoprodursi, di usare anche in studio il fonico live Andrew Bush e di affidare il missaggio a Peter Katis, come era accaduto per il debutto “Fourteen Autumns & Fifteen Winters”.
Il quarto LP dei Twilight Sad arriva dopo un anno in cui il cantante e autore dei testi James Graham si è trovato nel tipico momento di riflessione, con annesse domande esistenziali: il “fermarsi per ritrovarsi” si è concretizzato in questo “Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave”, registrato negli studi dei Mogwai. L’idea era quella di rappresentare le anime musicali espresse in dieci anni di carriera su disco e dal vivo: ecco quindi le scelte di autoprodursi, di usare anche in studio il fonico live Andrew Bush e di affidare il missaggio a Peter Katis, come era accaduto per il debutto “Fourteen Autumns & Fifteen Winters”. I membri della band disegnati di tre quarti, nello stile iconografico sovietico; intorno, pugni chiusi, raggi di sol dell’avvenir e… l’Atomium, il Manneken-Pis, birra, galli, cozze e patatine fritte. La copertina di The Belgians riassume lo spirito del quarto album del trio di Liegi: Dirty Coq e Boogie Snake (chitarre e voci) e Devil D’Inferno (batteria) costruiscono un disco a tema sul loro popolo: si comincia, come da copione, con l’inno nazionale (“La Brabançonne”) stravolto da elettricità e distorsioni (ma non siamo dalle parti dell’illustre precedente hendrixiano), si finisce con la cupa ed elettronica “Belgians Don’t Cry”. In mezzo canzoni che, tra rock’n’roll, garage e surf, parlano (male) del Paese “grande quanto un coriandolo” (cito dal comunicato stampa) e dei suoi abitanti.
I membri della band disegnati di tre quarti, nello stile iconografico sovietico; intorno, pugni chiusi, raggi di sol dell’avvenir e… l’Atomium, il Manneken-Pis, birra, galli, cozze e patatine fritte. La copertina di The Belgians riassume lo spirito del quarto album del trio di Liegi: Dirty Coq e Boogie Snake (chitarre e voci) e Devil D’Inferno (batteria) costruiscono un disco a tema sul loro popolo: si comincia, come da copione, con l’inno nazionale (“La Brabançonne”) stravolto da elettricità e distorsioni (ma non siamo dalle parti dell’illustre precedente hendrixiano), si finisce con la cupa ed elettronica “Belgians Don’t Cry”. In mezzo canzoni che, tra rock’n’roll, garage e surf, parlano (male) del Paese “grande quanto un coriandolo” (cito dal comunicato stampa) e dei suoi abitanti.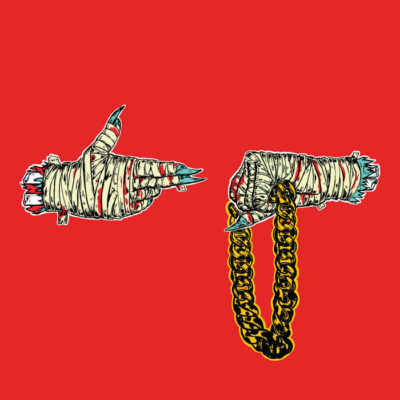 Il punto non è il cosa, ma il come. Già, perché
Il punto non è il cosa, ma il come. Già, perché  “
“