Dagli archivi: Damo Suzuki: “Faccio la musica dell’oggi”
 Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista.
Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista.
Ti conoscono tutti come il cantante dei Can, ma ormai sono passati 35 anni da quell’esperienza, quindi parliamo del presente, del Damo Suzuki Network. Di che si tratta?
Per lavoro viaggio in tanti Paesi del mondo e cerco volta per volta, nello spazio e nel tempo in cui sono, di creare qualcosa con i “sound carrier locali”. Sono musicisti, ma io li chiamo “sound carrier” [“portatori di suono”, ndr] perché “musicista” è una parola vecchia, perché negli ultimi venti-trent’anni tutto è cambiato nel panorama musicale e noise. Suono ovunque, incontro persone senza fare prove, faccio la musica dell’oggi. Funziona, non è mai noioso perché ogni giorno posso fare cose diverse e incontro persone dalle mentalità molto diverse tra loro. Insomma, il menù del giorno cambia sempre.
Si tratta di improvvisazioni?
Non proprio, non mi piace tanto quella parola. Sì, è una specie di improvvisazione, ma il termine è utilizzato soprattutto dai musicisti jazz, e nel jazz, anche quando si improvvisa, non si fa davvero musica sul momento. Perché comunque nel jazz ci sono strutture definite, i solisti… Ognuno di noi, invece, fa nello stesso momento cose diverse.
Cosa succede quando, suonando, accade qualcosa di talmente bello e particolare che ti va di ripeterlo?
Di solito non ripeto nulla perché ogni volta ho a che fare con musicisti diversi. E poi ripetere significa copiare se stessi: non è proprio cosa per me.
In quanti Paesi diversi sei stato con il tuo progetto e che musicisti hai incontrato?
Non tanti, forse 27 Paesi diversi, e ho suonato con musicisti di ogni tipo: free jazz, hip hop, bande di ottoni…
Com’è stato suonare con gli Zu?
Gli Zu hanno un’energia incredibile ed è la cosa che davvero mi piace di loro. Anche nei miei concerti c’è molta energia, la condivido con il pubblico e me ne torno a casa con una bella sensazione.
Ci sono artisti o dischi interessanti che hai ascoltato di recente?
È una domanda difficile, perché per me ogni sound carrier che suona con me è interessante.
I sound carrier sono molto orgogliosi di suonare con te…
E io lo sono di suonare con loro, perché è davvero speciale. Prima di cominciare a suonare non ci conosciamo di persona e poi comunichiamo con la musica, è molto bello. Per comunicare non mi serve imparare l’italiano, una lingua per molto difficile: con la musica comunico ovunque. Ed è anche un motivo per cui porto avanti questo progetto: voglio usare la musica come arma contro ogni tipo di violenza. In questo mondo c’è molta violenza perché le persone non comunicano tra loro e la musica permette di farlo anche meglio [che con le parole].
Ci hai parlato della diversità dei Paesi che visiti e dei musicisti con cui suoni, ma che mi dici del pubblico?
Ti faccio un esempio: lo scorso aprile [2007, ndr] ho suonato a Londra con un quartetto d’archi, con musicisti classici, in un posto dove almeno l’80 per cento del pubblico era composto da appassionati di classica. Per me è stata un’esperienza interessantissima e la reazione del pubblico è stata magnifica: c’è stata una standing ovation e abbiamo fatto due parti, la prima da due pezzi, per un totale di 45 minuti e la seconda con un pezzo solo da 77 minuti.
Intervista andata in onda originariamente in diretta su Radio Città del Capo di Bologna il 18 gennaio 2008

 Quasi vent’anni fa pubblicavo sul blog
Quasi vent’anni fa pubblicavo sul blog  Ogni volta che riascolto dall’inizio alla fine l’ultimo disco dei Thee Silver Mt. Zion ho una reazione fisica: un brivido che sale per scoppiare puntuale intorno al secondo minuto e mezzo della penultima traccia, “
Ogni volta che riascolto dall’inizio alla fine l’ultimo disco dei Thee Silver Mt. Zion ho una reazione fisica: un brivido che sale per scoppiare puntuale intorno al secondo minuto e mezzo della penultima traccia, “
 Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”.
Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”. Una delle band più importanti e influenti della storia dell’hardcore celebra nel 2011 due anniversari: trentacinque anni dalla fondazione e dieci dallo scioglimento. Stiamo parlando dei Black Flag, che nel lasso intercorso tra il 1976 e il 1986 diedero davvero una spinta notevolissima all’undereground culturale statunitense e non solo.
Una delle band più importanti e influenti della storia dell’hardcore celebra nel 2011 due anniversari: trentacinque anni dalla fondazione e dieci dallo scioglimento. Stiamo parlando dei Black Flag, che nel lasso intercorso tra il 1976 e il 1986 diedero davvero una spinta notevolissima all’undereground culturale statunitense e non solo.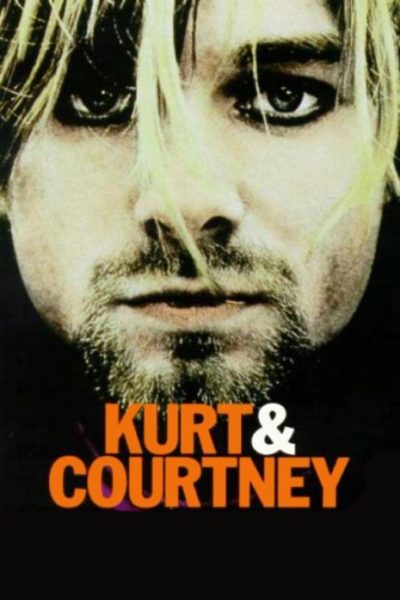 Il regista e giornalista inglese Nick Broomfield ha diretto nel 1998 Kurt and Courtney. Stimolato dai misteri legati alla fine del leader dei Nirvana, Broomfield va per conto della BBC negli Stati Uniti occidentali, tra California e Washington, per capire che è successo davvero. Vorrebbe, ovviamente, intervistare Courtney Love, che per un periodo diventò una sorta di “Yoko Ono” perversa e distruttiva. Tutti la descrivono, nel documentario, come una persona orrenda: o meglio, Broomfield non ci mostra nessuno che la difenda, neanche il padre della musicista. La “sottotrama” del film è legata alle difficoltà finanziarie della produzione, che vanno di pari passo con la pressione che l’entourage della moglie di Cobain esercita sulla creazione del documentario. Broomfield intervista una serie di personaggi grotteschi, da Dylan Carlson degli Earth all’ultima babysitter che si è presa cura della figlioletta della coppia prima di quel tragico giorno dell’aprile del 1994. La parata di strani figuri fa pensare una cosa certa allo spettatore: qualcosa di strano sotto l’apparente suicidio di Cobain c’è. Broomfield ci lascia quindi con alcuni momenti struggenti, legati ai ricordi e ai cimeli della zia di Kurt, con qualche dubbio e con nessuna prova, se non quelle terribili coincidenze che hanno portato molte persone a fare delle congetture sulla scomparsa di Cobain. Si respira il clima cospiratorio di quegli anni, che però oggi pare lontano.
Il regista e giornalista inglese Nick Broomfield ha diretto nel 1998 Kurt and Courtney. Stimolato dai misteri legati alla fine del leader dei Nirvana, Broomfield va per conto della BBC negli Stati Uniti occidentali, tra California e Washington, per capire che è successo davvero. Vorrebbe, ovviamente, intervistare Courtney Love, che per un periodo diventò una sorta di “Yoko Ono” perversa e distruttiva. Tutti la descrivono, nel documentario, come una persona orrenda: o meglio, Broomfield non ci mostra nessuno che la difenda, neanche il padre della musicista. La “sottotrama” del film è legata alle difficoltà finanziarie della produzione, che vanno di pari passo con la pressione che l’entourage della moglie di Cobain esercita sulla creazione del documentario. Broomfield intervista una serie di personaggi grotteschi, da Dylan Carlson degli Earth all’ultima babysitter che si è presa cura della figlioletta della coppia prima di quel tragico giorno dell’aprile del 1994. La parata di strani figuri fa pensare una cosa certa allo spettatore: qualcosa di strano sotto l’apparente suicidio di Cobain c’è. Broomfield ci lascia quindi con alcuni momenti struggenti, legati ai ricordi e ai cimeli della zia di Kurt, con qualche dubbio e con nessuna prova, se non quelle terribili coincidenze che hanno portato molte persone a fare delle congetture sulla scomparsa di Cobain. Si respira il clima cospiratorio di quegli anni, che però oggi pare lontano. Nel 2004, invece, nel decennale della morte, esce il cofanetto With the Lights Out: in tre cd e un dvd si mette in luce il lato inedito della musica dei Nirvana. Cobain, ovviamente, domina la scena, ma è la musica che sta al centro del progetto. Il dvd, in particolare, è realmente emozionante: comprende video amatoriali e non girati tra il 1988 e il 2003. In quindici anni Cobain, nonostante tutto, è sorprendentemente costante. Certo, nelle prime prove filmate a casa della madre del bassista Novoselic, il ventunenne biondo è timido al punto tale da suonare e cantare rivolto al muro, spalle alla camera. In fondo Kurt è ancora in un momento di incertezza e crisi che dura da quando, a otto anni, i suoi hanno divorziato: da quel momento la sua vita è andata a rotoli sempre, dal punto di vista emotivo. Sempre nel dvd ci sono altri momenti eccezionali: uno su tutti è la prima esecuzione dal vivo di “Smells Like Teen Spirit”, una canzone che come poche altre segna gli anni ’90 e quelli a venire. Il live è dell’aprile del 1991, cinque mesi prima dell’uscita di Nevermind e della consacrazione planetaria della band.
Nel 2004, invece, nel decennale della morte, esce il cofanetto With the Lights Out: in tre cd e un dvd si mette in luce il lato inedito della musica dei Nirvana. Cobain, ovviamente, domina la scena, ma è la musica che sta al centro del progetto. Il dvd, in particolare, è realmente emozionante: comprende video amatoriali e non girati tra il 1988 e il 2003. In quindici anni Cobain, nonostante tutto, è sorprendentemente costante. Certo, nelle prime prove filmate a casa della madre del bassista Novoselic, il ventunenne biondo è timido al punto tale da suonare e cantare rivolto al muro, spalle alla camera. In fondo Kurt è ancora in un momento di incertezza e crisi che dura da quando, a otto anni, i suoi hanno divorziato: da quel momento la sua vita è andata a rotoli sempre, dal punto di vista emotivo. Sempre nel dvd ci sono altri momenti eccezionali: uno su tutti è la prima esecuzione dal vivo di “Smells Like Teen Spirit”, una canzone che come poche altre segna gli anni ’90 e quelli a venire. Il live è dell’aprile del 1991, cinque mesi prima dell’uscita di Nevermind e della consacrazione planetaria della band.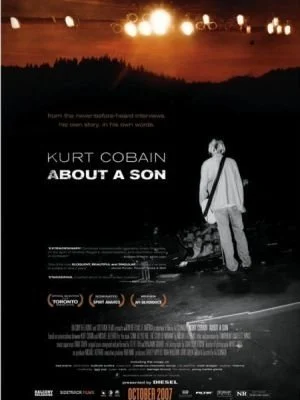 Infine, Kurt Cobain: about a son. Diretto da A.J. Schnack nel 2006, è un documentario bellissimo. Oltre un’ora e mezza fatta solo di volti di abitanti delle zone di Aberdeen e Olympia, foto di concerti dell’epoca (soprattutto di altre band), paesaggi squallidi o incantevoli, traffico e periferie, diner e officine meccaniche. Tutto è commentato dalla voce di Cobain, tratta dalle registrazioni di numerose telefonate fatte dal giornalista Michael Azerrad per il libro Come as you are, tuttora considerato uno dei più belli in assoluto sui Nirvana. Le parole di Cobain, talvolta pronunciate con voce un po’ assente, o con la bocca piena, si intrecciano meravigliosamente con una colonna sonora più che notevole, formata dalle canzoni e dalle band che Kurt amava di più. Dai Vaselines ai Melvins, dagli Young Marble Giants ai Mudhoney. “Songs from the era”, si direbbe: una scelta azzeccatissima per un documentario che, non a caso è intitolato quasi come una canzone dei Nirvana. Schnack si sofferma molto sull’infanzia, vero snodo cruciale dello sviluppo emotivo di chiunque, Cobain compreso. Proprio lui continua a dirlo, nel corso del film: sono uno qualunque. Ma non si tratta di modestia. Sembra più una richiesta d’aiuto, di considerazione. Non pone tesi, About a son: racconta la storia di un personaggio, iconico suo malgrado, in maniera affascinante e originale, quasi astratta, abbracciando le contraddizioni di un grande artista così come la sua musica. Un ritratto commovente, consigliato a chi volesse tentare di conoscere, forse senza poterlo capire fino in fondo, Kurt Cobain.
Infine, Kurt Cobain: about a son. Diretto da A.J. Schnack nel 2006, è un documentario bellissimo. Oltre un’ora e mezza fatta solo di volti di abitanti delle zone di Aberdeen e Olympia, foto di concerti dell’epoca (soprattutto di altre band), paesaggi squallidi o incantevoli, traffico e periferie, diner e officine meccaniche. Tutto è commentato dalla voce di Cobain, tratta dalle registrazioni di numerose telefonate fatte dal giornalista Michael Azerrad per il libro Come as you are, tuttora considerato uno dei più belli in assoluto sui Nirvana. Le parole di Cobain, talvolta pronunciate con voce un po’ assente, o con la bocca piena, si intrecciano meravigliosamente con una colonna sonora più che notevole, formata dalle canzoni e dalle band che Kurt amava di più. Dai Vaselines ai Melvins, dagli Young Marble Giants ai Mudhoney. “Songs from the era”, si direbbe: una scelta azzeccatissima per un documentario che, non a caso è intitolato quasi come una canzone dei Nirvana. Schnack si sofferma molto sull’infanzia, vero snodo cruciale dello sviluppo emotivo di chiunque, Cobain compreso. Proprio lui continua a dirlo, nel corso del film: sono uno qualunque. Ma non si tratta di modestia. Sembra più una richiesta d’aiuto, di considerazione. Non pone tesi, About a son: racconta la storia di un personaggio, iconico suo malgrado, in maniera affascinante e originale, quasi astratta, abbracciando le contraddizioni di un grande artista così come la sua musica. Un ritratto commovente, consigliato a chi volesse tentare di conoscere, forse senza poterlo capire fino in fondo, Kurt Cobain. Look up here, I’m in heaven
Look up here, I’m in heaven






