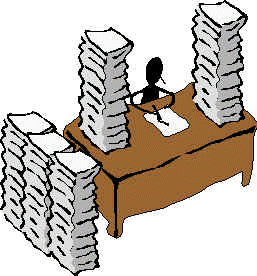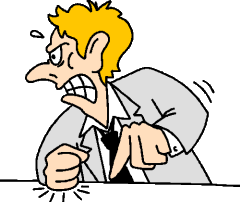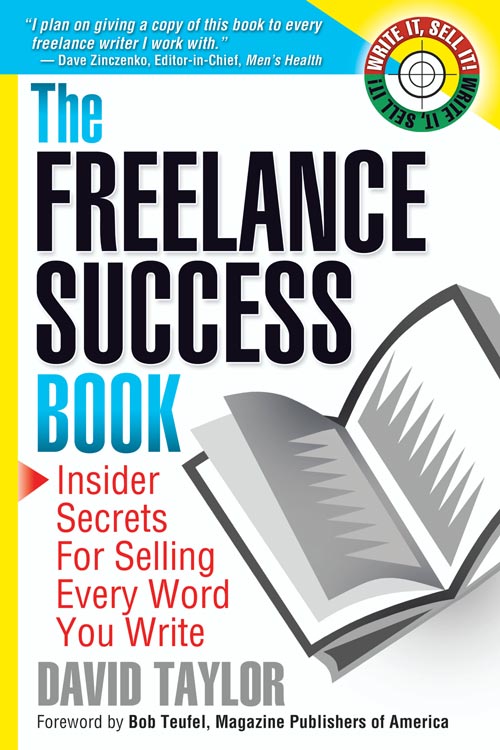I giornalisti preferiscono i biondini
Ma, nell’ultimo caso di stupro balzato agli onori della cronaca, quello del parco della Caffarella a Roma, uno degli accusati viene ormai chiamato “il biondino”.Sono i momenti in cui mi vergogno profondamente di fare parte dell’Ordine dei giornalisti. Che schifo.