Tutta l'erba del fascio
 Fini: “Una volta ho provato uno spinello e sono rimasto rimbecillito per due giorni” (da Repubblica.it)
Fini: “Una volta ho provato uno spinello e sono rimasto rimbecillito per due giorni” (da Repubblica.it)
È perché te lo sei iniettato, Gianfranco.
 Fini: “Una volta ho provato uno spinello e sono rimasto rimbecillito per due giorni” (da Repubblica.it)
Fini: “Una volta ho provato uno spinello e sono rimasto rimbecillito per due giorni” (da Repubblica.it)
È perché te lo sei iniettato, Gianfranco.
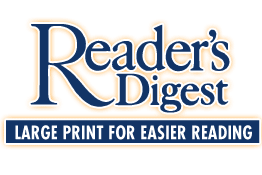 Una volta tanto faccio anche io il weblogger (ops!) e indico una serie di link, tra l’interessante, il fondamentale e il “non ho proprio niente da fare: che faccio?”, a risorse trovate in rete, in altri blog-che-ora-non-ricordo, eccetera.
Una volta tanto faccio anche io il weblogger (ops!) e indico una serie di link, tra l’interessante, il fondamentale e il “non ho proprio niente da fare: che faccio?”, a risorse trovate in rete, in altri blog-che-ora-non-ricordo, eccetera.
Prima di tutto andate qui e firmate per una nuova proposta di legge sulla destinazione dell’otto per mille. Perché non darlo alla ricerca, invece che a qualche aggregazione religiosa o allo Stato? Per come stanno le cose in Italia, soprattutto nel campo della ricerca, è assolutamente vitale. Andate e firmate.
La telefonia VOIP (Voice Over IP, cioè via Internet), per quanto decantata da tutti, non mi ha mai convinto. Quando qualcosa è gratis, secondo me, c’è qualcosa sotto. E poi come si fa a provare la qualità del collegamento se la lista-amici di Skype è vuota? Provate a scaricare, quindi, VoipStunt. Potete chiamare tutti i numeri fissi di molti paesi a gratis (almeno per un po’) e pagate solo le telefonate ai cellulari. Il trucco, sicuramente, c’è o ci sarà, ma per ora… (Se anche la vostra rubrica è vuota, fate scherzi telefonici, che vi devo dire. Del resto, cosa non si fa per ammazzare il tempo…)
Non l’ho ancora finito di leggere Generazione 1000 euro. È un romanzo scritto a quattro mani sul solito co.co qualcosa che deve trovare il modo di sfangarla e arrivare a fine mese. Per ora sospendo il giudizio. Fatemi sapere che ne pensate, se l’avete letto.
E infine, Pandora. Ne parlano tutti, e lo sto provando mentre scrivo questo post. Praticamente è una radio via web, che, secondo i suoi creatori, dovrebbe fare scoprire dei gruppi che suonano in maniera simile a band che già si conoscono. Io ho provato mettendo i Nine Inch Nails. Il pezzo successivo era “One Vision” dei Queen. “Ehi, le ritmiche sono le stesse”, mi ha rassicurato Pandora. Poi mi ha proposto Rob Zombie, poi Marylin Manson, poi i Nine Inch Nails di nuovo.
Adesso provo con Alberto Fortis.
Buon fine settimana a tutti.
 Questo post trae fiducia e ispirazione da un commento al post sotto, in cui Gianluca parla dell’intervista che ho fatto a Luttazzi, e critica le ragioni che l’hanno portato a chiudere il suo blog. Prima di tutto, è meglio che dica che l’intervista a Luttazzi non doveva, in origine, toccare altro argomento se non il suo spettacolo, come da accordi con il suo ufficio stampa. E inoltre aggiungo che non mi interessava gran che chiedergli del blog. Detto questo, riprendo il commento di Gianluca, che mi sembra interessante, e parlo qui (credo per la prima volta, dopo averlo fatto in un paio di occasioni in pubblico) di alcune cose che riguardano il mezzo stesso su cui sto scrivendo.
Questo post trae fiducia e ispirazione da un commento al post sotto, in cui Gianluca parla dell’intervista che ho fatto a Luttazzi, e critica le ragioni che l’hanno portato a chiudere il suo blog. Prima di tutto, è meglio che dica che l’intervista a Luttazzi non doveva, in origine, toccare altro argomento se non il suo spettacolo, come da accordi con il suo ufficio stampa. E inoltre aggiungo che non mi interessava gran che chiedergli del blog. Detto questo, riprendo il commento di Gianluca, che mi sembra interessante, e parlo qui (credo per la prima volta, dopo averlo fatto in un paio di occasioni in pubblico) di alcune cose che riguardano il mezzo stesso su cui sto scrivendo.
Credo che il blog sia uno strumento, un mezzo di comunicazione che tutti possano usare, e il verbo potere qui ha due sensi. Il primo è che tutti hanno le capacità tecniche per aprire un blog, il secondo è che ognuno può usare un blog come gli pare. Il problema, secondo me, sta nella definizione di blogger. Gianluca scrive che “forse Luttazzi blogger non lo è mai stato”. Ma nessuno di noi è un blogger, o lo siamo tutti. Mi spiego: nonostante sia un medium, il blog non è un mass medium, e non è neanche un mezzo di comunicazione istituzionalizzato. Questo, in un certo senso, è uno dei suoi punti di forza, ma anche qualcosa che, visto il doppio significato di “potere” di prima, fa sì che non ci sia alcuna “professionalizzazione” nella figura di chi gestisce un blog, nel blogger, insomma. Anche questo elemento ha due facce: da un lato è un bene, perché rendere professionale (e come, poi?) una figura così sarebbe difficile e potrebbe portare il blogger a piegarsi ai tanti compromessi e ostacoli che caratterizzano qualsiasi figura professionale nell’ambito della comunicazione. Dall’altro lato è un male, perché spesso si fa informazione tramite i blog senza avere minimamente idea delle regole (etiche e, ancora una volta, professionali) che sono necessarie per un’informazione corretta.
 Luttazzi mi ha detto, nell’intervista, che si è reso conto come il blogger famoso possa diventare una specie di capopopolo. Questo può essere vero: sebbene io sia d’accordo con Gianluca sull’interazione necessaria con gli utenti, quest’interazione è minoritaria rispetto al “senso di abbandono” che si ha verso le parole di una “guida”. Insomma, diciamolo francamente: prima dello scivolone sulla questione dei contributi statali alla stampa, moltissimi associavano Beppe Grillo alla verità (scomoda), annullando il senso critico che dovrebbe essere alla base di qualsiasi lettura (intesa in senso ampio) di qualsiasi mezzo di informazione, dai giornali, ai blog, ai giornali radio, ai quotidiani.
Luttazzi mi ha detto, nell’intervista, che si è reso conto come il blogger famoso possa diventare una specie di capopopolo. Questo può essere vero: sebbene io sia d’accordo con Gianluca sull’interazione necessaria con gli utenti, quest’interazione è minoritaria rispetto al “senso di abbandono” che si ha verso le parole di una “guida”. Insomma, diciamolo francamente: prima dello scivolone sulla questione dei contributi statali alla stampa, moltissimi associavano Beppe Grillo alla verità (scomoda), annullando il senso critico che dovrebbe essere alla base di qualsiasi lettura (intesa in senso ampio) di qualsiasi mezzo di informazione, dai giornali, ai blog, ai giornali radio, ai quotidiani.
Ma non è solo questa la preoccupazione da tenere in considerazione, secondo me. C’è anche un altro effetto, che alcuni blog hanno come gli organi di informazione: determinare la cosiddetta agenda-setting, cioè, in parole povere, stabilire cosa è importante e degno di nota e cosa no. Ora, questo sarebbe un bene se i blog fossero considerati davvero, nel nostro Paese. Non lo sono, e questo accade sia per la scarsa qualità generale dei blog stessi, sia per una sorta di spocchia del mondo giornalistico istituzionale verso i nuovi mezzi di comunicazione in genere, soprattutto se “dal basso” come i blog. Il punto è che i blog più letti in Italia parlano (benissimo) di cazzate (e mi ci metterei in mezzo, se non fosse per i miei accessi non enormi e, soprattutto, il “benissimo”). E questo vuol dire che muovono sì l'”opinione pubblica” (occhio alle virgolette: i lettori di quotidiani, in Italia, in confronto ai lettori di blog, sono una massa enorme e sterminata, e voi sapete quanto poco vengono letti i giornali da noi), ma su serie tv, film (talvolta), altri siti, gruppi musicali di nicchia. In tutto questo, intendiamoci, non c’è nulla di male, anzi. Ma di informazione “seria” nei blog italiani ce n’è poca e, quando c’è, è spesso presente anche il “senso di abbandono” di cui sopra.
Torniamo a Luttazzi, quindi. Ha provato ad usare una tecnologia, che, come dice giustamente, non è neutrale, come tutte le tecnologie, e ha trovato delle cose che non vanno, o che non vanno a lui in questo momento. Secondo me non è detto che non ci riprovi, in un futuro. Ma per ora ha deciso di chiudere il suo blog, e capisco il suo gesto.
Update. Luttazzi parla della questione su Repubblica.it.
 Come quasi ogni giovedì, anche oggi l’etere bolognese (e lo streaming mondiale) verrà invaso dalla mia voce. Nella puntata di Monolocane di stasera un’intervista a Daniele Luttazzi, con il quale ho chiacchierato del suo nuovo spettacolo Come uccidere causando inutili sofferenze, di satira e informazione e di quello che ho visto scritto sui muri di Bologna.
Come quasi ogni giovedì, anche oggi l’etere bolognese (e lo streaming mondiale) verrà invaso dalla mia voce. Nella puntata di Monolocane di stasera un’intervista a Daniele Luttazzi, con il quale ho chiacchierato del suo nuovo spettacolo Come uccidere causando inutili sofferenze, di satira e informazione e di quello che ho visto scritto sui muri di Bologna.
In più musiche, dediche, rubriche e tanta giovane spensieratezza.
Dalle 22.30 sui 96.3 e 94.7 MHz a Bologna e, cliccando qua, in streaming all over the world.
Ecco l’intervista a Daniele Luttazzi!
[mixcloud https://www.mixcloud.com/Monolocane/monolocane-19-gennaio-2006/ width=100% height=120 hide_cover=1]
 Me ne rendo conto: sto diventando noioso a parlare di case, ma del resto la mia vita, in questo momento, è in gran parte occupata dalla ricognizione del mercato immobiliare. Sentendo pareri in giro, mi rendo conto che l’agente immobiliare è percepito come un essere dalla moralità un gradino sotto quella di Erode. Mi raccomando, però: non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, soprattutto perché se Erode fosse vivo potrebbe prendersela.
Me ne rendo conto: sto diventando noioso a parlare di case, ma del resto la mia vita, in questo momento, è in gran parte occupata dalla ricognizione del mercato immobiliare. Sentendo pareri in giro, mi rendo conto che l’agente immobiliare è percepito come un essere dalla moralità un gradino sotto quella di Erode. Mi raccomando, però: non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, soprattutto perché se Erode fosse vivo potrebbe prendersela.
Da ingenuo, pensavo che le agenzie immobiliari avessero l’esclusiva sugli appartamenti. Così non è. E non sto parlando di appartamenti incredibili che i prorpietari, magari, hanno voluto fare valutare a diverse agenzie. No, parlo di postacci strani e messi male. I loro proprietari, immagino, conoscono la legge dei grandi numeri e si basano su quella per tentare di disfarsene. In particolare mi è stato proposto uno stesso appartamento quattro volte. Un posto strano, esotico, affascinante e ributtante allo stesso tempo, perché dotato di due cucine. Come un serpente a due teste, insomma: sei morbosamente incuriosito dall’anomalia, ma non lo vorresti a casa (almeno, io no).
 Dopo un po’ ho riconosciuto la casa-dalle-due-cucine nei vari annunci: l’appartamento, infatti, è descritto sempre in maniera diversa. Alcune mie telefonate, quindi, ultimamente hanno avuto questo andazzo.
Dopo un po’ ho riconosciuto la casa-dalle-due-cucine nei vari annunci: l’appartamento, infatti, è descritto sempre in maniera diversa. Alcune mie telefonate, quindi, ultimamente hanno avuto questo andazzo.
“Potrei proporle un appartamento [descrizione]…”, dice l’agente.
“È quello [completa la descrizione]?”, dico io.
“Sì, l’ha già visto?”
“Già, è la x agenzia che me lo propone.”
A questo punto si sente distintamente una bestemmia trattenuta tra i denti, poi tutti dicono la stessa identica frase:
“Eh, che vuole: così si lavora male.”
(È un’espressione talmente frequente, ormai, che penso sia un codice segreto tra agenti immobiliari. Un giorno proverò a dire qualcosa come “Lo dice anche Johnny quando fa la torta”, vediamo che succede.)
A quel punto l’agente premuroso mi chiede che cosa non mi sia piaciuto. Evito di dire che viene proposto come ristrutturato quando farebbe la gioia di un qualunque carpentiere e muratore dilettante, e mi limito all’elemento più evidente: il fatto che abbia, appunto, due cucine. Quando lo dico, l’agente in questione non ammette mai l’evidenza. Prima dice “No, non è vero”, poi, quando gli ricordo che le ho viste, è costretto ad ammettere l’affascinante anomalia, suggerendo che, però, una delle due si può togliere. E io sono sempre tentato di chiedere: “E l’appartamento vive lo stesso?”
 Caro Lorenzo P.,
Caro Lorenzo P.,
ignoro perché tu mi abbia mandato un curriculum. Io, sai, faccio parte di quelli che i cv li mandano, e sperano che qualcuno li legga. Probabilmente hai trovato il mio indirizzo insieme ad altri, o hai usato uno di quei programmini che creano le liste a cui mandare spam, non lo so. Spero per te che tu non sia messo così male da avermi mandato consciamente il tuo curriculum, ma credo sia un’ipotesi improbabile. Comunque, proprio perché spero che qualcuno legga le cose che mando in giro, ho letto quello che hai fatto, e sono rimasto sinceramente impressionato. Hai un paio di anni più di me e hai fatto e studiato una quantità di cose che io forse riuscirei a fare in due vite. Mentre lo leggevo pensavo che avrei potuto inoltrarlo a qualcuno, per darti una mano. Siamo tutti nella stessa barca, in fondo.
Poi, arrivato alla fine, ho letto i tuoi interessi, una parte del curriculum che io stesso valuto poco, sbagliando. E ho visto che, cito, pratichi musica, chitarra, canto, vela, letteratura, scrittura, poesia, volontariato internazionale, moto, tennis, pallavolo, trekking, enologia e gastronomia internazionale.
Potevi dirlo subito che volevi lavorare alla redazione di “Gusto” del TG5.
 Quando andavo a scuola dovevo attraversare sempre una piccola galleria commerciale nel centro della mia città di nascita: durante le feste natalizie era sempre addobbata a festa, con tristi alberi di Natale, fiocchetti e un tappeto rosso con scritto “Buone Feste!” (sì, con due maiuscole, un punto esclamativo e, forse, numerose facce di babbonatale da pestare: essendo un tappeto…).
Quando andavo a scuola dovevo attraversare sempre una piccola galleria commerciale nel centro della mia città di nascita: durante le feste natalizie era sempre addobbata a festa, con tristi alberi di Natale, fiocchetti e un tappeto rosso con scritto “Buone Feste!” (sì, con due maiuscole, un punto esclamativo e, forse, numerose facce di babbonatale da pestare: essendo un tappeto…).
La galleria per me non significava niente durante le feste: ignoravo alberi e fiocchetti e pestavo naturalmente la faccia al vecchio grassone.
Ma il sette gennaio, quando si tornava a scuola, passare attraverso quella galleria era dolorosissimo: infatti rimaneva adobbata a festa anche dopo l’Epifania, per qualche giorno, e le faccione ormai grigiastre e tumefatte sul tappeto si prendevano la rivincita su noi ragazzini che tornavamo a scuola, in discesa libera verso le forche della fine del primo quadrimestre.
Era da tanto tempo che non sentivo quella sensazione. Oggi in radio ho preso una pausa, sono andato alla macchina del caffè, ho premuto un pulsante ed è venuto fuori un bicchiere con decorazioni di campanelle, bacche e agrifogli. Mi si è stretto lo stomaco. Ho preso il bicchiere e ho fatto per berne il contenuto. Le macchie sulla superficie della bevanda avevano una forma che ricordava tanto il viso di un vecchio con la barba che sogghignava.
Mi trovo di nuovo, dopo qualche mese, a guardare annunci immobiliari e riviste gratuite con planimetrie ed espressioni a me praticamente ignote come “nuda proprietà”, “rogito” e “foresteria”.
E incappo in un annuncio che dice:
BOLOGNA (BOLOGNA). Via S. Apollonia, disponibile bilocale interrato di circa 50 mq, impianti autonomi, NO abitabilità, ottimo come punto appoggio/magazzino o per studenti.
Non ci credete? Voilà.
 Poche ore prima di finire Lunar Park, l’ultimo grande libro di Bret Easton Ellis (autore che qui, lo dico subito, si idolatra vergognosamente), ho rivisto Ricomincio da tre. In un momento del film c’è un dialogo tra Gaetano (Massimo Troisi) e Lello (Lello Arena) che ha per oggetto la verità delle cose che vengono scritte. “Voi scrittori siete dei bugiardi: dite che inventate le cose e invece non inventate niente”, dice Lello alla fidanzata di Gaetano, Marta. La questione è di quelle che, di solito, vengono lasciate perdere, quando si parla di libri e di scrittori. “Ma sono cose vere, quelle che ha scritto?” è la domanda che ogni persona che intervista uno scrittore vorrebbe fargli, nonostante si dichiari sempre il contrario. E Ellis lo sa bene. Per questo motivo, alla fine del primo capitolo di Lunar Park, quello sicuramente più verosimile, l’autore scrive: “Tutto ciò che leggerete è realmente accaduto”, aggiungendo però subito dopo la frase “ogni parola è vera”. Queste due dichiarazioni, sebbene sembrano completarsi l’un l’altra, non sono necessariamente logiche in maniera consequenziale. Soprattutto perché il libro inizia parlando di come gli inizi dei libri di Bret Easton Ellis siano diventati mano a mano più complessi, elaborati e sovraccarichi di parole. Lo scrittore, quindi, può essere sincero con le sue parole, pur usandole per riportare fatti inventati.
Poche ore prima di finire Lunar Park, l’ultimo grande libro di Bret Easton Ellis (autore che qui, lo dico subito, si idolatra vergognosamente), ho rivisto Ricomincio da tre. In un momento del film c’è un dialogo tra Gaetano (Massimo Troisi) e Lello (Lello Arena) che ha per oggetto la verità delle cose che vengono scritte. “Voi scrittori siete dei bugiardi: dite che inventate le cose e invece non inventate niente”, dice Lello alla fidanzata di Gaetano, Marta. La questione è di quelle che, di solito, vengono lasciate perdere, quando si parla di libri e di scrittori. “Ma sono cose vere, quelle che ha scritto?” è la domanda che ogni persona che intervista uno scrittore vorrebbe fargli, nonostante si dichiari sempre il contrario. E Ellis lo sa bene. Per questo motivo, alla fine del primo capitolo di Lunar Park, quello sicuramente più verosimile, l’autore scrive: “Tutto ciò che leggerete è realmente accaduto”, aggiungendo però subito dopo la frase “ogni parola è vera”. Queste due dichiarazioni, sebbene sembrano completarsi l’un l’altra, non sono necessariamente logiche in maniera consequenziale. Soprattutto perché il libro inizia parlando di come gli inizi dei libri di Bret Easton Ellis siano diventati mano a mano più complessi, elaborati e sovraccarichi di parole. Lo scrittore, quindi, può essere sincero con le sue parole, pur usandole per riportare fatti inventati.
Quindi siamo tornati al punto di partenza. Non è importante quanto sia “vera” la storia raccontata in Lunar Park, che, ricordiamolo, è un libro in cui il protagonista si chiama come l’autore, ed è scritto per la prima volta al passato.
Il passato, già: è un “ritorno al passato” quello che fa iniziare il racconto del romanzo (o il secondo romanzo di Lunar Park, secondo la recensione molto bella di Giuseppe Genna), il secondo capitolo, con le parole “Sei una perfetta caricatura di te stesso”, le stesse dell’incipit del primo. Il passato è declinato secondo la vita privata di Ellis e la vita pubblica, o meglio i suoi romanzi: ecco che le due linee vengono a coincidere, visto che emerge dalle prime pagine che il sanguinario protagonista di American Psycho, forse il più riuscito e famoso dei romanzi di Ellis, è ispirato alla figura del padre dello scrittore.
E il passato, infine, si ricongiunge col presente: Ellis è diventato padre a sua volta, è sposato ad un’attrice, dalla quale ha avuto un figlio una decina di anni prima. O tutto questo è solo quello che ci racconta il protagonista di Lunar Park.
Il vero tema di Lunar Park è antico, primordiale: è il rapporto padre-figlio, allargato metaforicamente a quello dell’atto creativo, del dare vita (ad un essere umano, al passato, alle parole, ad una storia, ad una casa, a Lunar Park), ed esteso anche allo stile. L’ultima parte del libro è infatti un omaggio dichiarato alle atmosfere e allo stile di Stephen King, che Ellis ha spesso citato come fonte di ispirazione in dichiarazioni e interviste.
Lunar Park è molto diverso da qualsiasi cosa che Ellis abbia mai scritto prima. Ma, del resto, con il suo ultimo libro Bret Easton Ellis ha partorito con dolore se stesso. Credo quindi che, come tutte le persone che diventano padri, non potrà più essere quello di una volta.
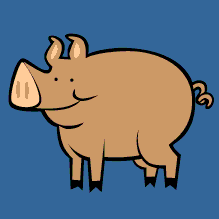 Questo è un buon simbolo di quello che è successo alla festa di fine anno di ieri. Protagonista assoluto il maiale, nella forma a sinistra, ma con i colori e il senso pop di quello di destra. La staticità delle pose, dovuta a profonda riflessione da un lato, e a macellazione dall’altro, invece, non c’entra per niente.
Questo è un buon simbolo di quello che è successo alla festa di fine anno di ieri. Protagonista assoluto il maiale, nella forma a sinistra, ma con i colori e il senso pop di quello di destra. La staticità delle pose, dovuta a profonda riflessione da un lato, e a macellazione dall’altro, invece, non c’entra per niente.
Qualcuno ieri si dev’essere preoccupato che non si mangiasse abbastanza, come ieri. Il risultato è stato una quantità di cibi e bevande varie che avrebbe sfamato uno stato di piccole dimensioni, e non musulmano, si intende, per ovvi motivi. Ogni tanto si sentivano voci come “Ehi, ma qui c’è del tacchino”, o “Ma è incredibile, non credevo che le lenticchie avessero una forma di organizzazione autonoma”. C’è anche stato uno scambio di questo tipo:
“Questo (quello nella foto, n.d.r.) è un salame vegetariano?”
“No, viene da Castel San Pietro.”
 Qualcuno ha intonato canti leninisti alternandoli con pezzi dei Van Der Graaf Generator. Altri hanno insegnato alla straniera di turno parolacce e filastrocche che finivano con cose come “and all the angels in a column” (e alle traduzioni letterali delle espressioni del nostro bell’idioma la WASP di turno esclamava cose come “Oh, really? Is that the translation?”).
Qualcuno ha intonato canti leninisti alternandoli con pezzi dei Van Der Graaf Generator. Altri hanno insegnato alla straniera di turno parolacce e filastrocche che finivano con cose come “and all the angels in a column” (e alle traduzioni letterali delle espressioni del nostro bell’idioma la WASP di turno esclamava cose come “Oh, really? Is that the translation?”).
Poi si è passati alle danze, con il rituale, angosciante e lunghissimo conto alla rovescia (dio, l’ansia che mi mette ogni singolo anno) a fare da punteggiatura. Un ballo ininterrotto dall’una alle sei sulle note di canzoni scaricate al momento, a seconda della generosità della rete p2p.
 Conclusioni raggiunte alla fine della serata, cioè quando ormai albeggiava:
Conclusioni raggiunte alla fine della serata, cioè quando ormai albeggiava:
– il Martini cocktail è qualcosa che non si può improvvisare;
– non c’è alcuna differenza tra il primo, il secondo e il terzo giro di rhum e pera: sul quarto sospendo il giudizio;
– una stanza normalissima dotata di un letto a soppalco, un portatile e una connessione a banda larga può diventare dancefloor, locale di lap dance, sala prove del Living Theatre;
– la musica è fondamentalmente la stessa dal 1982 ad oggi (questa è di Manu);
– dopo le cinque del mattino la funzione di una cravatta è esattamente a metà strada tra quella di un boa di piume e una corda per saltare.
Ancora una volta, buon anno a tutti.