Pensieri del fine settimana
Ha qualche significato la stretta somiglianza tra “Trans Europe Express” dei Kraftwerk e la sigla del telefilm Supercar?
E poi, ovviamente, Il caimano.
Ha qualche significato la stretta somiglianza tra “Trans Europe Express” dei Kraftwerk e la sigla del telefilm Supercar?
E poi, ovviamente, Il caimano.
 Ultimamente il mio lavoro si sta riducendo ad una cosa soltanto: attendere. Aspetto che salgano percentuali di trasferimento. Che si carichino pagine. Che file vengano copiati. Vedo scorrere barre di completamento, avanzare rettangolini blu, verdi, rossi, neri, grigi, che tendono alla fine dell’alloggiamento dove scorrono (ed è meglio non pensare, in questi casi, al paradosso di Zenone).
Ultimamente il mio lavoro si sta riducendo ad una cosa soltanto: attendere. Aspetto che salgano percentuali di trasferimento. Che si carichino pagine. Che file vengano copiati. Vedo scorrere barre di completamento, avanzare rettangolini blu, verdi, rossi, neri, grigi, che tendono alla fine dell’alloggiamento dove scorrono (ed è meglio non pensare, in questi casi, al paradosso di Zenone).
Attendo, attendo, attendo. E, tra un’attesa e un’altra, un clic. Poi un altro.
Poi un altro.
Voi potreste dirmi: fa’ qualcosa, mentre aspetti i vari caricamenti, scorrimenti, trasferimenti. Lo faccio. Controllo la posta, di solito. Ma la mente è comunque rivolta alla parte di operazione che sto facendo, a quello che ha preceduto e quello che seguirà il caricamento. Rischio quindi di pubblicare i cavoli miei e di mandare via mail notizie, quando va bene, o blocchi di html. In quel caso, va male. Lo stesso vale per il blog. Non l’ho aggiornato per più di qualche giorno, ma stavo aspettando che si completassero alcuni caricamenti, upload, render, copie, processi.
 Ma perché questo non rimanga solo un post lamentoso, vi regalo due canzoncine. Si tratta di due pezzi dei The Subways, un gruppo che ha vinto la sezione “emergenti” del Festival di Glastonbury due anni fa (credo), e che finora ha pubblicato solo un disco, uscito l’anno scorso: Young for Eternity. Ed è proprio con quello spirito che i fanciulli suonano. Tutto e subito, senza pensare troppo alle parole, ma mettendoci l’anima. Ovviamente sono inglesi. Ovviamente il loro secondo disco sarà del tutto dimenticabile, se mai ci sarà. Però mi fa strano che alcuni dei miei blog musicali di riferimento non ne abbiano dato notizia. O forse mi sono perso qualche post. O forse ad alcuni dei miei blog musicali di riferimento questo disco fa schifo. Va’ a sapere.
Ma perché questo non rimanga solo un post lamentoso, vi regalo due canzoncine. Si tratta di due pezzi dei The Subways, un gruppo che ha vinto la sezione “emergenti” del Festival di Glastonbury due anni fa (credo), e che finora ha pubblicato solo un disco, uscito l’anno scorso: Young for Eternity. Ed è proprio con quello spirito che i fanciulli suonano. Tutto e subito, senza pensare troppo alle parole, ma mettendoci l’anima. Ovviamente sono inglesi. Ovviamente il loro secondo disco sarà del tutto dimenticabile, se mai ci sarà. Però mi fa strano che alcuni dei miei blog musicali di riferimento non ne abbiano dato notizia. O forse mi sono perso qualche post. O forse ad alcuni dei miei blog musicali di riferimento questo disco fa schifo. Va’ a sapere.
The Subways – I want to hear what you’ve got to say
The Subways – Rock’n’Roll Queen
(Ovviamente dovrete aspettare un po’ per scaricare i pezzi. Così questo diventa un post decisamente empatico.)
 Ho scritto poche volte di quando torno nella mia città natia: basta leggere un resoconto per capire perché.
Ho scritto poche volte di quando torno nella mia città natia: basta leggere un resoconto per capire perché.
Ma questo fine settimana mi è successa una cosa molto particolare: ho conosciuto per la prima volta un ragazzo gay che abita in quel posto dimenticatodaddio. Amico di amica, ha chiacchierato piacevolmente con me. Al terzo locale in cui eravamo vedo che discute animatamente con la mia amica. Mi intrometto, e chiedo quale sia il motivo della disputa.
“Mi sta chiedendo”, dice lui un po’ brillo, “se uno là dietro è gay.”
A questa frase inizia una discussione sul tema: come un omosessuale capisce se un altro uomo è etero o no. Alla fine capisco che se un uomo “guarda e riguarda” un altro uomo, beh, è gay. A meno che l’uomo non sia vestito in maniera molto particolare: in tal caso fa il gay.
“E come fai a sapere se uno è gay ma tu non gli piaci?”
“Guarda e riguarda comunque”, dice lui. E aggiunge: “Ma sai quanti sono gay o bisessuali?”
“Eh, sì”, dico io.
“Sei bisessuale?” dice lui dissimulando entusiasmo.
“No”, rispondo, e quasi mi verrebbe da scusarmi.
“Ma sai qui quanti cosiddetti etero, anche padri di famiglia…”
“Eh”, continuo io, “guardano e riguardano?”
Lui mi fissa per un po’, poi dice, con una punta di tristezza: “Fanno. E rifanno.”
E poi, come al solito, finiamo per parlare di Bologna, di quanto è bella, libera, indipendente, giovane e divertente.
 Ho fatto tre al Superenalotto, davvero. Nell’estrazione di giovedì scorso. Voi non avete mai giocato al Superenalotto? Non siete mai stati tentati dal jackpotmilionario? No?
Ho fatto tre al Superenalotto, davvero. Nell’estrazione di giovedì scorso. Voi non avete mai giocato al Superenalotto? Non siete mai stati tentati dal jackpotmilionario? No?
Beh, io ci gioco da un po’. Non è un modo per risolversi la vita, questo lo so. Ma, d’altro canto, con lo stipendio che ho dovrei lavorare diecimilaseicentoquindici anni, per accumulare dei soldi. Ovviamente senza contributi. E senza pensione. Anche perché sforerei l’età pensionabile di un bel po’, e se dovessero pagarmi i contributi per tutti quegli anni di lavoro dovrebbero regalarmi un piccolo stato dell’Africa centrale come ricompensa. Quindi preferisco giocarmi le mie due combinazioni da un euro e tentare il sei.
Sapete quante possibilità ci sono di fare sei al Superenalotto? Le hanno calcolate dei matematici. Poi, quando hanno finito di ridere, hanno comunicato al mondo il risultato: una su seicento milioni. Circa. È il circa che mi dà fiducia, ovviamente. Pensate, quindi, a tutta la popolazione dell’Unione Europea e degli Stati Uniti, ognuno con la sua bella combinazione da un euro. Tralasciate la fila che ci sarebbe alle ricevitorie. Beh, di questa massa di gente, tedeschi, sanmarinesi, newyorkesi, e ovviamente anche gente del Wyoming, farebbe sei uno solo. Immaginate che rosicamento gli altri. In confronto fare tredici al Totocalcio o vincere la Lotteria Italia è una bazzeccola. Nonostante questo io e altri milioni di persone giocano al Superenalotto. E non venite a fare discorsi da formichine, che con quell’euro risparmiato, eccetera eccetera: ci vorrebbero sempre migliaia di anni per accumulare una cifra decente, per giocare finalmente il sistemone spaziale globale, che aumenta moltissimo le possibilità di vincita: una su trecento milioni. Via gli Stati Uniti dalla competizione, insomma.
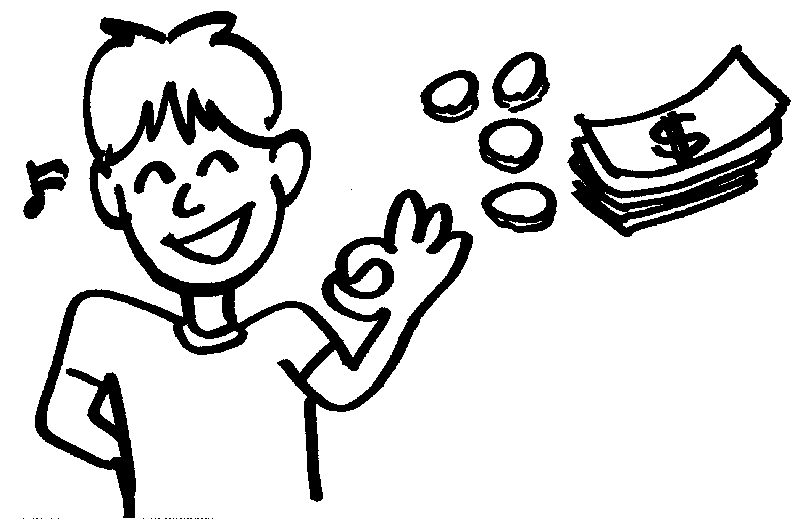 Fatto sta che giovedì scorso ho fatto tre. È tremendo fare tre. Perché non è fare quattro, né cinque, né cinque più uno. (Sei l’ha fatto la signora Evelyn Jackson di Tampa, Florida). E’ quasi vergognoso. Anche mio padre ha fatto tre, una volta. Si vergognava talmente tanto di farmelo sapere che, per attutire il colpo, mi ha detto “Non sono tuo padre. Ah, e poi ho anche fatto tre al Superenalotto”.
Fatto sta che giovedì scorso ho fatto tre. È tremendo fare tre. Perché non è fare quattro, né cinque, né cinque più uno. (Sei l’ha fatto la signora Evelyn Jackson di Tampa, Florida). E’ quasi vergognoso. Anche mio padre ha fatto tre, una volta. Si vergognava talmente tanto di farmelo sapere che, per attutire il colpo, mi ha detto “Non sono tuo padre. Ah, e poi ho anche fatto tre al Superenalotto”.
Quando ho visto i risultati delle estrazioni ho avuto un minuto di euforia, fantasticando se, coi soldi vinti, avrei potuto prendere, oltre alla birra media e alla quattro stagioni, la proibitiva aggiunta di mozzarella di bufala.
Venerdì mattina sono andato nella ricevitoria dove avevo giocato il giorno prima. “Salve”, ho detto imbarazzato al gestore, porgendogli la schedina. “Avrei fatto tre al Superenalotto.” “Bravo”, mi ha detto il gestore, pensando ai cazzi suoi. “Sono dodici euro e sessanta.” Ha ravanato nella cassa, poi mi ha guardato e mi ha chiesto: “Non avrebbe mica quaranta centesimi di resto?”
 Ho incontrato Carlo Verdone una sola volta, alla presentazione del suo film Ma che colpa abbiamo noi, ormai tre anni fa.
Ho incontrato Carlo Verdone una sola volta, alla presentazione del suo film Ma che colpa abbiamo noi, ormai tre anni fa.
Lo ammetto senza pudori: a me piace. Ovviamente preferirei dimenticare le cose che ha fatto negli ultimi dieci anni, ma penso che comunque abbia fatto degli ottimi film. E poi, mi tolgo gli abiti del critico cialtrone che indosso qua, a me Verdone fa ridere. Un po’ come Pozzetto (et voilà, via con un’altra confessione), mi basta vederlo sullo schermo (spesso il piccolo schermo) perché rimanga a vedere tutto il film o lo sketch in questione.
Molti anni fa avevo fatto una cassettina, da mettere nell’autoradio. Sopra c’era il primo quarto d’ora di Un sacco bello: quindici minuti che conosco ancora a memoria, comprese musiche e rumori di fondo. E quando sono stato in Cornovaglia, una decina di anni fa, sono andato nell’hotel di Land’s End dove ha girato alcune scene di Maledetto il giorno che ti ho incontrato.
Ho osservato Verdone al buffet dopo la presentazione di Ma che colpa abbiamo noi. Credo di averlo solo salutato, di avere scambiato con lui una battuta sul cibo, e ricordo perfettamente la sua espressione: era sovrappensiero, ed era come se l’avessi beccato a fare qualcosa di sconveniente.
Mi piacerebbe parlare con lui di tutte queste cose oggi, dalle 1530, in radio, perché sarà con me in diretta, nella prima mezz’ora usurpata dal programma di Elisa Graci e FedeMC, Su la testa. Mi piacerebbe raccontargli della cassetta che avevo fatto, di quanto alcuni suoi film siano legati al mio passato. Ma non potrò farlo, perché non saremo da soli. Con noi, infatti, ci sarà anche Silvio Muccino. Il film che promuovono si chiama Il mio miglior nemico.
Update. Pare abbiano perso il treno, niente incontro. Sicuramente è stata colpa di Muccino.
 È inutile: ormai ogni volta che vado a Roma, piove. Scrivo questo noncurante del fatto che i romani che hanno commentato il mio post precedente ormai possano bollarmi come iettatore: affronterò l’eventuale realtà.
È inutile: ormai ogni volta che vado a Roma, piove. Scrivo questo noncurante del fatto che i romani che hanno commentato il mio post precedente ormai possano bollarmi come iettatore: affronterò l’eventuale realtà.
Mi sono reso conto, però, dei collegamenti tra me e il ragioniere soltanto sul treno del ritorno.
Prima di tutti, ovviamente, la nuvola da impiegato. Avevo bisogno di questo fine settimana, e me lo immaginavo soleggiato, con quell’aria meravigliosa che solo Roma può avere. Invece ho avuto, almeno per il giorno-e-mezzo in più che mi sono preso di vacanza, cielo lattiginoso e pioggerellina. Molto british, non c’è che dire. Ma se lo volevo me ne andavo a Londra, no?
Poi c’è stato il passaggio sulla tangenziale est, tra la Prenestina e San Lorenzo, con precisa indicazione, da parte del fratello, del balconcino dal quale il ragioniere si cala per prendere il bus al volo, nel primo film. All’epoca quel tratto di tangenziale è chiusa. Adesso, invece, è realmente possibile scendere dal terrazzino e immettersi nel traffico dell’Urbe, con un innocuo saltino. Progressi dell’urbanistica.
Infine sono andato a mangiare la quaglia, per la prima volta in vita mia. Lo ammetto: ero terrorizzato, pensavo che il volatile, sebbene più che morto, saltasse grazie alla mia imperizia su teste e tavoli altrui. Invece l’ho domato, senza che il mio viso diventasse rosso pompeiano o, peggio, blu tenebra.
 E la parentesi felliniana, direte voi? C’è stata domenica mattina, prima che partissi. Sono andato a vedere le case romane del Celio: dimenticatevi le rovine, via dei Fori Imperiali, il Colosseo. Questo sito archeologico vi fa entrare in case e botteghe, vi fa camminare in stretti vicoli, vi mostra affreschi bellissimi. Uno li guarda e si aspetta sempre che, come in Roma, il venticello della capitale li faccia volar via, per sempre.
E la parentesi felliniana, direte voi? C’è stata domenica mattina, prima che partissi. Sono andato a vedere le case romane del Celio: dimenticatevi le rovine, via dei Fori Imperiali, il Colosseo. Questo sito archeologico vi fa entrare in case e botteghe, vi fa camminare in stretti vicoli, vi mostra affreschi bellissimi. Uno li guarda e si aspetta sempre che, come in Roma, il venticello della capitale li faccia volar via, per sempre.
Tutto è iniziato una settimana fa circa, o forse un po’ di più. Camminavo in una strada del centro di Bologna, costeggiando il grande palazzo della Cassa di Risparmio cittadina. Ad un tratto ho sentito un rumore sordo e ho visto qualcosa cadere ad un metro da me: era un pezzo del palazzo, non enorme, ma abbastanza grande da permettervi, nel caso fossi stato nella sua traiettoria, di parlare di me al passato remoto.
Due giorni fa ero seduto in autobus a leggere quando ho sollevato gli occhi e ho visto una donna cadere di faccia per terra, dopo avere messo un piede in fallo.
Le cadute e ricadute di questa specie di influenza che pare non manifestarsi mai veramente la fanno da padrone nel mio organismo da una settimana.
E mi cadono tra capo e collo, stavolta in maniera figurata, proposte e cose, di varia entità, che subito si annullano e vengono sostituite da altre cose.
Provo quindi a ragionare con le stesse armi del “nemico”: per evitare questo moto perpetuo, mi sposto e me ne vado a Roma fino a domenica. Sperando di non scivolare appena messo piede nella stazione Termini.
 Me ne rendo conto: sto diventando noioso a parlare di case, ma del resto la mia vita, in questo momento, è in gran parte occupata dalla ricognizione del mercato immobiliare. Sentendo pareri in giro, mi rendo conto che l’agente immobiliare è percepito come un essere dalla moralità un gradino sotto quella di Erode. Mi raccomando, però: non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, soprattutto perché se Erode fosse vivo potrebbe prendersela.
Me ne rendo conto: sto diventando noioso a parlare di case, ma del resto la mia vita, in questo momento, è in gran parte occupata dalla ricognizione del mercato immobiliare. Sentendo pareri in giro, mi rendo conto che l’agente immobiliare è percepito come un essere dalla moralità un gradino sotto quella di Erode. Mi raccomando, però: non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, soprattutto perché se Erode fosse vivo potrebbe prendersela.
Da ingenuo, pensavo che le agenzie immobiliari avessero l’esclusiva sugli appartamenti. Così non è. E non sto parlando di appartamenti incredibili che i prorpietari, magari, hanno voluto fare valutare a diverse agenzie. No, parlo di postacci strani e messi male. I loro proprietari, immagino, conoscono la legge dei grandi numeri e si basano su quella per tentare di disfarsene. In particolare mi è stato proposto uno stesso appartamento quattro volte. Un posto strano, esotico, affascinante e ributtante allo stesso tempo, perché dotato di due cucine. Come un serpente a due teste, insomma: sei morbosamente incuriosito dall’anomalia, ma non lo vorresti a casa (almeno, io no).
 Dopo un po’ ho riconosciuto la casa-dalle-due-cucine nei vari annunci: l’appartamento, infatti, è descritto sempre in maniera diversa. Alcune mie telefonate, quindi, ultimamente hanno avuto questo andazzo.
Dopo un po’ ho riconosciuto la casa-dalle-due-cucine nei vari annunci: l’appartamento, infatti, è descritto sempre in maniera diversa. Alcune mie telefonate, quindi, ultimamente hanno avuto questo andazzo.
“Potrei proporle un appartamento [descrizione]…”, dice l’agente.
“È quello [completa la descrizione]?”, dico io.
“Sì, l’ha già visto?”
“Già, è la x agenzia che me lo propone.”
A questo punto si sente distintamente una bestemmia trattenuta tra i denti, poi tutti dicono la stessa identica frase:
“Eh, che vuole: così si lavora male.”
(È un’espressione talmente frequente, ormai, che penso sia un codice segreto tra agenti immobiliari. Un giorno proverò a dire qualcosa come “Lo dice anche Johnny quando fa la torta”, vediamo che succede.)
A quel punto l’agente premuroso mi chiede che cosa non mi sia piaciuto. Evito di dire che viene proposto come ristrutturato quando farebbe la gioia di un qualunque carpentiere e muratore dilettante, e mi limito all’elemento più evidente: il fatto che abbia, appunto, due cucine. Quando lo dico, l’agente in questione non ammette mai l’evidenza. Prima dice “No, non è vero”, poi, quando gli ricordo che le ho viste, è costretto ad ammettere l’affascinante anomalia, suggerendo che, però, una delle due si può togliere. E io sono sempre tentato di chiedere: “E l’appartamento vive lo stesso?”
 Quando andavo a scuola dovevo attraversare sempre una piccola galleria commerciale nel centro della mia città di nascita: durante le feste natalizie era sempre addobbata a festa, con tristi alberi di Natale, fiocchetti e un tappeto rosso con scritto “Buone Feste!” (sì, con due maiuscole, un punto esclamativo e, forse, numerose facce di babbonatale da pestare: essendo un tappeto…).
Quando andavo a scuola dovevo attraversare sempre una piccola galleria commerciale nel centro della mia città di nascita: durante le feste natalizie era sempre addobbata a festa, con tristi alberi di Natale, fiocchetti e un tappeto rosso con scritto “Buone Feste!” (sì, con due maiuscole, un punto esclamativo e, forse, numerose facce di babbonatale da pestare: essendo un tappeto…).
La galleria per me non significava niente durante le feste: ignoravo alberi e fiocchetti e pestavo naturalmente la faccia al vecchio grassone.
Ma il sette gennaio, quando si tornava a scuola, passare attraverso quella galleria era dolorosissimo: infatti rimaneva adobbata a festa anche dopo l’Epifania, per qualche giorno, e le faccione ormai grigiastre e tumefatte sul tappeto si prendevano la rivincita su noi ragazzini che tornavamo a scuola, in discesa libera verso le forche della fine del primo quadrimestre.
Era da tanto tempo che non sentivo quella sensazione. Oggi in radio ho preso una pausa, sono andato alla macchina del caffè, ho premuto un pulsante ed è venuto fuori un bicchiere con decorazioni di campanelle, bacche e agrifogli. Mi si è stretto lo stomaco. Ho preso il bicchiere e ho fatto per berne il contenuto. Le macchie sulla superficie della bevanda avevano una forma che ricordava tanto il viso di un vecchio con la barba che sogghignava.
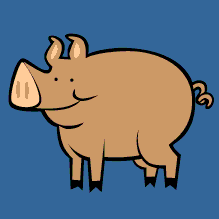 Questo è un buon simbolo di quello che è successo alla festa di fine anno di ieri. Protagonista assoluto il maiale, nella forma a sinistra, ma con i colori e il senso pop di quello di destra. La staticità delle pose, dovuta a profonda riflessione da un lato, e a macellazione dall’altro, invece, non c’entra per niente.
Questo è un buon simbolo di quello che è successo alla festa di fine anno di ieri. Protagonista assoluto il maiale, nella forma a sinistra, ma con i colori e il senso pop di quello di destra. La staticità delle pose, dovuta a profonda riflessione da un lato, e a macellazione dall’altro, invece, non c’entra per niente.
Qualcuno ieri si dev’essere preoccupato che non si mangiasse abbastanza, come ieri. Il risultato è stato una quantità di cibi e bevande varie che avrebbe sfamato uno stato di piccole dimensioni, e non musulmano, si intende, per ovvi motivi. Ogni tanto si sentivano voci come “Ehi, ma qui c’è del tacchino”, o “Ma è incredibile, non credevo che le lenticchie avessero una forma di organizzazione autonoma”. C’è anche stato uno scambio di questo tipo:
“Questo (quello nella foto, n.d.r.) è un salame vegetariano?”
“No, viene da Castel San Pietro.”
 Qualcuno ha intonato canti leninisti alternandoli con pezzi dei Van Der Graaf Generator. Altri hanno insegnato alla straniera di turno parolacce e filastrocche che finivano con cose come “and all the angels in a column” (e alle traduzioni letterali delle espressioni del nostro bell’idioma la WASP di turno esclamava cose come “Oh, really? Is that the translation?”).
Qualcuno ha intonato canti leninisti alternandoli con pezzi dei Van Der Graaf Generator. Altri hanno insegnato alla straniera di turno parolacce e filastrocche che finivano con cose come “and all the angels in a column” (e alle traduzioni letterali delle espressioni del nostro bell’idioma la WASP di turno esclamava cose come “Oh, really? Is that the translation?”).
Poi si è passati alle danze, con il rituale, angosciante e lunghissimo conto alla rovescia (dio, l’ansia che mi mette ogni singolo anno) a fare da punteggiatura. Un ballo ininterrotto dall’una alle sei sulle note di canzoni scaricate al momento, a seconda della generosità della rete p2p.
 Conclusioni raggiunte alla fine della serata, cioè quando ormai albeggiava:
Conclusioni raggiunte alla fine della serata, cioè quando ormai albeggiava:
– il Martini cocktail è qualcosa che non si può improvvisare;
– non c’è alcuna differenza tra il primo, il secondo e il terzo giro di rhum e pera: sul quarto sospendo il giudizio;
– una stanza normalissima dotata di un letto a soppalco, un portatile e una connessione a banda larga può diventare dancefloor, locale di lap dance, sala prove del Living Theatre;
– la musica è fondamentalmente la stessa dal 1982 ad oggi (questa è di Manu);
– dopo le cinque del mattino la funzione di una cravatta è esattamente a metà strada tra quella di un boa di piume e una corda per saltare.
Ancora una volta, buon anno a tutti.