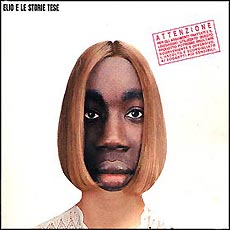“Ora so chi sono”: intervista a John Grant (novembre 2011)
John Grant rimarrà per sempre associato a una mia grande dimenticanza: ancora oggi mi pento nel non avere preso in considerazione il suo Queen of Denmark a sufficienza, quando uscì. L’ho recuperato dopo, poco prima dello splendido concerto nella chiesa di Castenaso dell’aprile 2011. Da quel momento in poi, però, il disco e i ricordi di quel live mi sono rimasti in testa. Nel novembre del 2011 Grant è tornato a esibirsi in Italia, e ho avuto la possibilità di intervistarlo poco prima della sua data bolognese, insieme a LessTv, che ha fornito l’audio dell’intervista che state per leggere.
Grant mi accoglie disteso sul divano del camerino del Covo: indossa pantaloni e maglietta, e così andrà sul palco poche ore dopo. Sorride, è cordiale. Si scusa per la posizione, ma chiede di rimanere così. Io allora mi accomodo su una sedia all’altezza delle sue spalle e insieme sembriamo un quadretto “paziente-analista”. L’immagine non è peregrina, perché ancor prima che inizi a porre una domanda è lui che inizia a parlare.
“Non mi trovo a mio agio con la gente ricca”, confessa, “forse perché sono di estrazione bassa… o loro credono che lo sia.” Come molte delle frasi pronunciate dal cantante, anche questa è tanto sincera quanto pervasa di ironia: la profonda intelligenza e sensibilità dell’ex-Czars si manifestano in ogni sua espressione. “Sono stato in una scuola di ragazzi ricchi ed erano orribili: erano il male.”
Che mi dici di quando ti sei trovato in situazioni simili, anche di recente, quando hai vinto dei premi?
Non mi dà più fastidio, perché ora so meglio chi sono. Non che sia questo grande affare, ma… Adesso riesco a pensare più logicamente a tutto questo, e capisco che sono solo persone.
Parli spesso di un “ora”: a cosa si contrappone? Cosa c’era nel passato?
In realtà c’è stato un processo graduale negli anni, più che un “adesso” e “prima”. Ho superato la “questione dei ricchi” intorno ai trent’anni. Anche quando vivevo in Germania ero in mezzo ai ricchi, perché uscivo con molti studenti della facoltà di Legge, le cui famiglie erano sfacciatamente ricche. Andavo spesso in queste loro case e non avevo un bel vestito da mettermi. Questo mi metteva a disagio. Non avevo soldi per un vestito, quindi andavo in jeans e camicie scadenti. (fa una lunga pausa per pensare) Credo di avere cominciato a superare tutto questo una decina di anni fa, quando ho smesso con alcol e droghe per diventare sobrio. È stato più di sette anni fa.
Questa partizione è legata direttamente alle tue due fasi musicali?
Sicuramente. Quando ero negli Czars non riuscivo a esprimere vocalmente quello che stavo passando. Non sapevo dirlo a parole. (fa una pausa) Non credo di averci mai pensato prima d’ora, ma probabilmente è stato più facile parlare di me stesso apertamente da quando è morta mia madre. Perché penso che se mia madre fosse viva e ascoltasse il disco (Queen of Denmark, ndr) si arrabbierebbe molto. Non ci avevo mai pensato prima, mi è venuto ora. Non so se sia veramente così, sto pensando a voce alta. Mia madre è morta nel ’95 e noi avevamo appena iniziato. Abbiamo continuato per dieci anni. Davvero troppo…
In molte interviste sei apparso sicuro e tagliente nel giudicare il lavoro fatto con la band. Ma quanto del John Grant musicista, che suonava con gli Czars, c’è in colui che ha fatto Queen of Denmark?
La domanda è interessante. Diciamo che ora mi sento di più me stesso. Ero io anche quando suonavo negli Czars, ma era un periodo duro, bevevo molto… Non volevo avere a che fare con alcunché di serio, con il fatto che stessi crescendo o con la mia confusione sessuale. Quindi ho bevuto, mi sono fatto, ho scopato chiunque potessi avere a tiro, ho vissuto in maniera promiscua per dimenticare. Quindi, tornando alla domanda: ero lì, ma ero coperto da un sacco di merda. Sono la stessa persona, ma non ho più paura di essere me stesso: è più facile esserlo, per quello che so di me. Ammettiamolo: non posso sapere chi sono fino in fondo, ma ora ne ho un’idea migliore. Ripensare a quel periodo mi mette a disagio, perché è stato un momento doloroso.
Pensi che sia stato necessario attraversare quel periodo per conoscerti meglio?
Non so… Quel periodo è stato pura evasione, distrazione, non sapevo cosa stavo facendo. Quando mia madre morì, fu un brutto colpo, ma ero egoista: usai la morte di mia madre per attirare attenzione, per me stesso. E anche questo pensiero è doloroso, perché vuol dire che in quel momento non stavo realmente pensando a ciò che stava accadendo, a mia madre e alla sua morte, forse perché era troppo difficile. Comunque credo che elaborare quel periodo, parlarne, possa aiutarmi a comprendermi di più: tuttavia non so se ne sono completamente uscito. Quando mi stabilisco da qualche parte cerco subito un analista: è più facile parlare con un medico che annoiare a morte i tuoi amici, fino a farli dire “Non ce la faccio più, va’ in analisi”! (ride) C’è anche da dire che prendo antidepressivi da diciott’anni. Un po’ alla volta sto smettendo con tutte le medicine per la depressione, ma continuo a prenderne una, la più forte. È difficile smetterla perché ti fotte il cervello, quando non la assumi più: bisogna farlo quindi molto molto gradualmente. Sto andando da un dottore e insieme vogliamo cercare di capire chi sia, senza medicine. Le prendo da vent’anni, ma non ho mai avuto a che fare prima con un dottore che mi aiuti a comprendere il perché le prendo. Faccio queste cure da anni senza che nessuno controlli davvero i risultati ottenuti. Forse non so nemmeno cosa succede nella mia testa, e una volta che smetterò di prendere quest’ultima medicina saprò davvero chi sono. Non so che succederà, davvero: sarà interessante.
Queen of Denmark è molto autobiografico. Nei tuoi prossimi lavori continuerai su questa linea o il disco precedente è un romanzo a cui è stata posta la parola “fine”?
No, continuerò su quella strada. Nel nuovo disco ci saranno parti autobiografiche, nuovi stimoli e molta rabbia. Ci saranno molti “vaffanculo”, come in “Queen of Denmark”, ma anche più ironia; rabbia mista allo humor. Credo che solo dopo il prossimo disco potrò pensare ad altre cose, altre storie. Mi piacerebbe cantare in lingue diverse, e quindi potrei fare un disco sui posti dove sono stato: l’Italia, l’Islanda, la Svezia, la Danimarca… Amo la Scandinavia, ma l’Italia e la Spagna hanno qualcosa in più, perché ho passato molta della mia vita al buio, lontano dal sole e dalla luce. L’Italia è davvero un posto diverso, per questo motivo, dai Paesi del nord. C’è un modo diverso di vivere. Ancora non capisco bene l’italiano, perché ho passato qui troppo poco tempo, ma voglio impararlo. E poi c’è una bellezza tale che la mente difficilmente la comprende. Mi chiedo cosa voglia dire essere italiano, perché ho paura che avendo tutta questa bellezza intorno, qualsiasi altro Paese che visitiate sia poca cosa per voi. Oggi pomeriggio pensavo a Monica Bellucci, senza motivo, e mi chiedevo perché abbia dovuto lasciare Roma per Los Angeles: ho pensato però che Roma dev’essere una città difficile da vivere. Ho vissuto anche in campagna, nel Devon: stavo da solo in un piccolo cottage. Scrivevo, passeggiavo, guardavo film e programmi televisivi, studiavo lingue, le grammatiche: ho bisogno di cose come queste, ma anche della gente. La mia vita è in un momento di totale fluttuazione: non ho un posto mio dove vivere da due anni. Sono stato da amici, senza avere un luogo dove mettere i miei libri. Ho libri a Berlino, a Göteborg, a Londra, in Texas, in Colorado, a New York… Ho bisogno di un posto tutto mio dove tenere le mie cose. Negli ultimi due anni, con Queen of Denmark, la mia vita è cambiata completamente. E continuerà così, perché inizierò a registrare il mio nuovo disco alla fine di gennaio (2012, ndr) e si ricomincerà.
Qual è il tuo rapporto tra la tua nazionalità d’origine e tutti gli elementi prettamente americani di Queen of Denmark e le tante culture che hai studiato attraverso le lingue e i Paesi in cui hai vissuto?
Sono contento che tu mi abbia posto questa domanda, perché ti devo dire che amo essere americano e lo sono molto. Proprio il conoscere altri posti mi ha messo a mio agio con il fatto di essere americano. Quando ho lasciato il Paese, a diciannove anni, non ne potevo più: era difficile essere gay negli USA, e andando in Europa ho pensato che sarebbe stato più facile. Be’, non lo è, non lo è per niente. Anzi, in alcuni Paesi è anche peggio, e l’Italia credo che rientri tra questi. In Russia è peggio ancora. Comunque: quando cresci, ti viene insegnato che gli Stati Uniti sono il posto migliore dove vivere, ma appena ho messo piede in Germania sono rimasto assai colpito dalla bellezza, dalla storia, dalla lingua, dalla gente… Ci sono tantissimi posti dove si può essere felici e vivere bene, e questa per me è stata una grande scoperta. Non sono antiamericano: amo gli Stati Uniti, è bello viverci, c’è un clima rilassato ed è più facile fare quello che vuoi. In alcuni Paesi europei si sente molto il peso della tradizione sul futuro dei giovani: in Germania se vuoi frequentare il Gymnasium devi deciderlo molto prima. La direzione da prendere si stabilisce in giovane età, e credo che sia difficile per molti. Tuttavia ci sono moltissime cose che odio degli Stati Uniti. La politica è disgustosa, il sistema sanitario è vergognoso: ci dicono che sia il Paese più bello dove vivere, eppure non si prende cura della sua gente. Ci sono mendicanti e senzatetto a ogni angolo: è triste. Insomma, ci sono cose orribile ovunque. Londra, Londra sì che è dura. Cazzo, c’è dolore, povertà, una gioventù distrutta… Ci sono estremi di bellezza e disperazione: molte delle persone migliori che conosco vengono da lì, ma Londra è un casino, peggio di New York. Ho vissuto anche a New York, per tre anni, ma Londra è più brutale, è gigante, ti sfianca. Comunque, tornando alla tua domanda: sono contento di essere americano, ma non sono sposato agli Stati Uniti. Non mi piace il patriottismo, perché spesso è solo un altro modo per dire nazionalismo, per dire “Il mio Paese non sbaglia mai”, il che è ridicolo. Sono orgoglioso di essere americano, ma amo anche altri posti, parlare altre lingue, vedere altre bellezze… Sono nato per andare in giro per il mondo.
L’ultima domanda è banale: ci dici i tuoi cinque dischi dell’isola deserta?
Odio questo tipo di domande, perché sono difficili, ma in fondo mi divertono. Credo che mi porterei un disco di musica classica, gli Studi per Piano di Chopin. Stella degli Yello. E poi Touch degli Eurythmics, quello con “Here Comes the Rain Again”; Voulez-Vous degli Abba e i Kraftwerk, con The Man Machine.


 Non riesco ancora bene a farmi un’opinione su quello che è accaduto a Roma sabato scorso: pensadoci, sono ancora pervaso dall’ansia che avevo mentre ascoltavo la diretta di Popolare Network (quanto sono bravi i miei colleghi?). Ma in rete pare che ognuno dica la sua, soprattutto quando a Roma non c’era, quel pomeriggio.
Non riesco ancora bene a farmi un’opinione su quello che è accaduto a Roma sabato scorso: pensadoci, sono ancora pervaso dall’ansia che avevo mentre ascoltavo la diretta di Popolare Network (quanto sono bravi i miei colleghi?). Ma in rete pare che ognuno dica la sua, soprattutto quando a Roma non c’era, quel pomeriggio.