Dagli archivi: Black Sabbath, Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO) – 18 giugno 2014
 Dopo l’annullamento della data di Milano, i Black Sabbath riempiono il Palasport di Casalecchio proponendo un live potente, dall’impatto visivo tutto sommato sobrio, ma efficace. C’è la musica e la presenza. E una scaletta che guarda al primo lustro di produzione della band, o poco più.
Dopo l’annullamento della data di Milano, i Black Sabbath riempiono il Palasport di Casalecchio proponendo un live potente, dall’impatto visivo tutto sommato sobrio, ma efficace. C’è la musica e la presenza. E una scaletta che guarda al primo lustro di produzione della band, o poco più.
“I can’t fuckin’ hear you”, ripete infinite volte Ozzy Osbourne agli undicimila che affollano il palasport alle porte di Bologna: insieme a lui i fedeli Geezer Butler al basso e Tony Iommi alla chitarra, dietro il tecnicissimo e potente Tommy Klufetos, batterista tra gli altri anche di Rob Zombie e dello stesso Ozzy. Il leader di una delle band più influenti e importanti degli ultimi cinquant’anni o giù di lì cerca continuamente il coinvolgimento della folla, non sempre caldissima, per quanto estasiata di vedere tre quarti dei Black Sabbath suonare bene per un’ora e quaranta.
A partire da “Iron Man”, per finire con “Paranoid”, impressiona infatti vedere quanto la band regga la prova con il tempo. La scaletta percorre i primi titoli della discografia degli inglesi, scegliendo tra le ultime canzoni solo il primo singolo di 13, “God Is Dead”: un’anomalia, confrontando le setlist di questo tour. Ma è confermato, anche nell’unica data italiana, il trittico “Black Sabbath”, “Behind the Wall of Sleep” e “N.I.B.”: una triade che segna il picco assoluto del concerto, suonata benissimo e cantata bene.
Già, perché, se proprio vogliamo trovare un problema, sta nella voce di Ozzy, ovviamente, spesso non all’altezza (anche nel senso proprio di intonazione) delle prove degli altri tre, davvero eccellenti. D’altro canto, l’ex-macellaio di Birmingham non è mai stato un cantante vero, no? Fa quello che deve fare: compare vestito di nero mantello, che abbandona presto, introduce “Snowblind” (quella che fa cantare a tutti “Cocaine”) rassicurandoci che quelle cose non le fa più, agita le braccia (non proprio agilmente), abusa di f-words, ci dice che siamo i numeri uno. E ripete che non ci sente urlare abbastanza, appunto. Arriva quasi a essere minaccioso, verso la fine del live: ma quando parte “Children of the Grave”, non c’è bisogno che ci ordini che dobbiamo diventare matti. Lo diventiamo.
Un “Let’s go fuckin’ crazy” introduce anche “Paranoid”: no, a dire la verità la canzone, creata come riempitivo del secondo album e diventata il più grande successo della band, è preceduta dall’intro di “Sabbath Bloody Sabbath”. Come a dire: “Abbiamo un repertorio talmente vasto di grandi pezzi che possiamo farne ciò che vogliamo”. Chapeau.
Recensione pubblicata originariamente sul numero di luglio 2014 de Il Mucchio Selvaggio

 Chissà cos’è successo di felice al siciliano Davide Iacono: il titolare del nome Veivecura, infatti, ha pubblicato quattro anni fa Sic Volvere Parcas, primo capitolo piuttosto scuro di una trilogia che è proseguita nel 2012 con le aperture di Tutto è vanità e si conclude oggi con Goodmorning Utopia. Ce lo chiediamo perché i toni di questo ultimo bel disco sono decisamente più solari e pacificati di quanto siamo stati abituati a sentire. Costruito intorno a sei canzoni più tre suite divise in parti e intitolate “Utopia”, l’album si concede derive decisamente più libere e leggere del solito, come in “Utopia I-II-III” dove compare anche un sax, o nella riuscita (e pop) “Oxymoron”.
Chissà cos’è successo di felice al siciliano Davide Iacono: il titolare del nome Veivecura, infatti, ha pubblicato quattro anni fa Sic Volvere Parcas, primo capitolo piuttosto scuro di una trilogia che è proseguita nel 2012 con le aperture di Tutto è vanità e si conclude oggi con Goodmorning Utopia. Ce lo chiediamo perché i toni di questo ultimo bel disco sono decisamente più solari e pacificati di quanto siamo stati abituati a sentire. Costruito intorno a sei canzoni più tre suite divise in parti e intitolate “Utopia”, l’album si concede derive decisamente più libere e leggere del solito, come in “Utopia I-II-III” dove compare anche un sax, o nella riuscita (e pop) “Oxymoron”. C’è più psichedelia nel pur ricco elenco di ingredienti a cui attinge la musica dei Bo Ningen, quartetto giapponese di stanza a Londra: si intuiva qualcosa già dall’uscita di “DaDaDa”, uno dei brani più interessanti, nonché apertura, di III. Poliritmico, con voci che si intersecano e si richiamano, fa pensare agli Animal Collective, ma non è questa l’unica direttiva del terzo album della band, non così lontano dal precedente Line the Wall. Per esempio ritorna la voce di Jehnny Beth delle Savages, in “CC”, uno dei due brani in inglese (sì, per la prima volta un album dei Bo Ningen non è tutto in giapponese); l’altro è la bella “Silder”, dove canta Roger Robinson dei King Midas Sound.
C’è più psichedelia nel pur ricco elenco di ingredienti a cui attinge la musica dei Bo Ningen, quartetto giapponese di stanza a Londra: si intuiva qualcosa già dall’uscita di “DaDaDa”, uno dei brani più interessanti, nonché apertura, di III. Poliritmico, con voci che si intersecano e si richiamano, fa pensare agli Animal Collective, ma non è questa l’unica direttiva del terzo album della band, non così lontano dal precedente Line the Wall. Per esempio ritorna la voce di Jehnny Beth delle Savages, in “CC”, uno dei due brani in inglese (sì, per la prima volta un album dei Bo Ningen non è tutto in giapponese); l’altro è la bella “Silder”, dove canta Roger Robinson dei King Midas Sound. Il secondo disco dei portoghesi Paus nasce sotto l’egida del prestigioso Primavera Sound, che ha ospitato per due edizioni di seguito i musicisti di Lisbona e che fa uscire questo album sotto la sua etichetta. Il quartetto ha una peculiarità: ci sono due batteristi che suonano lo stesso set (“siamese”, con la cassa in comune) uno di fronte all’altro. Clarão, però, non è un disco di puri ritmi, sebbene i battiti siano al centro delle dieci tracce che lo compongono. E non è neanche un album strumentale, per quanto le voci siano filtrate, spezzettate, usate come suoni in mezzo a chitarre, bassi e synth.
Il secondo disco dei portoghesi Paus nasce sotto l’egida del prestigioso Primavera Sound, che ha ospitato per due edizioni di seguito i musicisti di Lisbona e che fa uscire questo album sotto la sua etichetta. Il quartetto ha una peculiarità: ci sono due batteristi che suonano lo stesso set (“siamese”, con la cassa in comune) uno di fronte all’altro. Clarão, però, non è un disco di puri ritmi, sebbene i battiti siano al centro delle dieci tracce che lo compongono. E non è neanche un album strumentale, per quanto le voci siano filtrate, spezzettate, usate come suoni in mezzo a chitarre, bassi e synth.
 Dieci anni fa un ep, quindi l’album I’m the Creature, premio Fuori dal Mucchio per il migliore esordio. Poi nulla fino allo scorso giugno, quando è comparsa “Volunteer”, ora posta a chiusura di A S I M O / I, l’atteso ritorno dei MiceCars. “You should not play with my heart tonight / And praise our love with another lie”, dice la canzone: le parole e il cantato in falsetto rimandano al 2004, ma Little P. e Peter T. (che suonano insieme ad Andrea Mancin, Oliviero Farneti, Pasquale Citera e Marco Caizzi) sono ancora più disillusi e amaramente ironici sin dall’apertura “Mutual Destruction Assistance”, che riporta alla sfera intima e relazionale l’annientamento reciproco paventato nell’era nucleare richiamato dal titolo.
Dieci anni fa un ep, quindi l’album I’m the Creature, premio Fuori dal Mucchio per il migliore esordio. Poi nulla fino allo scorso giugno, quando è comparsa “Volunteer”, ora posta a chiusura di A S I M O / I, l’atteso ritorno dei MiceCars. “You should not play with my heart tonight / And praise our love with another lie”, dice la canzone: le parole e il cantato in falsetto rimandano al 2004, ma Little P. e Peter T. (che suonano insieme ad Andrea Mancin, Oliviero Farneti, Pasquale Citera e Marco Caizzi) sono ancora più disillusi e amaramente ironici sin dall’apertura “Mutual Destruction Assistance”, che riporta alla sfera intima e relazionale l’annientamento reciproco paventato nell’era nucleare richiamato dal titolo.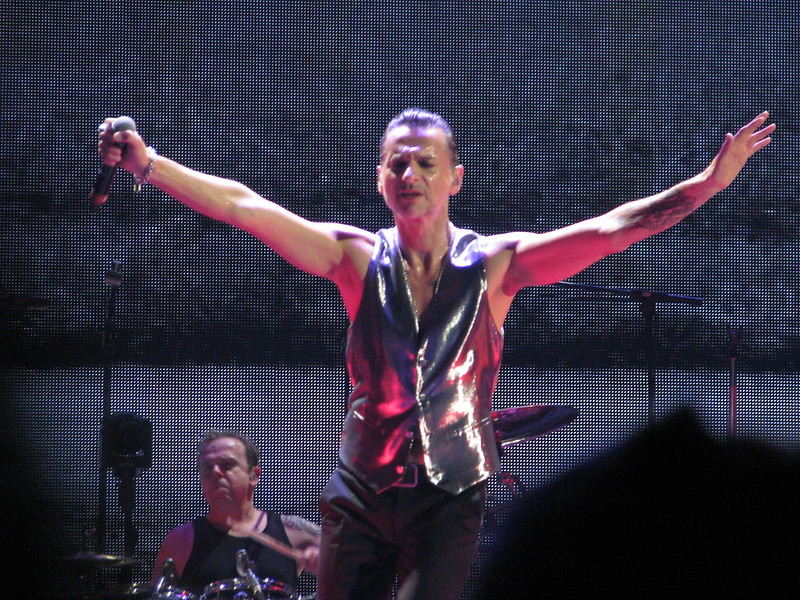

 Ogni volta che riascolto dall’inizio alla fine l’ultimo disco dei Thee Silver Mt. Zion ho una reazione fisica: un brivido che sale per scoppiare puntuale intorno al secondo minuto e mezzo della penultima traccia, “
Ogni volta che riascolto dall’inizio alla fine l’ultimo disco dei Thee Silver Mt. Zion ho una reazione fisica: un brivido che sale per scoppiare puntuale intorno al secondo minuto e mezzo della penultima traccia, “