Raccontare con gli arrangiamenti: intervista a Matthew E. White

Big Inner è uno dei dischi dell’anno scorso che mi sono un po’ sfuggiti: capita di appuntarsi mentalmente di ascoltare un album che poi, per un motivo o per un altro, non riesce mai a meritarsi il tempo necessario ad apprezzarlo. Qualche tempo fa, finalmente, mi ci sono messo e l’ho ascoltato più volte da cima a fondo. Ciò che mi ha fatto impressione è stato il primo approccio. Mi ha fatto tornare in mente What’s Going On di Marvin Gaye: gli strumenti che arrivano un po’ alla volta, senza una intro vera e propria, come se l’ascoltatore entrasse gradualmente in una casa dove già si suona, scoprendo la musica che viene da dentro un po’ alla volta. Quest’immagine mi è rimasta impressa nella mente fino a quando ho incontrato Matthew E. White in un albergo di Barcellona: il musicista era là per un concerto al Primavera Sound. E quindi l’intervista è iniziata con questo parallelo tra i due dischi che, l’avrei capito alla fine della chiacchierata, non era poi così peregrino.
Se Gaye si poneva delle domande sulla violenza e sui violenti cambiamenti della società degli anni ’70, c’è una domanda che Big Inner si fa o fa al suo pubblico di ascoltatori?
No, non in senso proattivo: non credo ci sia un tema dominante o una domanda che viene posta lungo il disco, oppure se c’è è qualcosa di inconscio. Non ho scritto l’album con grandi temi in mente: dopo averne parlato con un po’ di gente, ritengo che ci sia un senso di speranza opposto al turbamento. Èin effetti un argomento importante, ma ancora una volta è stato qualcosa di inconscio, non il risultato di un tentativo di fare emergere quel messaggio.
Quando hai capito che era arrivato il momento di realizzare il tuo disco? È stata solo una questione materiale, di tempo, oppure c’è stato qualcosa di più profondo che ti ha spinto?
Credo che sia dipeso dal rapporto con la comunità nella quale vivo. Per dieci anni sono stato prima uno studente all’università, poi una specie di organizzatore con ruolo da promoter e quindi ho messo in piedi la mia prima jazz band… Con queste esperienze ho pensato che sarebbe stato bello creare un’etichetta discografica che fosse basata sull’idea di fare musica insieme alle persone con le quali già la facevo: si trattava di dare un nome a tutto questo e di organizzarsi meglio. Quando l’ho fatto, ho chiamato l’etichetta Spacebomb ed è cominciato un processo che mi ha portato a pensare che forse dovevo uscire io per primo, che io dovevo essere la prima persona a provare quello che cercavo di realizzare: soprattutto perché, se fosse andata male, ci sarei andato di mezzo solo io, visto che l’idea era mia. Insomma, non si è trattato di una reale scelta forte, quanto di una serie di eventi che sono successi in molto tempo e che mi hanno naturalmente portato a fare un disco. Ecco, penso che sia il modo più facile per spiegarlo.
La Spacebomb è un altro esempio, come ce ne sono negli Stati Uniti, ma anche nel Regno Unito, di etichetta-collettivo, un po’ famiglia, un po’ legata ai rapporti di amicizia, oltre che di lavoro. Ci racconti di più?
Guarda, io vengo da Richmond, in Virginia: è un posto che ha una tradizione, dove vivono musicisti e da dove altri musicisti provengono. Tuttavia penso che negli ultimi dieci anni abbia acquisito uno slancio particolare: gente con cui andavo a scuola ha deciso di rimanere invece di spostarsi altrove. Penso che ciò che rende una comunità speciale non sia il decidere consciamente di fare qualcosa insieme, ma il valore di ciò che si fa insieme. Chiunque può dire con i suoi amici “facciamo musica insieme”, ma è ancora meglio fare buona musica insieme. Molti a Richmond hanno detto “stiamo qua e facciamo musica” e credo che ciò che hanno prodotto (e non parlo solo di Big Inner) sia qualcosa di davvero molto speciale. È un posto speciale perché abbiamo deciso di rimanerci, ma anche perché la musica che facciamo lo è. È la musica che possiamo fare solo noi, questo gruppo di persone… Ed è un gruppo nutrito, siamo in 30-40, interagiamo tra noi, è davvero bello farne parte: in questo momento io sono un leader, nel senso che ho la possibilità di andare in giro per il mondo e parlare con te e altri di cosa facciamo. Per esempio il mio amico Reggie… Eravamo in una band insieme e poi l’ha voluto Bon Iver nella sua per il tour. Quindi prima c’era lui a girare, a fare da predicatore per Richmond, ora tocca a me… È stato divertente farlo negli ultimi due o tre anni: questa piccola comunità ha avuto modo di viaggiare ed è bello che sia stata notata sempre di più.
Pensi che fare base a Richmond faccia un’enorme differenza rispetto a vivere a Los Angeles, New York o Austin, che sono città di riferimento per la cosiddetta scena indipendente statunitense?
Sai, in realtà credo che quello che è accaduto negli ultimi anni con internet e i media digitali abbia decentralizzato l’industria. Certo, gli uffici delle case discografiche sono a New York e Los Angeles, ma il modo in cui lavorano i direttori artistici, l’andare nei club, non è più lo stesso. Le cose si muovono e, insomma, non ho trovato alcun reale svantaggio a stare dove sono, anzi! Lo dico spesso, ma non potrei fare altrove quello che faccio. E non sto a Richmond perché voglio stare a Richmond, ma perché Richmond è l’unico posto dove posso fare la musica che voglio, questo è ciò che la rende unica. Non è questione di orgoglio o di avere molti amici in città: ci vivo perché è ciò che è più giusto che faccia per la mia carriera. Non potrei trasferirmi a Austin, Los Angeles o New York e continuare con la musica che faccio.
Torniamo al disco: c’è spesso un contrasto tra ciò che canti e il modo in cui lo fai. È una scelta precisa o deriva solo dal tuo stile e quindi canteresti a proposito di qualsiasi argomento così?
Ancora una volta, non credo che si tratti di qualcosa di intenzionale. O meglio, lo è nel senso che il modo di cantare che ho e di affrontare i temi che ci sono nel disco mi rispecchia molto come persona. Ho uno stile vocale che uso e mi è capitato di scoprire che mi si adatta bene. Quindi per me c’è una bella corrispondenza tra come sono qui, mentre ti parlo, e come sono sul palco: non ci sono maschere da indossare. Questo è molto bello e mi permette di scrivere di alcuni argomenti su disco. È per me qualcosa di molto personale, introspettivo e intimo. D’altro canto questo mi permette di esprimere emozioni più grandi con i suoni, la musica, gli arrangiamenti. Così si può raccontare una storia a tre dimensioni o raccontarne due: da un lato cantando, diciamo, in maniera piatta, o non troppo emotiva e rilassata. Dall’altro ci sono questi grandi arrangiamenti che rappresentano l’altro lato della narrazione. È significativo, perché se cantassi la stessa canzone al piano o alla chitarra si perderebbe la natura tridimensionale della storia, e questa è la peculiarità di lavorare con gruppi numerosi di persone e arrangiamenti estesi: si può raccontare molto della storia senza farlo propriamente.
Si è parlato del tuo album anche come un disco gospel, ma in un brano dubiti della tua stessa fede. Qual è il tuo rapporto con la religione e il cristianesimo? So che i tuoi genitori hanno a che fare con questo e vorrei saperne di più.
Sì, sono cresciuto in un ambiente molto religioso, molto cristiano. I miei genitori erano missionari oltreoceano e tutto questo ha fatto parte della mia vita a lungo. Da dieci anni a questa parte, però, ho intrapreso il mio viaggio, qualunque sia: talvolta ci sono molti dubbi, talvolta non mi sento a mio agio con alcune delle ripercussioni che la fede porta con sé, ma ci sono diverse cose del mio passato che rispetto molto. Penso che tutti abbiano un percorso di fede, unico, basato su come hanno affrontato alcuni eventi: è un lungo viaggio. Per me si è trattato di documentare questo sul disco e affiancare questioni religiose di fede ad altre cose, perché la nostra vita è così. Qualunque cosa facciamo, che sia stupida, formativa, importante, è affiancata da un lato spirituale: devo essere sincero e dire che questo fa parte della mia vita così come lo è una brutta relazione, o la morte di qualcuno. Si tratta di creare un dialogo onesto, che rifletta un po’ anche il mio percorso.
Un altro riferimento forte legato al disco è quello con la musica nera, con etichette quali Atlantic, Stax, Motown, insieme alla cosiddetta “americana”: ascolti questi generi?
Sì, sono davvero le prime cose che ho ascoltato. La musica afroamericana dai primi del ‘900 agli anni ’80 è ciò che ascolto, che amo: il ragtime, il jazz di New Orleans, l’R&B, il soul… Tutto questo viaggio, la storia della musica americana che ha fatto il giro del mondo, è così influenzato dalla musica afroamericana; se poi pensiamo anche alla musica folk e a come si è sviluppata nel rock and roll… Per me è la musica migliore del mondo, e sono felice che tu abbia citato la Atlantic perché di solito tutti parlano della Motown e della Stax, ma per me la musica migliore di quegli anni è della Atlantic. È la migliore etichetta di sempre, fosse anche solo per tutta la musica che ha pubblicato, per come fosse sempre avanti agli altri. Adoro le loro cose, sono un grande fan della loro musica, quindi… non posso dire di non ascoltarla (ride).
Torniamo al tuo passato: riesci a raccontarci la tua prima memoria musicale?
Sì, i miei avevano due cassette che ascoltavo: un greatest hits dei Beach Boys e uno di Chuck Berry. Le ho scoperte da piccolo e me ne sono innamorato. Mi ricordo che ero alla Filippine, seduto sul divano con un registratore e premevo play e poi rewind e ascoltavo quelle cassette di continuo…
Abbiamo parlato di musica e radici musicali americane, ma tu hai vissuto qualche anno appunto nelle Filippine. C’è mai stata nella tua testa la sensazione di uno scontro tra la cultura che vedevi intorno a te, quella dei tuoi genitori. La cultura con la quale sei stato cresciuto non era quella nella quale vivevi: un fattore che apre la mente, ma che può anche portare a disagi…
Sì, crescere oltreoceano… Non è che poi là pensassi in questi termini, non avevo una tale consapevolezza, ma una cosa interessante è successa quando sono tornato a casa, negli Stati Uniti: la cultura americana, le canzoni… Tutto è di più: l’aria è più pulita, ci sono i condizionatori, il traffico è incasinato, alla radio parlano del tempo… È casa. C’è una distanza che ti permette di vedere la natura unica di una serie di cose. Vivere identificando la propria casa con gli Stati Uniti è qualcosa di peculiare, anche se io mi sono sempre sentito un po’ un outsider, perché non è lì che ho vissuto i miei primi cinque anni… cioè, otto, a dire il vero. È interessante essere un outsider da un lato, e d’altro canto identificarsi molto con gli Stati Uniti: i miei vengono dal sud del Paese, le loro radici sono lì. Quindi per me è stato molto bello essere conscio delle mie origini, ma allo stesso tempo non esserne completamente preso. Ho fatto il disco, e non è un disco di musica “southern”, o di “americana”: è solo quello che ho fatto, ed è bello che non sia associabile del tutto ai luoghi da dove provengo. Non so se quello che ho detto ha senso, ma comunque: ci sono dei vantaggi a essere cresciuto oltreoceano e a tornare poi a casa. Dà libertà, anche nel modo in cui vedi la tua musica.
Non so se l’intervista ti sia piaciuta finora, ma la facciamo crollare: mi dici i tuoi cinque dischi da isola deserta?
Uno è il best of degli Staples Singers degli anni su VJ… Un box… La musica che hanno inciso per la VJ prima di passare alla Stax. È la musica più bella che sia mai stata fatta, secondo me… What’s Going On di Marvin Gaye. Qualcosa di Ray Charles…
Tipo Modern Sounds in Country & Western Music?
Sì, Modern Sounds in Country & Western Music. Good Old Boys di Randy Newman… Ho bisogno di qualcosa di New Orleans… Life, Love & Faith di Allen Toussaint, uno dei suoi primi dischi. Quindi, ce n’è uno di New Orleans, uno di Ray Charles, uno di Randy Newman, uno di Staples Singers…
… e Marvin Gaye, con cui abbiamo iniziato l’intervista: il cerchio si chiude.
Sì, è vero. Ecco fatto!
Sul sito di Maps trovate l’intervista audio.

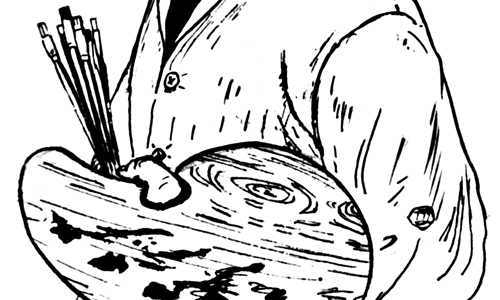

 Brian Wilson non ce la fa. E qui scatta la commozione, perché uno dei veri geni della musica americana non ce la fa più, nonostante sia coetaneo di McCartney, Bowie, Jagger, gente che salta, canta, balla. Lui non ce la fa, e si vede. Sta seduto, agita le mani come farebbe un vecchio nonno un po’ rimbambito, legge le parole sugli schermi che ha davanti.
Brian Wilson non ce la fa. E qui scatta la commozione, perché uno dei veri geni della musica americana non ce la fa più, nonostante sia coetaneo di McCartney, Bowie, Jagger, gente che salta, canta, balla. Lui non ce la fa, e si vede. Sta seduto, agita le mani come farebbe un vecchio nonno un po’ rimbambito, legge le parole sugli schermi che ha davanti. prima, probabilmente, per il peso di un padre-padrone-manager ossessivo. Poi, per i Beatles: diciamocelo, ma vi rendete conto, soffrire per i Beatles? Voglio dire, hanno provato questo lui, Pete Best (il loro primo batterista) e Stuart Sutcliffe (mollato prima di incidere il primo disco). Wilson soffre perché sente che, dall’altra parte dell’oceano, c’è qualcuno che fa musica in maniera geniale. Esce Rubber Soul, nel 1965, e lui dice: “Minchia!” (probabilmente). E poi aggiunge: “Adesso vi faccio vedere io.” E sforna quel capolavoro che è Pet Sounds. Tre mesi dopo i Beatles fanno uscire Revolver. Dieci mesi dopo ancora, Sgt. Pepper’s. E Brian crolla, letteralmente.
prima, probabilmente, per il peso di un padre-padrone-manager ossessivo. Poi, per i Beatles: diciamocelo, ma vi rendete conto, soffrire per i Beatles? Voglio dire, hanno provato questo lui, Pete Best (il loro primo batterista) e Stuart Sutcliffe (mollato prima di incidere il primo disco). Wilson soffre perché sente che, dall’altra parte dell’oceano, c’è qualcuno che fa musica in maniera geniale. Esce Rubber Soul, nel 1965, e lui dice: “Minchia!” (probabilmente). E poi aggiunge: “Adesso vi faccio vedere io.” E sforna quel capolavoro che è Pet Sounds. Tre mesi dopo i Beatles fanno uscire Revolver. Dieci mesi dopo ancora, Sgt. Pepper’s. E Brian crolla, letteralmente. Tutto questo, badate bene, scrivendo canzoni che, perdonatemi la banalità, appena iniziano fanno spuntare sorrisi e bermuda a chiunque.
Tutto questo, badate bene, scrivendo canzoni che, perdonatemi la banalità, appena iniziano fanno spuntare sorrisi e bermuda a chiunque.