Dell’accettazione della vita: intervista a John Grant su Pale Green Ghosts
“Buongiorno, Francesco”, mi dice John Grant al telefono, lunedì scorso. Mi saluta in italiano, perfetto nell’accento, e sarei tentato di sapere se ha deciso di includere anche la nostra lingua tra quelle che già padroneggia (sono almeno cinque o sei). Ma proseguiamo la telefonata in inglese. Pale Green Ghosts, il secondo album solista del musicista, dopo l’esperienza con gli Czars, viene pubblicato il giorno dopo (martedì) ed è uno dei dischi più attesi di questo inizio 2013. La prima traccia, quella che dà il titolo al lavoro, ha disatteso ogni aspettativa: i battiti di Biggi Veira (degli islandesi Gus Gus) pulsano contro il ricordo delle armonie e degli arrangiamenti dei Midlake, che avevano accompagnato le canzoni di Queen of Denmark, uscito nel 2010. Dopo i primi ascolti dell’album, però, mi tornano in mente due cose che John mi aveva detto alla fine del 2011, nel camerino del Covo. La prima è che il disco successivo a Queen of Denmark sarebbe stato autobiografico e con molta più rabbia, ironia e “vaffanculo”. La seconda: tra i dischi dell’isola deserta scelti da Grant in quel pomeriggio del novembre di due anni fa c’erano Stella degli Yello, Touch degli Eurythmics, Voulez-Vous degli Abba e The Man Machine dei Kraftwerk. Gli ricordo queste sue affermazioni ed esclamo “Ora tutto mi è chiaro”. Lui ride, in quel modo sincero e profondo che comparirà un altro paio di volte nella ventina di minuti passata insieme al telefono. Iniziamo quella che, come sempre con Grant, non è una semplice intervista, ma una specie di chiacchierata intima, quasi confessionale.
Hai usato l’ironia in Pale Green Ghosts per stemperare la rabbia così presente nel disco o è qualcosa che avresti usato comunque?
No, lo faccio sempre, nella vita di tutti i giorni: penso sia naturale per me usare l’ironia anche nelle canzoni. Non si possono prendere le cose troppo seriamente, altrimenti è impossibile godersi la vita. In ogni caso, lo humour nero è una parte molto importante della mia personalità: è sempre stato, o almeno è stato in parte, un forte meccanismo di difesa per me. Credo sia proprio il modo che ho di affrontare le cose.
Hai scelto due pezzi molto elettronici, la title track e “Black Belt”, come anteprime del disco: questo perché volevi mettere una distanza netta tra l’ultimo e Queen of Denmark?
Sì, in un certo senso… Diciamo che sono le canzoni che meglio definiscono il tono del disco, non solo dal punto di vista musicale, ma anche tematico. In particolare “Pale Green Ghosts” è quella che rappresenta meglio l’album anche per quanto riguarda i testi: parla della mia adolescenza. Queen of Denmark riguardava la mia infanzia, negli anni ’70; questo disco invece ha più a che fare con l’adolescenza e gli anni ’80. Ho scelto quelle canzoni perché per me sono più rappresentative della altre, ma sono comunque molto fiero di “Pale Green Ghosts” perché è come annunciare che si tratta di un disco che non è lo stesso, che non è quello che avete sentito la volta scorsa. Ne sono orgoglioso, volevo esporla, come quando si mette qualcosa di fronte alla finestra, o in vista, in modo tale che chiunque venga a trovarti la possa vedere. Una cosa così.
Il tuo approccio nel comporre i nuovi pezzi è stato diverso?
Sì, qualche volta. Per qualche brano ho fatto dei demo con Reason, sul mio computer, e con qualche altro programma elettronico. Non le ho scritte tutte al pianoforte, come ero solito fare, come è stato con i brani di Queen of Denmark. Sì, il processo è stato diverso: registravo i demo al computer, poi andavamo in studio ad ascoltarli e quindi Biggi cercava i suoni sui suoi strumenti; il responsabile della maggior parte dell’elettronica è lui, ma anche io ho programmato qualcosa.
La rabbia che si sente nelle tracce è spesso rivolta a un uomo, o forse a più uomini: sono quelli i fantasmi verde pallido di cui parli nella prima canzone? “Pale Green Ghosts” è il brano più evocativo, meno diretto, del disco.
No, i fantasmi verde pallido rappresentano qualcosa di positivo. Credo sia una metafora, intendo dal punto di vista figurativo, per cui si può dire che io stia anche parlando di fantasmi, ma in realtà in “Pale Green Ghosts” racconto di Denver e di come attraversavo la città sulla Interstate 25, guidando verso Boulder. Gran parte della rabbia del disco è rivolta verso una persona specifica o me stesso, ma i fantasmi verde pallido della canzone sono in realtà degli alberi ai lati della strada che percorrevo su e giù tutto il tempo. Anche allora era un periodo caotico, ma ci sono stati alcuni momenti di assoluta bellezza nell’adolescenza. Ecco, in “Pale Green Ghosts” io racconto uno di quei momenti: il guidare lungo l’autostrada, con l’aria tiepida tra i capelli, ascoltando il rumore dell’oceano alla radio. Sì, perché c’era questa stazione che talvolta trasmetteva delle cose per una settimana intera, come suoni dell’oceano. Comunque, i fantasmi sono degli alberi: in inglese si chiamano “olivo russo” [in italiano oleastri, ndr] e alla fine di maggio fanno dei piccoli fiori gialli che profumano in maniera incredibile, puoi sentirne la fragranza nell’aria. Insomma, ho cercato di fermare un momento, un momento felice della mia adolescenza: sembra una cosa semplice, ma è stato un periodo molto caotico.
Che mi dici del video? Oltre a recitarvi, hai partecipato alla sua ideazione?
Il video non rappresenta molto la canzone. Il regista ha scritto la sceneggiatura e io, niente, mi sono presentato sul set e ho fatto quello che mi dicevano di fare. Non so se capisci…
Sì, certo, le atmosfere del video e della canzone, per come l’hai raccontata, sono un bel po’ diverse!
Esatto! Ecco, non c’entra molto con la canzone… Il che, insomma, è una cosa un po’ disgraziata.
I film sono sempre presenti nelle tue canzoni: a questo proposito troviamo, tra le altre cose, un bel cambiamento in uno dei nuovi brani. Si va dal “qualche volta mi sento Sigourney Weaver” dell’album precedente a “cosa farebbe Ernest Borgnine” di Pale Green Ghosts: una bella differenza! Ma sono curioso di questa costante del “se fossi in un film”, che si ritrova nei due dischi…
I film sono una parte grande, molto grande della mia vita. Sono un grande fan di Woody Allen e mi piace parlare di cinema. Sono anche un fan di Ernest Borgnine e ho avuto l’occasione di incontrarlo una volta a New York, quattro, ormai cinque anni fa. Aveva appena compiuto 91 anni. Adoro parlare di film con la gente, è una delle cose che preferisco, è fonte di enorme piacere per me. Quindi il cinema deve fare parte anche della mia musica, perché fa molto parte della mia vita.
Come hai detto prima, oltre a un tu “altro” generico o specifico, spesso sei tu stesso il bersaglio della tua rabbia: sembra che lotti prima di tutto per venire a patti con la tua persona, con i tuoi errori, con il tuo dolore. Com’è mettere tutto questo in musica in maniera così diretta?
Farlo è molto importante per me. Passo molto tempo cercando di evitarmi, di scappare dai problemi e da me stesso, rifugiandomi nei film, nell’alcol, nella droga, nel sesso, eccetera. Cerco insomma di non affrontarmi. Quindi penso che per me sia decisivo affrontare di petto anche le piccole cose, in maniera netta e sincera. Non so, credo che mi aiuti. Per me buona parte dei sentimenti sta nella comprensione e il punto è che non capisco davvero bene cosa mi sia successo perché sia diventato quello che sono. Provo a capirlo, lo vorrei sul serio, ma spesso davvero non colgo quale sia la cosa giusta e quella sbagliata da fare. Tuttavia, alla fine di una giornata spesa a fare musica, non penso che ci sia il giusto e lo sbagliato. O quanto meno so che mi sono attenuto alla verità della situazione, di quello che sto facendo, capisci?
Sì, certo. Una famosa citazione di Keats dice che la bellezza è verità e che la verità è bellezza. Secondo te è così?
Non so dirti della bellezza, perché parlo molto anche di cose brutte. Ma direi che la vita è verità. Che la verità è vita.
Non pensi che comunque rappresentare artisticamente, diciamo, la bruttezza, magari parlandone in una canzone, sia un forma di bellezza? Lo so, è una banalità, ma si può parlare di una bella bruttezza, quando questa è rappresentata in una buona poesia o canzone…
Sì, credo che le persone siano affascinate dalla bruttezza, ma che in realtà non vogliano avere a che farci tutti i giorni. Insomma, è come se nella vita quotidiana le persone non vogliano considerare le cose brutte, ma quando le trovano nell’arte, nelle canzoni o nei film ne subiscono il fascino. Le guardano, ma non vogliono affrontarle nella normalità. Le trovano affascinanti, o meglio, le troviamo affascinanti quando sono poste a una certa distanza, quando hanno a che fare con qualcun altro o quando non le affrontiamo davvero ogni giorno. Credo che sia bellissimo riuscire a esprimere la verità di una situazione nella tua lingua, ma d’altro canto credo che sia difficilissimo: la verità non è affatto una cosa semplice da trovare, perché ha una prospettiva diversa sulle cose, un modo di guardarle differente.
Torniamo all’intervista di un po’ meno di due anni fa: mi hai detto che, dopo qualche tempo, sei riuscito a capire chi sei, almeno un po’ più di prima. Come ti senti ora, con un nuovo disco, la solita giostra di concerti, obblighi promozionali e stanze d’albergo? Come affronti nuovamente questa vita di vagabondaggi? Hai trovato un posto dove tenere tutti i tuoi libri e riposare?
Oh, sì, ormai vivo a Reykjavík, in Islanda, da più di un anno, ma i miei libri sono tuttora sparsi ovunque. Non sono riuscito a tornare in Texas per prenderli, non ce l’ho fatta a recuperare altri libri che ho a Denver, e ne sono rimasti un po’ in Svezia e a Berlino… Ora ho un posto dove tenerli e devo solo portarli là. (ride)
Ti voglio chiedere qualcosa a proposito di un’apparente contraddizione che puoi aiutarmi a capire meglio. Penso che la disciplina sia una delle qualità necessarie per fare musica, scrivere e registrare un disco. D’altro canto una delle cause di caduta e ricaduta nelle dipendenze è la mancanza di disciplina. Come si è combinato tutto questo in te?
Non penso di avere mai avuto tutta questa disciplina… Quando usavo droghe e bevevo molto non ne avevo proprio e questo era parte del problema. Ma in agosto è nove anni che sono sobrio. Ho realizzato Queen of Denmark da sobrio, e lo stesso vale per quest’ultimo disco. Ecco il punto: per me è molto facile essere disciplinato quando sto lontano da certe cose, perché se no prendo il largo. In realtà è complicato avere disciplina anche quando non ti droghi e non bevi, o almeno, per me è così: non sono mai stato tanto disciplinato, non ho mai imparato molto sull’argomento. Quindi combatto ogni giorno per esserlo, è una specie di lotta quotidiana che però permette di darti una certa struttura. Ho lavorato con Biggi in Islanda e lui ha una famiglia, tre figli e una moglie: quindi dovevamo iniziare alle nove o dieci del mattino, per andare avanti fino alle cinque, sei del pomeriggio. Un po’ come diceva Nick Cave: si va in ufficio ogni giorno. Per uno come me questo è buono. Da quando sono sobrio, inoltre, sono riuscito ad avere una sorta di etica lavorativa. L’anno scorso in Islanda avrei potuto fare un sacco di cose: mi hanno invitato a unirmi a viaggi, ad andare in altri posti, nelle case estive di certa gente, anche di fare delle gite in autostop, ma non ho fatto nulla di ciò, perché sapevo che avevo bisogno di rimanere concentrato sul disco. Mi sa che invecchiando sto diventando più disciplinato, o almeno riesco a obbligarmi ad esserlo quando ne ho bisogno.
L’ultima traccia del disco, “Glacier”, mi ha molto colpito: l’hai messa alla fine dell’album e sono rimasto a interrogarmi se quella del ghiacciaio che scava e distrugge la terra nutrendola al tempo stesso sia soltanto un pensiero, un’immagine in sé, o se fosse un modo per concludere positivamente il disco.
Ho scelto di metterla alla fine perché credo sia una canzone molto potente, così come la metafora che ci sta sotto: il dolore è qualcosa che ti trasforma così come il ghiacciaio cambia il territorio che attraversa, scavando, come dico nella canzone, “nuove vallate e spettacolari paesaggi”. Sì, è una specie di lieto finale: tutte le cose brutte che ti accadono possono essere usate in maniera buona nella vita, o almeno… Qualunque cosa si può prendere anche dall’altro verso e lasciare che ti distrugga, ma il disco gira interamente intorno al concetto di accettazione. Accettare la vita vuol dire anche accoglierne tutto il dolore, i momenti difficili e anche tutti i momenti in cui si compiono degli errori dei quali poi bisogna pagare le conseguenze: ma comunque la vita può essere bella e se ne può godere, imparare a viverla, a trarre piacere da ogni singolo giorno, anche se prima non lo sapevi fare. Diciamo che è un messaggio positivo dopo un disco particolarmente scuro.
Rimaniamo ancora un po’ a parlare di cinema e ci diamo appuntamento a Milano, per il concerto dell’11 aprile. Quando chiudo la telefonata penso che non abbiamo minimamente accennato all’ennesimo trauma della vita di Grant, che ha scoperto di essere sieropositivo proprio quando stava per mettersi al lavoro su Pale Green Ghosts: ma non serve. L’ultima risposta, così come l’ultima canzone del disco, sono sufficienti per comprendere la grandezza dell’uomo e del musicista. E capisco cosa mi ricorderò sempre di quest’intervista.
L’intervista audio è ascoltabile sul sito di Maps.


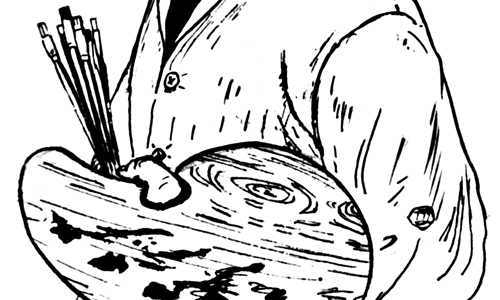

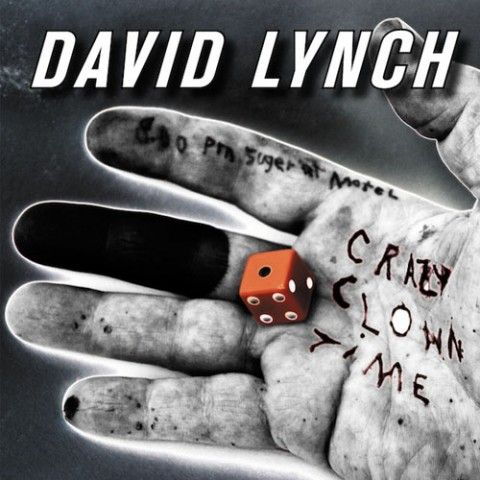 Esce oggi Crazy Clown Time, di
Esce oggi Crazy Clown Time, di  La voce di Lynch, quindi, è al centro di tutto, anche dell’ossessiva litania al vocoder di “Strange Unproductive Thinking”, del blues distortissimo di
La voce di Lynch, quindi, è al centro di tutto, anche dell’ossessiva litania al vocoder di “Strange Unproductive Thinking”, del blues distortissimo di