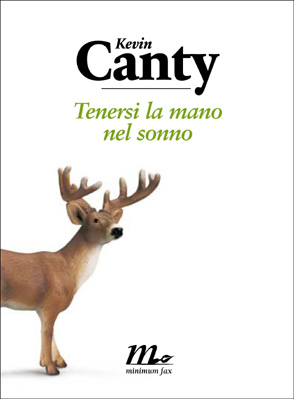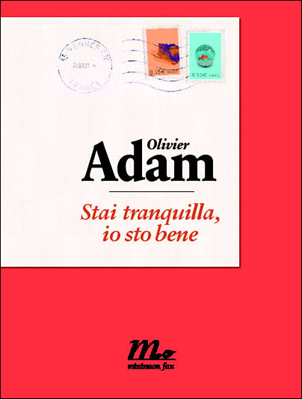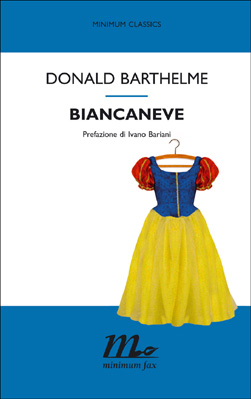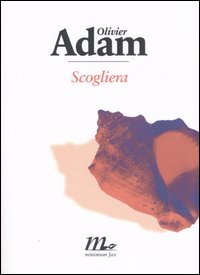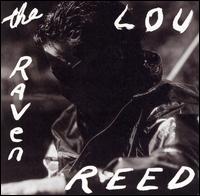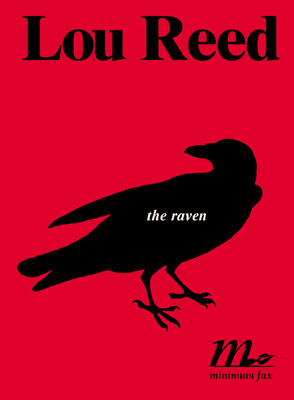Libri di passaggio
 Mi sono reso conto, cercando il post a tal proposito, che sono passati quasi tre anni da quando ho scritto del primo libro di Kevin Canty che mi sia passato sottomano, Tenersi la mano nel sonno. Rileggendo quelle parole ho percepito nuovamente la reale emozione che quel libro mi aveva dato. Dei racconti brevi e perfetti, come amo leggere e come raramente si trovano.
Mi sono reso conto, cercando il post a tal proposito, che sono passati quasi tre anni da quando ho scritto del primo libro di Kevin Canty che mi sia passato sottomano, Tenersi la mano nel sonno. Rileggendo quelle parole ho percepito nuovamente la reale emozione che quel libro mi aveva dato. Dei racconti brevi e perfetti, come amo leggere e come raramente si trovano.
Appena ho saputo dell’uscita, sempre per minimum fax, della nuova raccolta, mi sono precipitato a comprarla: ma ho concluso la lettura di Dove sono andati a finire i soldi solo ieri. Tra quando ho comprato il libro e quando l’ho finito, ho scoperto che Canty scrive anche romanzi. E che è il fratello di Brendan, il batterista dei Fugazi.
Il secondo elemento mi ha fatto sorridere, il primo, invece, mi è tornato in mente leggendo la nuova raccolta: il romanziere Canty si percepisce nell’arco di lettura. Mi spiego.
Gli uomini protagonisti di tutti i racconti vivono situazioni diverse, oltre ad essere descritti con tratti differenti. Sono però quasi tutti sopra i quaranta e si trovano nei guai: o meglio, noi li conosciamo quando si rendono conto della situazione difficile in cui si trovano. Li incontriamo mentre riaffiora il pensiero di un tradimento che si credeva sepolto, quando una difficoltà diviene un problema concreto e potenzialmente cronico, quando le cose si turbano all’improvviso, ma prevedibilmente, se uno ci avesse pensato.
Lo stile di Canty lega i personaggi, tanto da pensare che prima o poi questi si incontrino, magari per uscire dai momenti che le parole dell’autore rendono in maniera talvolta angosciante, ma sempre lucida e precisa. Si spera che si incontrino e che stiano bene, ma la maggior parte delle volte i finali delle storie che compongono la raccolta mi hanno fatto pensare a un’unica cosa. Che se fossi stato lì, con l’uomo che la maestria di Canty mi aveva fatto conoscere così bene in una manciata di pagine, sarebbe stato mettergli una mano sulla spalla e dirgli guardandolo negli occhi “Mi dispiace, davvero.”, trattenendomi dal pronunciare un’altra ovvietà: il rassicurarlo che, prima o poi, tutto sarebbe andato bene.
C’è qualcos’altro che, però, lega i racconti tra loro: l’attenzione che Canty ha per la descrizione dei paesaggi, quasi mai metropolitani. Dalle nevi della foresta boreale ai deserti del sud degli Stati Uniti, gli elementi naturali giocano un ruolo fondamentale anche in questo libro: tant’è che, in uno dei racconti più belli, dove questa dimensione è più assente, ti viene da pensare che il bambino figlio del protagonista, che ha iniziato a morsicare estranei e compagni di classe, sia un animaletto da curare, che segue un istinto insopprimibile ma che non può convivere con la società. Non è una caso che il racconto si intitoli “Non c’è posto per te a questo mondo”.
Una raccolta di racconti, dove si passa da uno all’altro senza interruzione: forse meno intensi di Tenersi la mano nel sonno, ma che dimostrano ancora una volta l’eccellente livello di Canty e che sembrano proiettare il lettore verso un romanzo che non esiste, o che forse, semplicemente, non ho ancora letto. La cosa buffa è che l’inizio del libro è affidato al racconto che dà il titolo alla raccolta: un vero e proprio trait d’union (o così mi voglio immaginare) tra la raccolta precedente e questa: sul sito di minimum fax si può scaricare per intero, qua.