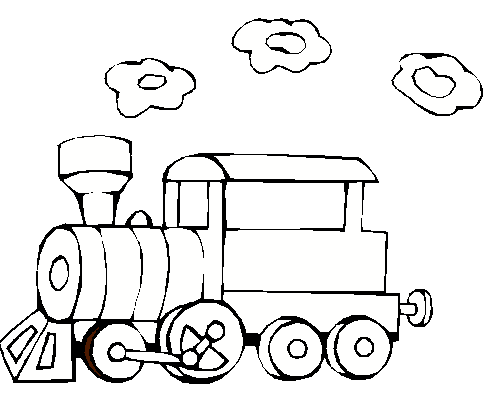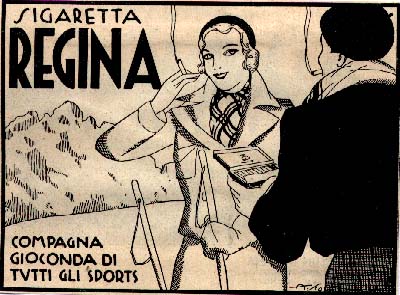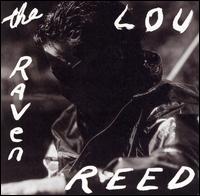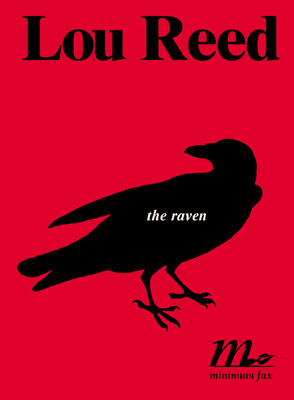L'umanità è bella perché è varia
Tornato dalla mia vacanza più lunga dopo quella di quest’estate, avrei voluto scrivere qua delle cose buffe e belle viste e sentite tra Venezia e Verona. O magari del fatto che mi sono fatto leggere per la prima volta i tarocchi, che mi hanno previsto un 2005 splendido. Sì, mi sto toccando, embè? Invece no.
No, perché ieri, nell’ultimo giorno di questa brevissima vacanza, ho assistito ad una serie di episodi orrendi e sussurrati, comuni e tremendamente fastidiosi. Piccoli come cellule tumorali, e con lo stesso potenziale distruttivo, proprio perché invisibili.
Un viaggio in autobus. In fondo ci sono dei ragazzi marocchini, giovani, sui quindici anni. Accanto a loro due ragazze loro coetanee, che sembrano marocchine anch’esse. Quando le due ragazze si avvicinano alla porta per scendere, i ragazzini iniziano a prenderle in giro. “Bum, bum Camerùn, meglio negro che terùn!”, “Dal Po in giù l’Italia non c’è più”, e cose del genere. Le ragazze un po’ sorridono, un po’ sono in imbarazzo. Poi iniziano a parlare tra loro e sento che sono meridionali. Una di loro dice ai ragazzi: “Ma proprio voi parlate”. Poi, rivolta all’altra: “Verona, non c’è niente da fare.” Il mio primo innocuo pensiero è “Ma guarda un po’ come si mescolano i tratti dei volti”. Il secondo pensiero è “Umanità di merda.”
Un altro viaggio in autobus, poco dopo. Una donna africana, vicino all’uscita, parla a voce alta con un uomo, nella sua lingua. Non si capisce se stiano litigando o se si stiano prendendo in giro. Altri passeggeri dell’autobus, rigorosamente italiani, quindi inclini di natura al silenzio e alla contemplazione, sbuffano e protestano. Un ragazzo accanto a me dice, a voce né troppo alta né troppo bassa: “Una bella pistola, quello ci vorrebbe, e… bam bam”. Affiora nella mia mente solo il secondo dei due pensieri di prima.
In stazione, meno di un’ora dopo, sono al bancone del bar, e sto per pagare una Coca. Arriva un signore, dal chiaro accento meridionale, e chiede con una certa arroganza di parlare con “il responsabile”. La signora alla cassa si gira verso di lui e chiede quale sia il problema. L’uomo, sempre con lo stesso tono, protesta dicendo che il caffè che gli è appena stato servito è troppo lungo, o troppo corto, non ho ben capito. Intanto dietro di me si forma una piccola coda. L’ultimo in fila, un ragazzo della mia età, protesta dicendo che certa gente dovrebbe smetterla di rompere le scatole in questo modo. La discussione tra il cliente e la barista continua, e accanto all’uomo arriva una donna, dai tratti nordafricani: evidentemente i due sono insieme, e forse il “problema” del caffè riguarda anche lei. Il ragazzo dietro di me continua: “Sicuramente quello là non è italiano”. Io mi giro e lo fisso, pensando a quanto noi italiani, effettivamente, siamo accomodanti sulla risoluzione di ogni tipo di problema. In quel momento l’uomo alza la voce, e si sente che parla evidentemente nella nostra bella lingua, anche se non con una cadenza che l’Accademia della Crusca approverebbe. Il ragazzo continua: “Certo, guarda con chi sta, con quella mezza araba del cazzo.” Solo a quel punto, un attimo prima che io dica qualcosa, l’uomo dietro di me lo zittisce come si direbbe ad un bambino di smetterla di fare dei versi. Io guardo il ragazzo, lui mi guarda, poi la signora torna alla cassa e pago. Non ci sono pensieri, nella mia testa.
L’epilogo di tutto questo si svolge un paio di ore dopo, in un autobus che sostituisce il tratto di treno dove è accaduto l’incidente di qualche giorno fa. Fuori è tutto buio, non si vede nulla, e mi sembra di stare fermo. Accanto a me, da una parte e dall’altra, due ragazze africane si preparano per una notte di lavoro. Una tira fuori un opuscolo dallo zaino. E’ il giornale dei Testimoni di Geova, in inglese. In quel momento l’orologio digitale in fondo al pullmann mi dimostra che il tempo scorre: scattano le ventidue e tre minuti dell’ottavo giorno dell’anno nuovo.