Non pensate di fare i fotografi: un consiglio di Kevin Cummins
Alla galleria Ono Arte di Bologna, fino al 20 novembre, sono esposte le foto di Kevin Cummins, uno dei nomi che meglio ha saputo raccontare il rock per immagini. Attivo dalla fine degli anni ’70, si fa prima a dire chi Cummins non abbia fotografato, negli ultimi quarant’anni: davanti alle sue lenti sono passati in tanti, da Bowie ai Pistols, dai Joy Division ai Buzzcocks, dai Fall ai New Order. L’ho intervistato per Maps: oggi pomeriggio potrete ascoltare la chiacchierata che abbiamo fatto, ma se siete curiosi, è pubblicata ora sul sito della trasmissione, doppiata e in lingua originale.
Parliamo degli inizi della tua carriera: quando hai scattato quella che secondo te è la prima delle fotografie per cui sei diventato famoso?
Quando studiavo arte a Manchester andavo ai concerti e scattavo delle foto per me stesso: era un modo per entrare gratis, nei primi anni ’70. Scattai una foto a David Bowie durante il tour di Ziggy Stardust: credo che sia stata quella a farmi pensare che fotografare poteva essere un modo per guadagnarmi da vivere. Quindi il mio prima scatto fu proprio Bowie dal vivo.
Com’era passare la barriera del palco? Il backstage è probabilmente uno dei luoghi in cui si può costruire un rapporto più intimo con il musicista.
Quando iniziò il punk, molta della scena era a Manchester. Io avevo sempre la macchina con me e Paul Morley, che scriveva per il New Musical Express, andava a tutti i concerti. Abbiamo pensato di dare alla stampa musicale inglese foto e parole per testimoniare il momento e credo che i Buzzcocks siano stati i primi con cui abbia lavorato a stretto contatto. Andavo spesso a trovarli, scattavo loro molte foto e provavo soluzioni diverse: loro non erano abituati a essere fotografati, io non lavoravo molto nel mondo del rock, quindi sia io che loro abbiamo sperimentato, cercando strade diverse. Un po’ alla volta ho così creato un portfolio. Quindi sì, penso che tutto sia cominciato con i Buzzcocks.
C’erano ostacoli tra te e gli artisti? Voglio dire che un giovane fotografo può incontrare delle difficoltà nell’accedere a luoghi privati…
No, in realtà credo che ci siano più ostacoli ora, in un periodo in cui chiunque può usare il cellulare e fare delle foto. All’epoca ce n’erano meno, anche perché eravamo tutti coetanei e perché avevo studiato fotografia: questo permise a molte band di avere da subito delle foto professionali e i gruppi erano contenti del mio lavoro. Quando ho cominciato a fotografare i Joy Division, ho avuto modo di dare loro qualcosa che allora non si potevano permettere.
Sei molto famoso per le tue fotografie dal vivo, ma hai scattato molte serie di bellissimi ritratti. Qual era il tuo metodo quando dovevi lavorare su quel tipo di fotografia, incontrando un musicista e fotografandolo a lungo?
Credo che il primo passo sia riconoscere quanto valga il loro tempo: intendiamoci, è prezioso quello di tutti, ma i musicisti hanno un’idea abbastanza idiosincratica del tempo. Talvolta si possono aspettare anche tre o quattro giorni prima di fare il primo scatto, fino a che sono felici di averti intorno: allora tiri finalmente fuori la macchina fotografica, rompendo allo stesso tempo la barriera che crea. I musicisti iniziano a reagire a una persona, non più a un obiettivo e non c’è problema se si gira intorno a loro non scattando una foto per ore. Può capitare che sia necessario aspettare una settimana per un grande scatto, ma talvolta ne vale la pena.
C’è qualcuno che hai dovuto fotografare e ne avresti fatto volentieri a meno e, viceversa, c’è qualche musicista che sei sempre felice di riprendere?
Di solito non sono costretto a fotografare persone che non mi piacciono: la mia è una posizione privilegiata. Ho avuto modo di lavorare con tante persone che apprezzavo, instaurando con loro un bel rapporto professionale. Se la band con cui lavori non ha rispetto di te come artista e, allo stesso modo, tu non rispetti loro, non verrà mai fuori una foto decente. L’unica band con la quale ho dovuto lavorare per un servizio del New Musical Express sono stati i Duran Duran: credo che non ri rispettassero l’un l’altro, quindi figuriamoci che rispetto potevano avere per me.
Tra tutti i concerti che hai visto in vita tua, ce ne sono un paio ancora ben presenti nella tua memoria per la loro importanza?
Penso che anche oggi i concerti possano essere interessanti, ma per dire i più ovvi, di certo quello dei Sex Pistols al Lesser Free Trade Hall di Manchester, un paio di concerti dei Joy Division e David Bowie nel periodo di Ziggy Stardust: momenti in cui pensi con enfasi che sia il giorno più bello della tua vita. In realtà, però, ce ne sono stati anche in tempi più recenti: ad esempio quando gli Oasis stavano davvero diventando grandi, andarli a vedere voleva dire esclamare “Mio Dio, c’è una stella enorme sul palco”. Sono cose che affascinano, ma talvolta è lo spettacolo stesso a fare effetto. Ricordo di avere visto Noel Gallagher a Londra un mese fa in un posto piccolissimo, da trecento persone, chiamato Dingwalls. Eppure era come se fosse grandissimo. Il punto è l’emozione: una volta che non c’è più, tanto vale non andare ai concerti.
Hai parlato di fotografia digitale, prima: che ne pensi e cosa pensi dei nuovi fotografi rock?
Io uso il digitale e non ho nulla in contrario. Non capisco però perché le persone si ostinino a usare i loro iPhone per scattare foto ai concerti. Non riusciranno mai a farne una bella così, così come non avranno mai dei video di buona qualità. Ho visto Jack White, sempre un mese fa e sempre a Londra: prima del concerto è salito uno sul palco ha detto di mettere via i cellulari, perché avrebbero pubblicato il concerto in mp3 un paio di giorni dopo insieme a delle foto del live di buona qualità. Insomma, ha detto a tutti di godersi lo spettacolo. E’ stato bellissimo, perché è davvero irritante quando vai a un concerto e davanti a te ci sono trecento persone con il loro telefono: non stanno avendo una bella esperienza live, non stanno nemmeno guardando il concerto, poiché lo fanno attraverso uno schermo. Meglio tenere il telefono in tasca e godersi il concerto.
Quale potrebbe essere un suggerimento per un giovane fotografo intenzionato a una carriera come la tua?
(ride) Non fatelo, non fatelo! Oggi è difficilissimo, perché ci sono così tanti mass media e così tanta gente che non vuole pagare per dei contenuti. Iniziare una carriera del genere per un giovane fotografo è veramente qualcosa di autodistruttivo, che non permette di sopravvivere. Io ho la fortuna di avere un archivio legato a un periodo in cui non si fotografava così tanto, ma oggi è dura, davvero dura.

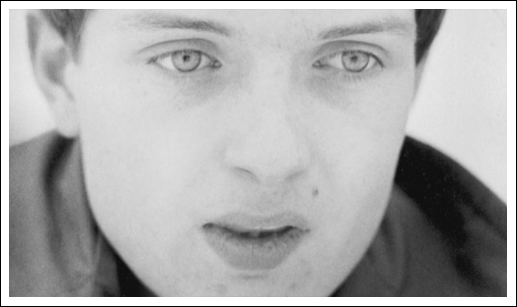
 Quando ISBN Edizioni mi ha mandato
Quando ISBN Edizioni mi ha mandato