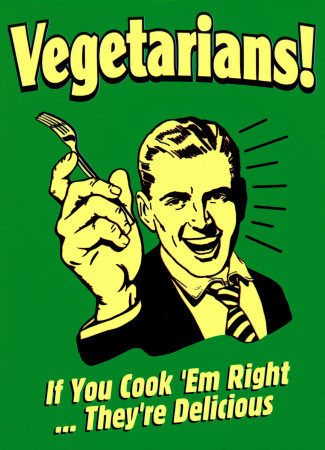Cosa resterà di questi anni '80
 Quando ISBN Edizioni mi ha mandato Player One, il romanzo d’esordio di Ernest Cline (supernerd, sceneggiatore di Fanboys, campione di slam poetry e possessore di una DeLorean), mi sono preoccupato: come possono pensare che legga seicento e passa pagine di libro in pochi giorni, in tempo per presentarlo a Bologna? La preoccupazione è svanita nel momento in cui l’ho aperto: le pagine sono volate, non appena ho conosciuto il protagonista del romanzo, Wade, un nerd appena maggiorenne che, come la maggior parte degli abitanti della Terra tra una trentina d’anni, vive per lo più collegato a OASIS, una simulazione di realtà (dove si gioca, si studia, si fa sesso, si va a scuola, si ammazza, si muore) ideata da un geniale incrocio tra Wozniac e Jobs, James Halliday. Quando il creatore di OASIS, unica speranza – per quanto fittizia – di un pianeta ridotto al lumicino, muore, indice la caccia al tesoro più grande della storia: chi troverà l’Easter Egg nascosto in OASIS (un universo fatto di migliaia di pianeti) erediterà il sistema stesso e le fortune del suo creatore. Inizia quindi una sfida per lo più incentrata su quiz, giochi e prove legate all’immaginario pop anni ’80, con richiami continui a musiche, film, e – ovviamente – giochi (per computer e non) di quella decade.
Quando ISBN Edizioni mi ha mandato Player One, il romanzo d’esordio di Ernest Cline (supernerd, sceneggiatore di Fanboys, campione di slam poetry e possessore di una DeLorean), mi sono preoccupato: come possono pensare che legga seicento e passa pagine di libro in pochi giorni, in tempo per presentarlo a Bologna? La preoccupazione è svanita nel momento in cui l’ho aperto: le pagine sono volate, non appena ho conosciuto il protagonista del romanzo, Wade, un nerd appena maggiorenne che, come la maggior parte degli abitanti della Terra tra una trentina d’anni, vive per lo più collegato a OASIS, una simulazione di realtà (dove si gioca, si studia, si fa sesso, si va a scuola, si ammazza, si muore) ideata da un geniale incrocio tra Wozniac e Jobs, James Halliday. Quando il creatore di OASIS, unica speranza – per quanto fittizia – di un pianeta ridotto al lumicino, muore, indice la caccia al tesoro più grande della storia: chi troverà l’Easter Egg nascosto in OASIS (un universo fatto di migliaia di pianeti) erediterà il sistema stesso e le fortune del suo creatore. Inizia quindi una sfida per lo più incentrata su quiz, giochi e prove legate all’immaginario pop anni ’80, con richiami continui a musiche, film, e – ovviamente – giochi (per computer e non) di quella decade.
Della trama non vi racconto nulla di più (ci penserà il film che ne verrà tratto a rovinare tutto), ma del libro è bene parlare un po’: raramente un romanzo mi ha così immediatamente preso e divertito. Le pagine si divorano, si sorride spesso e, sebbene dopo la metà il ritmo si ingolfi un po’ e il finale sia alquanto prevedibile, leggere Player One è uno spasso. Soprattutto per chi, come me, ha vissuto da ragazzino gli anni ’80, è cresciuto con i vari Goonies, Wargames e Indiana Jones, sebbene io non sia stato un uguale appassionato di giochi di ruolo e videogame. Per Wade gli anni ’80 sono un’epoca esotica, che lui e i suoi sodali Gunter (Egg Hunter, cioè cacciatori di “uova”, coinvolti nella gara globale al centro del romanzo) conoscono attraverso musiche, videoclip, serie televisive e videogame. Per Halliday gli anni ’80 sono la giovinezza. Due modi di mitizzare un periodo storico. Proprio dal punto di vista storico, però, gli anni ’80 (come dice giustamente Matteo Bittanti) sono l’ultimo momento in cui i nerd sono stati emarginati: infatti viviamo oggi in un mondo dominato da nerd e geek, dove smanettoni e fan accaniti (di qualsiasi cosa) sono posizionati ben in alto nella scala sociale. Venticinque anni fa, rincoglioniti dal lato più luccicante della decade in questione, non l’avrebbe detto nessuno.
In Player One, dunque, gli anni ’80 sono il riferimento principale, tuttavia si sfora anche più indietro nel tempo, quando si citano serie giapponesi degli anni ’50, ma raramente più avanti: nel romanzo non compare alcun riferimento a qualcosa che sia stato creato oltre il ventesimo secolo. Perché? Forse perché negli ultimi anni, come dice Simon Reynolds in Retromania, viviamo in un continuo richiamo a ciò che è stato, senza effettivamente fare?
E perché, nonostante il finale conciliante, nessuno fa una mossa per operare nel mondo reale, che tra crisi energetiche e degli alloggi, povertà e violenza, di una mano avrebbe anche bisogno? C’è un lato criticabile nella cultura nerd: come in tutte le sottoculture il nerd è autoreferenziale ma, soprattutto, vive nel suo mondo (o, come direbbe l’amico C., “è felicemente prigioniero del suo immaginario”). Facendo un balzo di lato, forse neanche troppo composto, ci si chiede se uno dei lati negativi della cultura nerd sia quello di avere contribuito a ridurre le persone alla clausura volontaria, al non uscire di casa e affrontare il mondo: quando leggo delle rivolte arabe (e oplà, atterraggio maldestro) penso che la reale differenza tra i giovani italiani, europei e statunitensi e quelli dei Paesi che stanno provando a fare qualcosa è che i ragazzi egiziani, tunisini e algerini non hanno armi di distrazione e, soprattutto, abbiano prime necessità da conquistare. Quando non si ha da mangiare, si capisce, risolvere uno schema di PacMan o finire l’ennesima stagione di una serie TV è cosa di ben poco conto.
Eppure, nel mondo reale immaginato da Ernest Cline, Wade e i suoi amici fanno pochissimo: sì, una delle protagoniste, Art3mis, dice che vorrebbe dare i soldi del premio alla popolazione del globo per risollevarlo dallo stato in cui si trova, ma la cosa suona come un segno di spunta alla voce “impegno sociale”. Insomma, non vorrei che ci fossimo già dentro la Terra preconizzata da Cline: per ora, di OASIS qua non c’è traccia.
Ernest Cline sarà mio ospite a Maps domani pomeriggio e domani sera, insieme a Luigi Bernardi, presenteremo Player One a Modo Infoshop, a Bologna.

 Esattamente cinque anni fa scrivevo di
Esattamente cinque anni fa scrivevo di  Essere al centro dell’attenzione, sempre e comunque: una condizione nella quale gli Stati Uniti, spesso per la loro stessa volontà, hanno vissuto da secoli. Questo porta a vulnerabilità, soprattutto quando si scopre di non essere invicibili, e che attacchi come quello di Pearl Harbor possono essere replicati in forma anche più distruttiva e subdola. Scatta immediatamente, quindi, la mancanza di fiducia (un’altra parola ricorrente in filigrana nelle pagine di Ellis) e, di conseguenza, un comportamento velatamente o esplicitamente paranoico, che dà luogo alla paura costante. In Imperial Bedrooms il protagonista è spesso fisicamente impaurito: gli tremano le mani, si piscia addosso, gli manca il respiro. Ma il suo primo istinto è quello di non sapere, di costringersi a fare finta di niente, o meglio di continuare a credere che le cose vadano come dovrebbero andare. E di annegarsi in droga e alcol per trovare una dimensione confortevole: un comportamento che, in effetti, lega i personaggi dello scrittore americano da venticinque anni a questa parte. “We know who you’re with and where you are”, recita “Imperial Bedroom”, di Elvis Costello (sua è anche una canzone che si intitola “Less Than Zero”). Quindi, Imperial Bedrooms è l’ennesimo trattato sulla paranoia di un Paese sull’orlo del collasso. O no?
Essere al centro dell’attenzione, sempre e comunque: una condizione nella quale gli Stati Uniti, spesso per la loro stessa volontà, hanno vissuto da secoli. Questo porta a vulnerabilità, soprattutto quando si scopre di non essere invicibili, e che attacchi come quello di Pearl Harbor possono essere replicati in forma anche più distruttiva e subdola. Scatta immediatamente, quindi, la mancanza di fiducia (un’altra parola ricorrente in filigrana nelle pagine di Ellis) e, di conseguenza, un comportamento velatamente o esplicitamente paranoico, che dà luogo alla paura costante. In Imperial Bedrooms il protagonista è spesso fisicamente impaurito: gli tremano le mani, si piscia addosso, gli manca il respiro. Ma il suo primo istinto è quello di non sapere, di costringersi a fare finta di niente, o meglio di continuare a credere che le cose vadano come dovrebbero andare. E di annegarsi in droga e alcol per trovare una dimensione confortevole: un comportamento che, in effetti, lega i personaggi dello scrittore americano da venticinque anni a questa parte. “We know who you’re with and where you are”, recita “Imperial Bedroom”, di Elvis Costello (sua è anche una canzone che si intitola “Less Than Zero”). Quindi, Imperial Bedrooms è l’ennesimo trattato sulla paranoia di un Paese sull’orlo del collasso. O no?