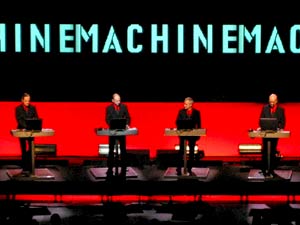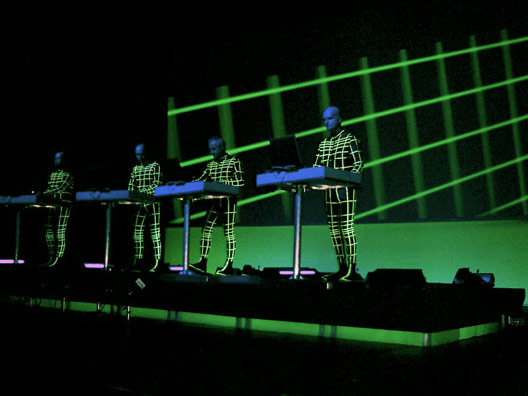Non si può scrivere altro che d’amore: intervista a Miles Kane

Lo ammetto: pur amando molto la musica britannica, ci sono alcune band che vengono dalle isole lassù che mi lasciano indifferente o non mi piacciono proprio: gli Arctic Monkeys sono una di queste. A parte il primo disco (o meglio, il primo singolo) la band di Alex Turner mi ha sempre detto poco. Ciononostante, penso che Turner sia musicalmente davvero dotato e la dimostrazione di questo talento sta a mio avviso nel disco realizzato insieme all’amico Miles Kane qualche anno fa, firmato The Last Shadow Puppets. Quando mi hanno proposto l’intervista all’ex-voce dei Rascals, quindi, ho accettato subito e sono andato a riascoltarmi i due dischi pubblicati da solista, scoprendo delle cose interessanti nell’ultimo album, uscito a giugno.
Giovedì scorso ho incontrato Miles Kane per una breve intervista nel backstage di piazza Castello a Ferrara, poco più di un’ora prima che salisse sul palco. Se volete ascoltare il suo meraviglioso accento di Liverpool, andate ad ascoltare l’audio sul sito di Radio Città del Capo, che inoltre trasmette l’intervista oggi intorno alle 11 e, nel pomeriggio, verso le 15.
Il tuo ultimo disco si intitola Don’t Forget Who You Are, cioè “non dimenticarti chi sei”. Chi è Miles Kane e quanto è ancora quel ragazzino che ha avuto la sua prima chitarra in dono dalla madre, considerando il grande successo che hai?
Penso che in fondo non cambierò mai. Credo di essere lo stesso ragazzo che suonava quella chitarra, ma vedi, si cresce e si evolve allo stesso tempo. L’importante è non rimanere impigliato nelle cose. Gli Arctic Monkeys sono l’esempio perfetto di chi ha successo, ma non cambia. Sono sempre loro stessi e continuano a tenere alla musica. Ecco quello che voglio anche io.
C’è un fattore, qualcosa, qualcuno, o un pensiero che ti tiene con i piedi per terra?
Probabilmente mia madre: siamo molto vicini e lei è un esempio per me.
Paul Weller ha contribuito al tuo ultimo disco. Sembra che la vecchia generazione di musicisti britannici non riposi per nulla sulle glorie del passato, ma voglia invece aiutare i giovani. Che ne pensi?
Paul è davvero un buon amico, ora, e ho una grande stima per lui. Mi ha incoraggiato molto, anche se non era obbligato a farlo, ma sa che ho grinta, che volevo fare il disco e farlo bene. Ero intenzionato a lavorare duro per arrivare dove volevo. Penso che sappia che sono vero.
Come si è comportato con te? Era il fratello maggiore, il padre, una specie di amico, il collega…
(ride) Un po’ tutto! Lui è per me una fonte di ispirazione… Vorrei essere come lui a 55 anni, stare qui seduto con te a parlare del mio nuovo disco, capisci? Mi voglio giocare tutta la partita, anche se ci sono alti e bassi… Le cose non nascono all’improvviso, ma vorrei fare questo, scrivere buona musica, per sempre.
Secondo te in cosa è meglio il tuo ultimo disco, se confrontato con l’album di debutto?
Penso sia più diretto. Le canzoni sono più consistenti. È un disco più conciso e brillante. Questa era l’idea di partenza che volevamo seguire. È un disco da suonare dal vivo, per darti energia.
La tua esperienza live quindi è stata determinante quando hai scritto le canzoni nuove…
Sì, tantissimo.
E le hai registrate pensando poi a quando le avresti suonate dal vivo…
Sì, al cento per cento. Sì.
C’è qualcosa o qualcuno che ha ispirato questi nuovi brani? Una specie di riferimento, un posto, una persona…
Tante cose, sai. Cose che mi sono accadute nell’ultimo anno. Non si può scrivere d’altro… cioè, per me si è trattato dell’innamorarmi del tutto e del disinnamorarmi davvero per la prima volta. È stata davvero la prima volta che mi sono innamorato sul serio e non si può scrivere altro quando ti capita, no? Forse nel passato ci sono andato vicino, ma stavolta volevo davvero essere onesto con i testi e esprimere i miei sentimenti, che fossi arrabbiato o felice.
Si tratta di messaggi molto diretti o li hai un po’ “lustrati”?
Be’, sì: penso che siano abbastanza diretti.
Cosa provi quando canti queste parole e quando lo fai dal vivo?
Diciamo che si formano delle piccole immagini nella mia testa che mi ricordano alcuni periodi, quando le scrivevo. Sento queste cose… Molte di queste canzoni erano dei demo e li ho ascoltati tantissimo. Mi ricordano di questo momento dell’anno scorso, quando eravamo presi dal tour ma scrivevo comunque, preparavo questo nuovo disco, mi succedevano un sacco di cose… Ecco cosa provo; ma c’è una canzone sul disco, “Out of Control”, un brano piuttosto lento, che talvolta mi emoziona. Non la suoniamo, cioè, l’abbiamo suonata solo un paio di volte, perché mi commuove. Cazzo, è pazzesco…
Pensi che a ogni concerto le cose migliorino da questo punto di vista? Il fardello emotivo si assottiglia, ne lasci un po’ su ogni palco, per sentirti più leggero?
Sì, forse sì.
Ne lascerai quindi anche un po’ a Ferrara, speriamo…
Speriamo. Sono felicissimo di suonare qua, perché non sono mai stato in Italia prima. Non ci ho mai suonato, se non ieri sera. Sento che la mia musica può funzionare qua. Il concerto di ieri a Roma è stato bellissimo, la gente è stata fantastica. Voglio venire qua spesso in modo da potere organizzare poi il mio tour. Non capisco come mai non sia venuto prima in Italia, perché ho fatto tanti concerti in Europa, molte volte. Sono stato molto in Francia, ho dato tanto là. Mi piacerebbe venire qua come ho fatto in altri Paesi, passare del tempo per farmi conoscere. Mi piace! Sono stato a Milano un paio di settimane fa per quattro giorni e a Roma per tre. È stato bello. Insomma, viaggio ovunque, in Paesi diversi, ma non so: dev’essere l’aria, mi piacciono le persone di qua.
Apriamo una breve parentesi su The Last Shadow Puppets: innanzitutto ci sarà un altro disco?
Non è pianificato, ma di certo ci piacerebbe farlo, un giorno.
Visto che Scott Walker era uno dei riferimenti principali del disco, cosa pensi del suo ultimo album, Bisch Bosh? L’hai sentito?
No, è un disco strano. Ho The Drift, ma è troppo.
Troppo cupo?
Non mi rende felice, non mi dà niente. Non riesco ad ascoltarlo. È troppo strano.
Mi dici al volo tre cose che ti rendono felice? (Miles ride un po’ imbarazzato) Ok, puoi dire “il sesso”, senza bisogno di scendere in dettagli… Allora altre due, dai.
Cose che mi rendono felice… C’è un disco che amo. È di Charles Bradley, un sessantacinquenne che nella vita fa il sosia di James Brown. Hai presente quella band, Sharon Jones and the Dapkings? Be’, l’hanno voluto per la loro etichetta: l’hanno visto, gli è piaciuto e ha firmato. Sono usciti due dischi: ti consiglio No Time for Dreaming, di Charles Bradley. Mi rende felice e lo ascolto ogni giorno. Poi fare un bel concerto, sudare e andare fuori di testa, senza problemi sul palco: anche questo mi fa felice.
Una domanda un po’ più ampia delle altre: sei un giovane britannico e vorrei conoscere il tuo punto di vista sulle giovani generazioni del tuo Paese, sia in generale sia parlando di quelli che, come te, hanno a che fare con l’arte. Ci sono speranze, soldi, posti, gente, attenzione…
Be’, è dura, lo è sempre. Raccogli, nella vita, solo ciò che semini. Qualunque cosa tu voglia fare, che sia il giornalista, il cantante o il pittore, devi volerlo al cento per cento. Da ragazzini ci si distrae e io mi sono distratto molto, ma quando vuoi qualcosa davvero ci possono volere un sacco di anni per ottenerlo, ma devi crederci molto. Non perderti in cazzate.
C’è un pensiero o qualcosa che tieni a mente per evitare di distrarti, o che usi quando sei pigro, quando non dai il cento per cento e più?
Abbiamo tutti quei giorni o quei momenti in cui vorresti prendere in mano la chitarra e scrivere, ma non lo fai. L’importante è non perdere di vista l’obiettivo.
Grazie a Emily Clancy per la revisione della traduzione.