Dagli archivi: Bill Fay – Who Is the Sender?
Bill Fay – Who Is the Sender? (Dead Oceans)
9
Altri ascolti raccomandati
Bill Fay – Bill Fay
Bill Fay – Time of the Last Persecution
Bill Fay – Life Is People
 Niente preamboli: il quarto album del musicista britannico è splendido, come il precedente Life Is People, che aveva interrotto un silenzio di quattro decadi. La squadra è la stessa, a partire dal produttore Joshua Henry: ma se le registrazioni di allora durarono un mese, qui Fay e i suoi hanno occupato gli studi londinesi di Ray Davies per un paio di settimane scarse. Incredibile, data la qualità sopraffina delle canzoni e degli arrangiamenti: Who Is the Sender? è uno degli album meglio composti e suonati che possiate sentire, ma accorgetevene dopo qualche ascolto.
Niente preamboli: il quarto album del musicista britannico è splendido, come il precedente Life Is People, che aveva interrotto un silenzio di quattro decadi. La squadra è la stessa, a partire dal produttore Joshua Henry: ma se le registrazioni di allora durarono un mese, qui Fay e i suoi hanno occupato gli studi londinesi di Ray Davies per un paio di settimane scarse. Incredibile, data la qualità sopraffina delle canzoni e degli arrangiamenti: Who Is the Sender? è uno degli album meglio composti e suonati che possiate sentire, ma accorgetevene dopo qualche ascolto.
Lasciate prima che i suoni e le parole vi rapiscano, infondendovi il senso di meraviglia, mistero e speranza che era tutto racchiuso in “The Healing Day” di Life Is People: quella è la canzone “ponte” tra i due album, entrambi (come del resto anche gli altri lavori di Fay) intrisi di una spiritualità più vicina alla sacralità naturale che a dogmi e rituali. Si cita indirettamente la Prima Lettera ai Corinzi in “Something Else Ahead”, compare un riferimento cristologico in “Order of the Day” e anche il “sender” della struggente title-track potrebbe essere interpretato in senso religioso. Ma, oltre la Natura, per Fay è sacro l’Uomo, con tutte le sue debolezze (“A Frail and Broken One”), la sua violenza (“War Machine”), la sua irrequietezza (“Bring It On Lord”) e soprattutto la sua musica, dono e fonte di speranza.
L’affresco sonoro dipinto dal piano di Fay assieme agli archi, talvolta accompagnati da un organo, fiati, lampi di chitarra elettrica, bassi elettrici e non e accortissime percussioni è commovente. E c’è tempo, alla fine dell’album, per riprendere “I Hear You Calling”, da Time of the Last Persecution: ci piace pensare che la fabbrica sul cui pavimento giace il narratore sia la stessa che vedono le oche dall’alto nell’apertura di questo Who Is the Sender, “The Geese Are Flying Westward”: una vertigine dello sguardo che abbraccia il tempo e lo spazio e proietta ancora una volta Bill Fay tra i grandissimi della musica.
Recensione pubblicata originariamente sul numero di aprile 2015 de Il Mucchio Selvaggio

 La rassegna Murato, nel suo penultimo appuntamento stagionale, porta al Locomotiv due nomi molto diversi tra loro, in una serata che è nettamente divisa per suoni, pubblico di riferimento e atmosfera.
La rassegna Murato, nel suo penultimo appuntamento stagionale, porta al Locomotiv due nomi molto diversi tra loro, in una serata che è nettamente divisa per suoni, pubblico di riferimento e atmosfera. Con la seconda parte della serata si volta pagina: un solista prende il posto del trio e il rock cede il passo all’elettronica. Romare è venuto in città a farci scoprire il suo album Projections, uno degli ultimi colpi messi a segno dalla Ninja Tune. Il giovane musicista britannico, alle prese con vari macchinari, sorride timido e riconoscente al pubblico (nettamente più sparuto rispetto alla prima parte della serata, ma del resto l’ora inizia a essere tarda), snocciola brani tratti dal disco e dal precedente ep accompagnato da proiezioni che hanno due soggetti che si ripetono spesso: Robert Johnson e Chet Baker, quest’ultimo raffigurato in varie fasi della sua vita e anche in scene dello pseudo-biopic All the Young Fine Cannibals.
Con la seconda parte della serata si volta pagina: un solista prende il posto del trio e il rock cede il passo all’elettronica. Romare è venuto in città a farci scoprire il suo album Projections, uno degli ultimi colpi messi a segno dalla Ninja Tune. Il giovane musicista britannico, alle prese con vari macchinari, sorride timido e riconoscente al pubblico (nettamente più sparuto rispetto alla prima parte della serata, ma del resto l’ora inizia a essere tarda), snocciola brani tratti dal disco e dal precedente ep accompagnato da proiezioni che hanno due soggetti che si ripetono spesso: Robert Johnson e Chet Baker, quest’ultimo raffigurato in varie fasi della sua vita e anche in scene dello pseudo-biopic All the Young Fine Cannibals. Mr E e soci sono tornati alla Royal Albert Hall di Londra il 30 giugno 2014, quasi dieci anni dopo il tour “Eels with Strings”. In questo caso, però, la band ha usato – benissimo – solo le sue risorse per dare talvolta alle canzoni (per lo più tratte dall’ultimo disco) nuovi arrangiamenti, senza rimanere intimidita da quello che è uno dei templi della musica.
Mr E e soci sono tornati alla Royal Albert Hall di Londra il 30 giugno 2014, quasi dieci anni dopo il tour “Eels with Strings”. In questo caso, però, la band ha usato – benissimo – solo le sue risorse per dare talvolta alle canzoni (per lo più tratte dall’ultimo disco) nuovi arrangiamenti, senza rimanere intimidita da quello che è uno dei templi della musica. L’esordio di Alessio Bondì comincia con una giocosa filastrocca che pare venire da epoche antiche: però quando il musicista palermitano rassicura il bambino a cui “Di cu si” è rivolta cantando che se batte le mani “veni puru spaidermè”, il tempo fa una capriola in avanti, il vecchio diventa il nuovo e anche noi ascoltatori veniamo sorpresi da un risolino di pura gioia. Ecco, Sfardo è un disco che fa bene, anche nei momenti più lirici e dolenti che pure ci sono: del resto il titolo vuol dire “strappo” in palermitano, la lingua delle dodici tracce dell’album.
L’esordio di Alessio Bondì comincia con una giocosa filastrocca che pare venire da epoche antiche: però quando il musicista palermitano rassicura il bambino a cui “Di cu si” è rivolta cantando che se batte le mani “veni puru spaidermè”, il tempo fa una capriola in avanti, il vecchio diventa il nuovo e anche noi ascoltatori veniamo sorpresi da un risolino di pura gioia. Ecco, Sfardo è un disco che fa bene, anche nei momenti più lirici e dolenti che pure ci sono: del resto il titolo vuol dire “strappo” in palermitano, la lingua delle dodici tracce dell’album.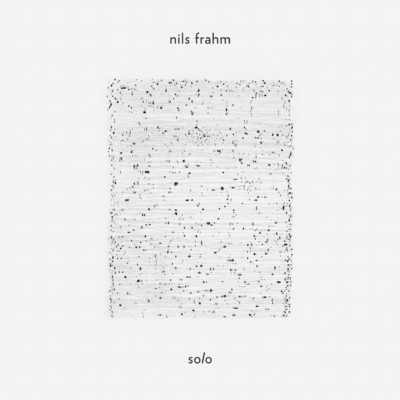 Il primo
Il primo  “I wanted to do something that I don’t know how to do”, si sente nella traccia d’apertura del nuovo disco degli Inventions: ma Mark T. Smith (Explosions in the Sky) e Matthew Cooper (meglio conosciuto come Eluvium) sanno il fatto loro, tanto da produrre un lavoro più riuscito
“I wanted to do something that I don’t know how to do”, si sente nella traccia d’apertura del nuovo disco degli Inventions: ma Mark T. Smith (Explosions in the Sky) e Matthew Cooper (meglio conosciuto come Eluvium) sanno il fatto loro, tanto da produrre un lavoro più riuscito  Tre anni dopo Big Inner,
Tre anni dopo Big Inner,  Basta confrontare la prima traccia del debutto del duo di Harlem con la intro di questo nuovo disco per capire che i 14 anni intercorsi tra lo splendido The Cold Vein e il fiacco Blade of the Ronin hanno decisamente cambiato le cose per Vordul Mega e Vast Aire (qui decisamente in primo piano rispetto al partner). Ciò che manca, soprattutto, è la ricerca dei suoni: nel 2001 i due raccontavano la loro NYC con distorsioni, squittii elettronici e bordoni inquietanti.
Basta confrontare la prima traccia del debutto del duo di Harlem con la intro di questo nuovo disco per capire che i 14 anni intercorsi tra lo splendido The Cold Vein e il fiacco Blade of the Ronin hanno decisamente cambiato le cose per Vordul Mega e Vast Aire (qui decisamente in primo piano rispetto al partner). Ciò che manca, soprattutto, è la ricerca dei suoni: nel 2001 i due raccontavano la loro NYC con distorsioni, squittii elettronici e bordoni inquietanti. Emanuele Bultrini, Paolo Pecorelli, Stefano Vicarelli e David Nerattini sono musicisti romani con un bel curriculum alle spalle: i primi tre suonano anche ne La Fonderia che, come questa neonata band, è principalmente strumentale. La Batteria si rifà alla musica italiana da film e da library prodotta tra la fine dei ’60 e i primi anni ’80: un periodo ultimamente più che sfruttato, a cui i musicisti guardano con fin troppo rispetto. Strumentazione d’epoca, progressioni armoniche filologicamente corrette e, tutto sommato, poche sorprese. Colpiscono “Chimera”, traccia iniziale con echi folk, e “Formula”, che si apre e si chiude con un synth quasi carpenteriano. Speriamo che le influenze più variegate di cui parla il comunicato stampa erompano con più coraggio in una seconda prova.
Emanuele Bultrini, Paolo Pecorelli, Stefano Vicarelli e David Nerattini sono musicisti romani con un bel curriculum alle spalle: i primi tre suonano anche ne La Fonderia che, come questa neonata band, è principalmente strumentale. La Batteria si rifà alla musica italiana da film e da library prodotta tra la fine dei ’60 e i primi anni ’80: un periodo ultimamente più che sfruttato, a cui i musicisti guardano con fin troppo rispetto. Strumentazione d’epoca, progressioni armoniche filologicamente corrette e, tutto sommato, poche sorprese. Colpiscono “Chimera”, traccia iniziale con echi folk, e “Formula”, che si apre e si chiude con un synth quasi carpenteriano. Speriamo che le influenze più variegate di cui parla il comunicato stampa erompano con più coraggio in una seconda prova. Al sesto disco i Dodos
Al sesto disco i Dodos