Dagli archivi: Woods – With Light and With Love
Woods – With Light and Love (Woodsist), 15 aprile 2014
7,5
Tre dischi:
Grateful Dead – Anthem of the Sun (Warner Bros, 1968)
Jefferson Airplane – Crown of Creation (RCA, 1968)
The Kinks – Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One (Py, 1970)
 Jeremy Earl torna sulle scene riprendendo il filo del precedente Bend Beyond, pubblicato sempre dalla sua Woodsist. Se dovessimo tenere fede al testo della title-track di due anni fa, quell’album avrebbe potuto intitolarsi “Bend Beyond the Light”: la luce è un elemento fondamentale nell’immaginario dei Woods, torna in titoli e testi, e anche le canzoni sparse in una discografia lunga ormai quasi un decennio la richiamano spesso.
Jeremy Earl torna sulle scene riprendendo il filo del precedente Bend Beyond, pubblicato sempre dalla sua Woodsist. Se dovessimo tenere fede al testo della title-track di due anni fa, quell’album avrebbe potuto intitolarsi “Bend Beyond the Light”: la luce è un elemento fondamentale nell’immaginario dei Woods, torna in titoli e testi, e anche le canzoni sparse in una discografia lunga ormai quasi un decennio la richiamano spesso.
Ma per capire dove questo valido With Light and With Love si allontana da Bend Beyond, ripeschiamo il disco pubblicato nel 2011, quel Sun and Shade dove facevano capolino beat quasi kraut e colori lontani dalla luminosità (appunto) pur strampalata e freak tipica della band. “Out of the Eye” e “Sol Y Sombra” (la title-track) espandevano durate e possibilità della peculiare forma di folk-psych-pop dei Woods per trovare altre strade, che parevano richiamare Can, Harmonia e altre splendide musiche teutoniche del passato.
In With Light and With Love la title-track è di nuovo la canzone più lunga del disco e si estende proprio sui suoni che lo caratterizzano: chitarre acide, organo hammond, leslie ovunque. Aggiungete delle percussioni spesso più massicce del solito (ma lontane da ogni parvenza motorik), un pianoforte e una sega musicale ed ecco gli ingredienti dell’album. I richiami sono, certo, alla psichedelia statunitense, ma lo sguardo di Earl si rivolge anche al Regno Unito. “Shining” ha qualcosa dei Kinks e qualche fraseggio di chitarra non sarebbe dispiaciuto all’Harrison di una quarantina di anni fa.
Ciononostante i Woods non suonano (troppo) derivativi: sporcano ogni tanto i fasci di luce che con grazia appoggiano sull’ascoltatore attraverso nastri, rumori e riverberi, ma non spaventano, almeno fino alla conclusione del disco. “Feather Man”, infatti, getta un’ombra (non si esce dal giochino) sulla luce e l’amore profusi: l’ultimo mezzo minuto di disco è affidato a delle campane e a una voce rallentata. Una nuova strada si profila all’orizzonte?
Recensione pubblicata originariamente sul numero di maggio 2014 de Il Mucchio Selvaggio

 I fratelli Brewis sono bravi e prolifici: insieme sono i Field Music, quattro validi dischi in meno di dieci anni. Peter da solo si fa chiamare The Week That Was: un buon album self titled sei anni fa. School of Language, invece, è il nome da solista di David, che ora ci regala Old Fears, dopo l’esordio del 2008. Il musicista del Sunderland dà alle stampe, per sua stessa ammissione, un disco pop: l’album riesce a cogliere magicamente la paura sospesa tra infanzia e maturità che si prova da giovani, combinando la distanza partecipe dell’età adulta a uno sguardo empatico.
I fratelli Brewis sono bravi e prolifici: insieme sono i Field Music, quattro validi dischi in meno di dieci anni. Peter da solo si fa chiamare The Week That Was: un buon album self titled sei anni fa. School of Language, invece, è il nome da solista di David, che ora ci regala Old Fears, dopo l’esordio del 2008. Il musicista del Sunderland dà alle stampe, per sua stessa ammissione, un disco pop: l’album riesce a cogliere magicamente la paura sospesa tra infanzia e maturità che si prova da giovani, combinando la distanza partecipe dell’età adulta a uno sguardo empatico. La band di San Francisco torna a Bologna trentaquattro anni dopo il primo storico live europeo: tre serate sold out per dei concerti da vedere, oltre che da ascoltare, che confermano l’eccellente peculiarità dei Tuxedomoon e rinsaldano il loro legame con la città.
La band di San Francisco torna a Bologna trentaquattro anni dopo il primo storico live europeo: tre serate sold out per dei concerti da vedere, oltre che da ascoltare, che confermano l’eccellente peculiarità dei Tuxedomoon e rinsaldano il loro legame con la città. Nel curriculum di Jocie Adams spicca, quasi più della militanza nei Low Anthem, un periodo passato alla NASA come ricercatrice: è il lato inaspettato, bizzarro, ma allo stesso tempo “serio” nella biografia di un’ottima musicista. C’è una sorta di corrispettivo di tutto ciò nel debutto solista a nome Arc Iris: si stende sulle undici tracce del disco, portando l’ascoltatore per mano in un viaggio in cui c’è una vera sorpresa ad ogni passo. Jocie mischia rock, jazz, folk, country, ma evita pasticci, barocchismi e virtuosismi, non forza la mano pur non disdegnando arrangiamenti complessi (basati principalmente su archi, fiati, armonie vocali e pianoforte) e richiami colti (uno su tutti, la musica da cabaret). Traccia la strada mentre la percorre e il paesaggio coloratissimo che si snoda canzone dopo canzone davanti ai nostri occhi muta di continuo, rivelando scorci inaspettati che fanno sobbalzare il cuore.
Nel curriculum di Jocie Adams spicca, quasi più della militanza nei Low Anthem, un periodo passato alla NASA come ricercatrice: è il lato inaspettato, bizzarro, ma allo stesso tempo “serio” nella biografia di un’ottima musicista. C’è una sorta di corrispettivo di tutto ciò nel debutto solista a nome Arc Iris: si stende sulle undici tracce del disco, portando l’ascoltatore per mano in un viaggio in cui c’è una vera sorpresa ad ogni passo. Jocie mischia rock, jazz, folk, country, ma evita pasticci, barocchismi e virtuosismi, non forza la mano pur non disdegnando arrangiamenti complessi (basati principalmente su archi, fiati, armonie vocali e pianoforte) e richiami colti (uno su tutti, la musica da cabaret). Traccia la strada mentre la percorre e il paesaggio coloratissimo che si snoda canzone dopo canzone davanti ai nostri occhi muta di continuo, rivelando scorci inaspettati che fanno sobbalzare il cuore. Il secondo disco dei portoghesi Paus nasce sotto l’egida del prestigioso Primavera Sound, che ha ospitato per due edizioni di seguito i musicisti di Lisbona e che fa uscire questo album sotto la sua etichetta. Il quartetto ha una peculiarità: ci sono due batteristi che suonano lo stesso set (“siamese”, con la cassa in comune) uno di fronte all’altro. Clarão, però, non è un disco di puri ritmi, sebbene i battiti siano al centro delle dieci tracce che lo compongono. E non è neanche un album strumentale, per quanto le voci siano filtrate, spezzettate, usate come suoni in mezzo a chitarre, bassi e synth.
Il secondo disco dei portoghesi Paus nasce sotto l’egida del prestigioso Primavera Sound, che ha ospitato per due edizioni di seguito i musicisti di Lisbona e che fa uscire questo album sotto la sua etichetta. Il quartetto ha una peculiarità: ci sono due batteristi che suonano lo stesso set (“siamese”, con la cassa in comune) uno di fronte all’altro. Clarão, però, non è un disco di puri ritmi, sebbene i battiti siano al centro delle dieci tracce che lo compongono. E non è neanche un album strumentale, per quanto le voci siano filtrate, spezzettate, usate come suoni in mezzo a chitarre, bassi e synth.
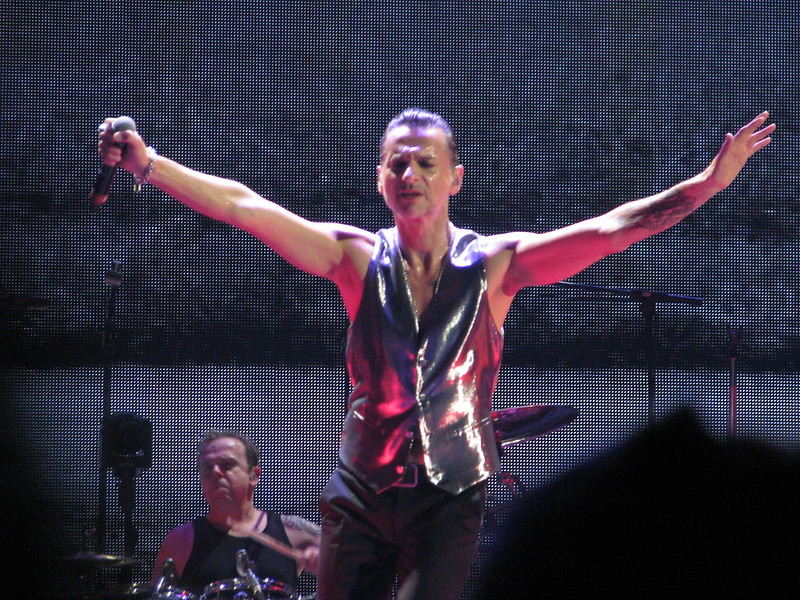

 Quasi vent’anni fa pubblicavo sul blog
Quasi vent’anni fa pubblicavo sul blog  Ogni volta che riascolto dall’inizio alla fine l’ultimo disco dei Thee Silver Mt. Zion ho una reazione fisica: un brivido che sale per scoppiare puntuale intorno al secondo minuto e mezzo della penultima traccia, “
Ogni volta che riascolto dall’inizio alla fine l’ultimo disco dei Thee Silver Mt. Zion ho una reazione fisica: un brivido che sale per scoppiare puntuale intorno al secondo minuto e mezzo della penultima traccia, “