Dieci anni e un mese circa
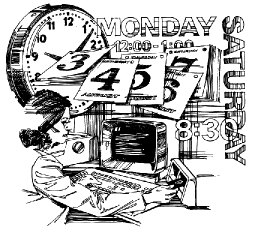 Un post come questo che si rinvia, si rinvia e si rinvia ancora, ha una caratteristica: il suo titolo si allunga e cambia, se uno volesse essere preciso, ogni istante.
Un post come questo che si rinvia, si rinvia e si rinvia ancora, ha una caratteristica: il suo titolo si allunga e cambia, se uno volesse essere preciso, ogni istante.
Se l’avessi scritto un paio di settimane fa, sarebbe stato “Dieci anni”, e forse per correttezza avrei dovuto aggiungere “più o meno”. Già, perché non ricordo esattamente quando mi sono trasferito a Bologna. Era l’ottobre del 1996, di questo ne sono certo. Potrei risalire alla prima lezione all’università, ma in fondo sono passati quattro anni (meno un mese circa) da quando mi sono laureato: l’università è finita, la mia permanenza a Bologna, no.
Non ricordo bene quel mese, perché è stato difficile, difficilissimo, ed esaltante allo stesso tempo. Avrei vissuto e fatto l’università a Bologna, che ai miei occhi era un po’ come fare l’università a Disneyland, senza avere però pupazzi enormi come docenti: poi ho avuto di fronte solo pupazzi normali, per la maggior parte.
Abbandonavo la cittadina del nordest senza rimorso alcuno, a parte quello di allontanarmi dalla mia ragazza di allora: lei si era fermata a Venezia, io avevo esagerato di un altro paio di centinaia di chilometri, ed ecco, ero a Bologna.
 Quell’ottobre di dieci anni fa mi ha visto conoscere i primi di una decina abbondante di coinquilini che avrei avuto. Mi ha visto stare ore al telefono, e segnare poi gli scatti su un quadernino: un gesto che adesso sembra assurdo, ma allora era – o meglio: avrebbe dovuto essere – l’ultimo vero atto della chiamata. E sulla carta il numero degli scatti era proporzionale all’intensità della telefonata: tanti scatti significavano comunque qualcosa di forte: un litigio o una serie infinita di “mi manchi” declinati in ogni modo. E talvolta ho pensato che, sommando quei numeri, avrei ottenuto qualcos’altro oltre alla cifra da pagare a fine mese.
Quell’ottobre di dieci anni fa mi ha visto conoscere i primi di una decina abbondante di coinquilini che avrei avuto. Mi ha visto stare ore al telefono, e segnare poi gli scatti su un quadernino: un gesto che adesso sembra assurdo, ma allora era – o meglio: avrebbe dovuto essere – l’ultimo vero atto della chiamata. E sulla carta il numero degli scatti era proporzionale all’intensità della telefonata: tanti scatti significavano comunque qualcosa di forte: un litigio o una serie infinita di “mi manchi” declinati in ogni modo. E talvolta ho pensato che, sommando quei numeri, avrei ottenuto qualcos’altro oltre alla cifra da pagare a fine mese.
In quell’ottobre di dieci anni fa giravo per Bologna perdendomi, ritrovandomi, iniziando a conoscere delle persone che mi accompagnano tutt’ora.
Una sera, tornando a casa dall’università, uno dei primi giorni di lezione, guardai il cielo, da via Rizzoli, verso le torri, e pensai a quanto era bello, a quanto era bella questa città. E a me in mezzo a tutto questo.
Adesso, dieci anni dopo, Bologna è diventata il luogo dove vivo, mangio, lavoro, abito. Ma ogni tanto, per fortuna, continuo a guardare il cielo e a perdermi.













