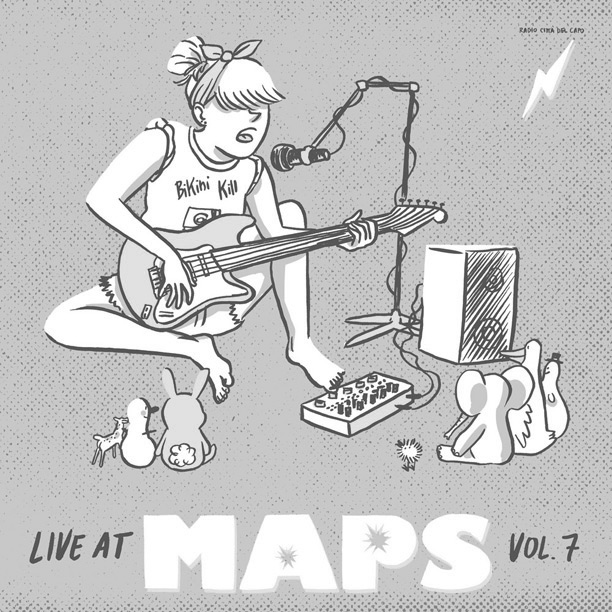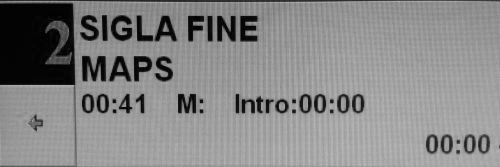Dagli archivi: Damo Suzuki: “Faccio la musica dell’oggi”
 Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista.
Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista.
Ti conoscono tutti come il cantante dei Can, ma ormai sono passati 35 anni da quell’esperienza, quindi parliamo del presente, del Damo Suzuki Network. Di che si tratta?
Per lavoro viaggio in tanti Paesi del mondo e cerco volta per volta, nello spazio e nel tempo in cui sono, di creare qualcosa con i “sound carrier locali”. Sono musicisti, ma io li chiamo “sound carrier” [“portatori di suono”, ndr] perché “musicista” è una parola vecchia, perché negli ultimi venti-trent’anni tutto è cambiato nel panorama musicale e noise. Suono ovunque, incontro persone senza fare prove, faccio la musica dell’oggi. Funziona, non è mai noioso perché ogni giorno posso fare cose diverse e incontro persone dalle mentalità molto diverse tra loro. Insomma, il menù del giorno cambia sempre.
Si tratta di improvvisazioni?
Non proprio, non mi piace tanto quella parola. Sì, è una specie di improvvisazione, ma il termine è utilizzato soprattutto dai musicisti jazz, e nel jazz, anche quando si improvvisa, non si fa davvero musica sul momento. Perché comunque nel jazz ci sono strutture definite, i solisti… Ognuno di noi, invece, fa nello stesso momento cose diverse.
Cosa succede quando, suonando, accade qualcosa di talmente bello e particolare che ti va di ripeterlo?
Di solito non ripeto nulla perché ogni volta ho a che fare con musicisti diversi. E poi ripetere significa copiare se stessi: non è proprio cosa per me.
In quanti Paesi diversi sei stato con il tuo progetto e che musicisti hai incontrato?
Non tanti, forse 27 Paesi diversi, e ho suonato con musicisti di ogni tipo: free jazz, hip hop, bande di ottoni…
Com’è stato suonare con gli Zu?
Gli Zu hanno un’energia incredibile ed è la cosa che davvero mi piace di loro. Anche nei miei concerti c’è molta energia, la condivido con il pubblico e me ne torno a casa con una bella sensazione.
Ci sono artisti o dischi interessanti che hai ascoltato di recente?
È una domanda difficile, perché per me ogni sound carrier che suona con me è interessante.
I sound carrier sono molto orgogliosi di suonare con te…
E io lo sono di suonare con loro, perché è davvero speciale. Prima di cominciare a suonare non ci conosciamo di persona e poi comunichiamo con la musica, è molto bello. Per comunicare non mi serve imparare l’italiano, una lingua per molto difficile: con la musica comunico ovunque. Ed è anche un motivo per cui porto avanti questo progetto: voglio usare la musica come arma contro ogni tipo di violenza. In questo mondo c’è molta violenza perché le persone non comunicano tra loro e la musica permette di farlo anche meglio [che con le parole].
Ci hai parlato della diversità dei Paesi che visiti e dei musicisti con cui suoni, ma che mi dici del pubblico?
Ti faccio un esempio: lo scorso aprile [2007, ndr] ho suonato a Londra con un quartetto d’archi, con musicisti classici, in un posto dove almeno l’80 per cento del pubblico era composto da appassionati di classica. Per me è stata un’esperienza interessantissima e la reazione del pubblico è stata magnifica: c’è stata una standing ovation e abbiamo fatto due parti, la prima da due pezzi, per un totale di 45 minuti e la seconda con un pezzo solo da 77 minuti.
Intervista andata in onda originariamente in diretta su Radio Città del Capo di Bologna il 18 gennaio 2008