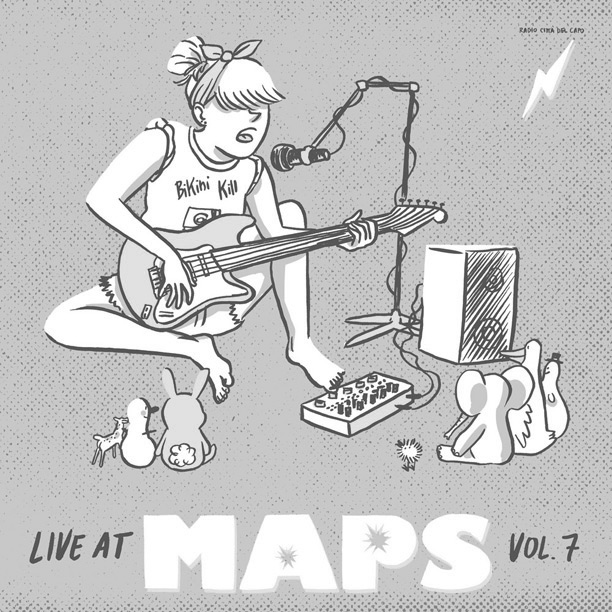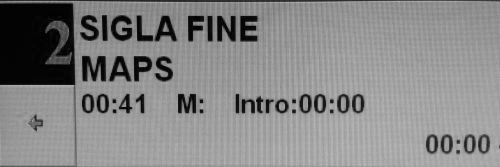Dagli archivi: A Place to Bury Strangers – Romare. Locomotiv Club, Bologna, 17 aprile 2015
 La rassegna Murato, nel suo penultimo appuntamento stagionale, porta al Locomotiv due nomi molto diversi tra loro, in una serata che è nettamente divisa per suoni, pubblico di riferimento e atmosfera.
La rassegna Murato, nel suo penultimo appuntamento stagionale, porta al Locomotiv due nomi molto diversi tra loro, in una serata che è nettamente divisa per suoni, pubblico di riferimento e atmosfera.
Si comincia con l’unica data italiana (sold out) degli A Place to Bury Strangers: la band “più rumorosa del mondo” raccoglie non solo il pubblico di Bologna e della Regione, ma anche di Veneto e Toscana. “We’ve Come So Far” è il brano di apertura: Oliver Ackerman inizia da solo, poco dopo raggiunto sul palco da Dion Lunadon al basso e Robi Gonzalez alla batteria. I tre sono perfettamente amalgamati nel riprodurre sul palco l’alchimia creativa di Transfixiation: gran parte della scaletta è costituita dai brani dell’ultimo album del gruppo, scritto da tutti e tre i musicisti proprio pensando alla resa dal vivo.
Entro poco il Locomotiv è invaso dal fumo e dalle luci stroboscopiche: il bilanciamento dei suoni si affina e il concerto diventa una sorta di vortice audiovisivo che coinvolge i partecipanti nonostante il terrorismo da decibel che precede la fama della band non si concretizzi mai davvero. Non sono i volumi (per quanto alti) a emozionare, ma la perizia che il trio dimostra sul palco… e in platea, visto che (come accade ormai di consueto) il finale del live è suonato dal mezzo del locale, con i musicisti attaccati a due amplificatori, una drum machine e un rack dal quale partono laser colorati. Come se il vortice di cui sopra si fosse ridotto e i tre l’avessero letteralmente portato in mezzo al pubblico, creando una fucina elettrica in platea.
 Con la seconda parte della serata si volta pagina: un solista prende il posto del trio e il rock cede il passo all’elettronica. Romare è venuto in città a farci scoprire il suo album Projections, uno degli ultimi colpi messi a segno dalla Ninja Tune. Il giovane musicista britannico, alle prese con vari macchinari, sorride timido e riconoscente al pubblico (nettamente più sparuto rispetto alla prima parte della serata, ma del resto l’ora inizia a essere tarda), snocciola brani tratti dal disco e dal precedente ep accompagnato da proiezioni che hanno due soggetti che si ripetono spesso: Robert Johnson e Chet Baker, quest’ultimo raffigurato in varie fasi della sua vita e anche in scene dello pseudo-biopic All the Young Fine Cannibals.
Con la seconda parte della serata si volta pagina: un solista prende il posto del trio e il rock cede il passo all’elettronica. Romare è venuto in città a farci scoprire il suo album Projections, uno degli ultimi colpi messi a segno dalla Ninja Tune. Il giovane musicista britannico, alle prese con vari macchinari, sorride timido e riconoscente al pubblico (nettamente più sparuto rispetto alla prima parte della serata, ma del resto l’ora inizia a essere tarda), snocciola brani tratti dal disco e dal precedente ep accompagnato da proiezioni che hanno due soggetti che si ripetono spesso: Robert Johnson e Chet Baker, quest’ultimo raffigurato in varie fasi della sua vita e anche in scene dello pseudo-biopic All the Young Fine Cannibals.
Rispetto all’album il live è molto più orientato al ballo e al divertimento: dal vivo Romare è meno intimista che nei pezzi in studio, i brani vengono lustrati un po’ dove serve e opportunamente interrotti e ripresi a cavallo del climax di ognuno, con uno stratagemma tipico e consolidato, ma che alla lunga mostra un po’ la corda. Il talento c’è, lui deve solo cercare di non accontentarsi sul palco, esattamente come non lo fa su disco: per quanto il concerto sia stato coinvolgente, si sono notate delle piccole incertezze soprattutto nella scorrevolezza del set. In conclusione, ci permettiamo un consiglio: usare il campionamento di una trombetta da stadio è divertente la prima, la seconda e la terza volta, ma dalla quarta in poi diventa un inutile tormentone.
Recensione pubblicata originariamente sul numero di maggio 2015 de Il Mucchio Selvaggio


 L’Iraq di vent’anni fa era un casino: era appena finita la seconda guerra del Golfo, il Paese era frammentato, diviso e pericoloso. Soprattutto, allora come oggi, in Iraq c’era tantissima sofferenza umana, dovuta a decenni di regimi, guerre e conflitti di ogni genere.
L’Iraq di vent’anni fa era un casino: era appena finita la seconda guerra del Golfo, il Paese era frammentato, diviso e pericoloso. Soprattutto, allora come oggi, in Iraq c’era tantissima sofferenza umana, dovuta a decenni di regimi, guerre e conflitti di ogni genere. In quei giorni Enzo Baldoni teneva contatti con la sua famiglia, con il giornalista (anch’esso in Iraq) Pino Scaccia, con la redazione di Diario, per cui scriveva, con la blogger Daniela Ceglie, me e pochi altri. L’ultima volta che l’ho sentito, chiamandolo da casa, era il 16 o 17 agosto del 2004. Ero preoccupato perché si era lussato una clavicola, ma mi aveva rassicurato. Stava bene e sarebbe partito per Najaf, che era appena caduta, insieme a una missione della Croce Rossa.
In quei giorni Enzo Baldoni teneva contatti con la sua famiglia, con il giornalista (anch’esso in Iraq) Pino Scaccia, con la redazione di Diario, per cui scriveva, con la blogger Daniela Ceglie, me e pochi altri. L’ultima volta che l’ho sentito, chiamandolo da casa, era il 16 o 17 agosto del 2004. Ero preoccupato perché si era lussato una clavicola, ma mi aveva rassicurato. Stava bene e sarebbe partito per Najaf, che era appena caduta, insieme a una missione della Croce Rossa. Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista.
Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista. Look up here, I’m in heaven
Look up here, I’m in heaven