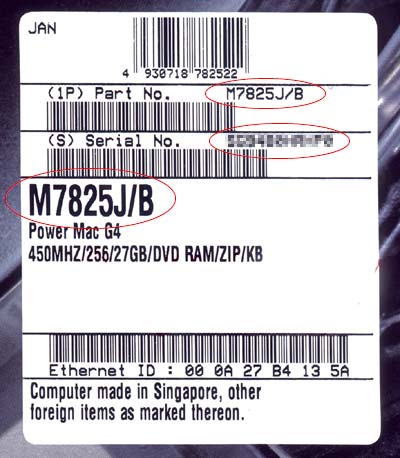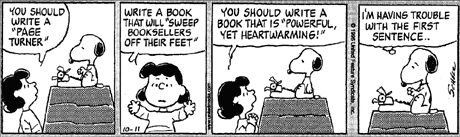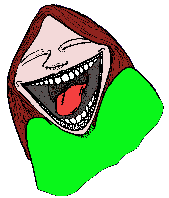No news is good news … but we have news
Poco prima di finire una mattinata di lavoro abbastanza inutile ti balza agli occhi un flash dell’Ansa che dice che Andreotti è stato assolto, almeno per le cose che ha fatto dopo il 1980. Prima: vabbè, è passato del tempo, stai a spaccare il capello…
Mentre pranzi il telegiornale ti informa che è passato il progetto di stupro costituzionale di Calderoli.
Vai dal medico che quando guarda l’irritazione che ti tormenta entrambi i popliti da mesi non trattiene un “E la madonna.” Inizia a sciorinare nomi di pomate e unguenti scrivendoli sulla ricetta, tu lo ascolti solo un po’, fino a che non dice qualcosa come “Relaxar Sin”, allora drizzi le orecchie ti rendi conto che ti ha detto “Bisogna rilassarsi“, e ti rendi conto che il “Relaxar Sin” non si compra. Aggiunge che non se ne parla di mangiare latticini. E ovviamente ieri ti sei comprato dei formaggi buonissimi. Poi aggiunge “E niente crostacei” e ti viene da rispondergli “Ma come, ho sei chili di aragoste nel congelatore, e come faccio, adesso?”. Ma sai che lui non riderebbe.
Vado a mettere i dischi per la festa della mia radio, al posto di mr. Papero. Solo musica stupida e danzereccia. Ci mancherebbe altro.
P.S. Questo potrebbe anche valere una candidatura ai Poverino’s, ma attenzione: per i primi due punti i poverini siamo tutti noi.