Sono tornati!
 Ma come chi? I Fleet Foxes (qui il resoconto di uno dei concerti della vita, e mica solo per la musica).
Ma come chi? I Fleet Foxes (qui il resoconto di uno dei concerti della vita, e mica solo per la musica).
[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/9872558″]
 Ma come chi? I Fleet Foxes (qui il resoconto di uno dei concerti della vita, e mica solo per la musica).
Ma come chi? I Fleet Foxes (qui il resoconto di uno dei concerti della vita, e mica solo per la musica).
[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/9872558″]
Capita, no, che uno aspetta tantissimo una cosa e poi venga in realtà stupito da qualcos’altro arrivato per caso. Si dice serendipità? Non lo so. Comunque, mercoledì sera sono arrivati in città in Godspeed You! Black Emperor: erano dieci anni che li attendevo, dopo averli visti per la prima e unica volta al vecchio Link. Prima di loro, però, è salito sul palco un uomo con un sassofono basso e ha iniziato a fare delle cose incredibili. Grazie a J. ho scoperto che si trattava di Colin Stetson, americano, dal curriculum impressionante, marito della violinista degli Arcade Fire (dove dà una mano anche lui), ma soprattutto dotato di poteri magici. Vedere (e sentire) per credere.
E poi alla fine i Godspeed sono stati meno emozionanti del previsto.
[youtube=http://youtu.be/ykISAaF6Rk4]
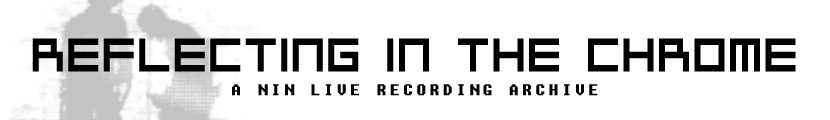
Dopo il Golden Globe, ora Trent Reznor e Atticus Ross concorrono per l’Oscar come migliore colonna sonora. Qui si giubila solo all’idea, e nel frattempo segnalo un sito che è l’ulteriore conferma che la comunità di fan intorno ai NIN è calorosa, numerosa e tecnologicamente avanzata.
In Reflecting the Chrome ci sono centinaia di live dei NIN dal primo all’ultimo tour.
Da scaricare gratis, ovviamente.
E il giubilo aumenta.
È uscito il nuovo numero di Jam, una rivista mensile di musica ben fatta e scevra da entusiasmi dell’ultimo minuto per una o l’altra band a caso. Nelle prime pagine c’è un mio pezzo, con tanto di foto, del concerto in memoria di John Lennon: insomma, il motivo originario per cui sono andato a Liverpool lo scorso mese.
Se volete, l’articolo è qua.
Se invece vi siete persi il resoconto liverpudlian, ecco le tre comode puntate.

Se la proprietà transitiva fosse il vettore su cui si regolano le relazioni nel mondo, e se ci fosse una giustizia basata sulla coerenza, potremmo assistere presto allo scontro tra lo storico bassista dei Kiss e il critico musicale di Repubblica. Perché? Perché Gene si è schierato con ferocia contro i download illegali e Assante, nella sua lista sul meglio della musica del 2010, ha inserito il nuovo disco di Iron&Wine, che esce, però, tra un mese.
Ah, manco a dirlo, ma l’articolo su Simmons indovinate chi l’ha scritto?
P.S. Buon anno a voi, miei ormai pochissimi ma fidati lettori!
 Ho vissuto il fine settimana precedente a quello che ci siamo appena lasciati alle spalle in una strana condizione. ISBN Edizioni mi aveva fatto avere il cofanetto di Avere Ventanni appena in tempo, appunto, per il week-end, e sapevo che avrei avuto solo quei giorni per preparare l’intervista a Massimo Coppola. Venticinque ore di documentari in meno di cinque giorni. Sono sei ore al giorno. Mica poco. Ma ce l’ho fatta, a discapito della mia presenza nel mondo reale, come succede sempre quando ci si immerge in qualcosa di totalizzante.
Ho vissuto il fine settimana precedente a quello che ci siamo appena lasciati alle spalle in una strana condizione. ISBN Edizioni mi aveva fatto avere il cofanetto di Avere Ventanni appena in tempo, appunto, per il week-end, e sapevo che avrei avuto solo quei giorni per preparare l’intervista a Massimo Coppola. Venticinque ore di documentari in meno di cinque giorni. Sono sei ore al giorno. Mica poco. Ma ce l’ho fatta, a discapito della mia presenza nel mondo reale, come succede sempre quando ci si immerge in qualcosa di totalizzante.
Vedere Avere Ventanni con questa modalità non è una cosa che posso consigliarvi di fare: rischierei la denuncia per ipnosi indotta. Ma vedere di seguito le tre serie andate in onda su MTV tra il 2004 e il 2006 ha anche diversi vantaggi. Il primo è percepire sensibilmente gli aggiustamenti di rotta degli autori (oltre a Coppola ci sono Giovanni Giommi, Alberto Piccinini e Latino Pellegrini) nelle prime puntate della prima serie. Coppola all’inizio prova a fare il suo alter ego (talvolta fastidioso) che c’era in Brand:new o in Pavlov, ma la realtà lo supera a destra. Comincia quindi giustamente a pensare che è un altro Coppola che deve porsi di fronte ai ventenni che incontra in giro per l’Italia: usa allora il retroterra filosofico, ma nel senso più pragmatico possibile. Coppola, quindi, inizia a domandare cose semplici e d’ordine quotidiano agli “eroi” delle puntate: cosa fanno, qual è il mestiere dei genitori, quanto guadagnano, se sono fidanzati. Entra nelle case, nelle stanze degli studentati, nei karaoke bar, nei cantieri, negli androni dei palazzi, nelle macchine, negli uffici. Spesso va in un posto per parlare con qualcuno e scopre che la storia di un altro è molto più interessante: l’obiettivo cambia repentinamente, libero da ogni pesantezza produttiva, considerando che tutto è realizzato con tecnologie digitali portatili. Infine Coppola e i suoi ascoltano, con curiosità e partecipazione, ma senza compatimenti. E, quando arriva la compassione, quando neanche gli autori riescono a trattenere il dolore e la tristezza, semplicemente, abbassano la camera e la spengono.
 Interrompere una registrazione è un atto realmente rivoluzionario, in ambiti intimi come quelli raccontati da Avere Ventanni. Nell’intervista potete ascoltare cosa Coppola pensa di quella che ho chiamato “etica della videocamera”, e di cui ho parlato spesso qua sul blog. Che senso ha zoomare sulle lacrime, infilare obiettivi tra le sbarre di cancelli chiusi, nominare ripetutamente le persone uccise, domandare tenendo attaccato il microfono all’altoparlante di un citofono? Nessuno. Eppure è così che la televisione italiana intende l’informazione, nella maggior parte dei casi. Già per questo Avere Ventanni ha un valore programmatico fortissimo ma, ahinoi, del tutto inascoltato. Il pudore e l’intelligenza di questi documentari sono un episodio occasionale e isolato nell’ambito televisivo italiano.
Interrompere una registrazione è un atto realmente rivoluzionario, in ambiti intimi come quelli raccontati da Avere Ventanni. Nell’intervista potete ascoltare cosa Coppola pensa di quella che ho chiamato “etica della videocamera”, e di cui ho parlato spesso qua sul blog. Che senso ha zoomare sulle lacrime, infilare obiettivi tra le sbarre di cancelli chiusi, nominare ripetutamente le persone uccise, domandare tenendo attaccato il microfono all’altoparlante di un citofono? Nessuno. Eppure è così che la televisione italiana intende l’informazione, nella maggior parte dei casi. Già per questo Avere Ventanni ha un valore programmatico fortissimo ma, ahinoi, del tutto inascoltato. Il pudore e l’intelligenza di questi documentari sono un episodio occasionale e isolato nell’ambito televisivo italiano.
Ma l’importanza di Avere Ventanni va oltre l’aspetto etico e formale a cui ho accennato. Vedere decine di ore di girato in pochi giorni mi ha illuminato sulla rilevanza storico-documentale che questo cofanetto ha. Ricordo ancora quando, nelle prime lezioni di storia delle superiori, il professore ci spiegò che cosa si intendesse per “documento” in quell’ambito. Scorrendo le storie raccontate nel cinque dvd, mi è tornato in mente il significato primo di questo termine molto usato (e quindi spesso abusato): effettivamente queste puntate sono un documento storico importantissimo per l’Italia contemporanea, ogni minuto e ogni inquadratura è portatrice di significato e ben contestualizzata. Assenza di riferimenti politici, disgregazione sociale, povertà, disillusione, ignoranza, violenza. “Erano anni dolorosi”, mi ha detto Coppola, usando il passato solo per coerenza, visto che gli stavo chiedendo di quei primi anni zero in cui Avere Ventanni è stato girato: le cose non sono poi così tanto cambiate. Attenzione, però: si potrebbe obiettare che l’obiettivo dell'”indagine” degli autori fosse la condizione giovanile di quel periodo. Nonostante questo io credo che, alla fine, Avere Ventanni parli del Paese tutto: perché, sebbene le classi dirigenti italiane facciano di tutto per negarlo o ignorarlo, sono i ventenni che iniziano a costruire, ricostruire ed eventualmente a cambiare una nazione. Proprio quelli che oggi stanno abbandonando in massa l’Italia e che, solo sei anni fa, avevano ventanni.
 Sapevo solo vagamente chi fosse Robert Lowell, a cui è intitolata la prima traccia del nuovo disco dei Massimo Volume, Cattive abitudini. Ho scoperto che è stato il fondatore della “Poesia confessionale”, ma è divertente (e bellissimo) che la pagina Wikipedia dedicata al poeta parli di “poesia confusionale“.
Sapevo solo vagamente chi fosse Robert Lowell, a cui è intitolata la prima traccia del nuovo disco dei Massimo Volume, Cattive abitudini. Ho scoperto che è stato il fondatore della “Poesia confessionale”, ma è divertente (e bellissimo) che la pagina Wikipedia dedicata al poeta parli di “poesia confusionale“.
Non c’è nulla di confusionale, in Cattive abitudini: le linee di chitarra traggono forza dal rumore e leggerezza dai silenzi, quando sono più o meno rarefatte. La batteria è una sicurezza, amalgamata al basso: insomma, sono tornati i Massimo Volume, come ce li ricordavamo, e come li abbiamo visti dal vivo dal 2008 a oggi. Dentro e fuori dall’onda ho parlato molte con Mimì, Vittoria, Egle e Stefano: la reunion è stata un successo e i live ne sono la conferma, ma il disco? La domanda, insomma, che sicuramente oltre che da a me gli è stata posta da tanti altri. “Tanto vale dirlo subito, confessarlo“, avranno pensato.
chi l’avrebbe mai detto
di ritrovarci qui,
giugno 2010
in un pomeriggio
di pioggia e di sole
seduti di fronte
alle nostre parole?(“Robert Lowell”)
 Forse è vero, forse nessuno di voi l’avrebbe detto, ma eccoci, il disco è già iniziato da qualche secondo e sono loro, proprio loro, non c’è dubbio. Non si sono fatti tentare da impasti di riverberi, basi elettroniche più o meno raffinate, né dai sorrisi della gente sotto il palco più giovane di quando loro stessi avevano iniziato a suonare, vent’anni fa. Si sono chiusi in uno studio sulle rive del Po, quest’estate, e hanno tirato fuori un’ora di musica potente e lucida, su cui e con cui Clementi, ancora una volta, racconta storie popolate da luci e sensazioni che in una manciata di righe ti si piantano nella testa. I testi sono scritti su carta intestata di diversi alberghi, dalla Svizzera a Londra, da Rimini a Venezia, e il libretto riporta, oltre ai bellissimi disegni di BJ, solamente quelli e qualche nota tecnica. Mi è venuto voglia, ascoltando il disco, di prendere un atlante e immaginare dei viaggi, seguendo quegli alloggi temporanei con nomi altisonanti, ma le parole mi hanno riportato a loro con pressante dolcezza. E così sono stato a “Coney Island” ,in una stanza chiusa a chiave, tra i deliri di Leo e le asprezze delle donne descritte da Clementi, l’ossessione del tempo, scandito da arpeggi e distorsori, fino al letto di morte di qualcuno, trasfigurato nei ricordi e nella fantasia di un impossibile ritorno.
Forse è vero, forse nessuno di voi l’avrebbe detto, ma eccoci, il disco è già iniziato da qualche secondo e sono loro, proprio loro, non c’è dubbio. Non si sono fatti tentare da impasti di riverberi, basi elettroniche più o meno raffinate, né dai sorrisi della gente sotto il palco più giovane di quando loro stessi avevano iniziato a suonare, vent’anni fa. Si sono chiusi in uno studio sulle rive del Po, quest’estate, e hanno tirato fuori un’ora di musica potente e lucida, su cui e con cui Clementi, ancora una volta, racconta storie popolate da luci e sensazioni che in una manciata di righe ti si piantano nella testa. I testi sono scritti su carta intestata di diversi alberghi, dalla Svizzera a Londra, da Rimini a Venezia, e il libretto riporta, oltre ai bellissimi disegni di BJ, solamente quelli e qualche nota tecnica. Mi è venuto voglia, ascoltando il disco, di prendere un atlante e immaginare dei viaggi, seguendo quegli alloggi temporanei con nomi altisonanti, ma le parole mi hanno riportato a loro con pressante dolcezza. E così sono stato a “Coney Island” ,in una stanza chiusa a chiave, tra i deliri di Leo e le asprezze delle donne descritte da Clementi, l’ossessione del tempo, scandito da arpeggi e distorsori, fino al letto di morte di qualcuno, trasfigurato nei ricordi e nella fantasia di un impossibile ritorno.
te ne sei andato docile
tra le mie braccia
nella tua arida notte
che un giorno sarà la mia(“Mi piacerebbe ogni tanto averti qui”)
E d’accordo, a nessun poeta o scrittore piace sentirsi rivolgere la domanda “Ma quanto c’è di autobiografico in tutto questo”, però l’idea che Lowell fosse messo là in cima non per caso è arrivata, ma è stata subito spazzata via da un’apertura melodica e armonica che i Massimo Volume hanno raramente mostrato. Un trio femminile (Vittoria Burattini e Marcella Riccardi, una titolare e una “ex”, e Angela Baraldi) accompagna e innalza la consapevolezza, il cui dolore sfocia poi in “Fausto”, disperata e urlata: non a caso quest’ultimo brano contiene una citazione da “L’urlo” di Ginsberg, dove però la distruzione della generazione del poeta avveniva per follia; nel nostro “mondicino” basta scegliere di apparire per una serata in tv per perdersi rimanendo vestiti (lontani dalla nudità primitiva e folle di Ginsberg), “intonando il vestito al tema della puntata”.
Ma lo si può anche non fare: si può anche scegliere di ricordare, di non tradire. Così come si può tornare, quasi dieci anni dopo essersene andati, perché si ha davvero qualcosa da dire. E lo si fa alla perfezione.
(Ancora una volta avrò i Massimo Volume ospiti a Maps, venerdì 15 ottobre alle 16. E neanche a dirlo, Cattive abitudini è il nostro disco della settimana).
 James Murphy è un buon furbacchione: non è uno che frega o se ne approfitta, per intenderci, ma semplicemente uno che da anni e anni è molto attento a quello che accade nel mondo musicale. Sente, percepisce, intuisce, riprende, rimastica, ripropone con varianti. Tanto di cappello, eh, mica stiamo sempre a cercare l’originalità assoluta (un concetto, peraltro, che nel 2010 lascia davvero il tempo che trova).
James Murphy è un buon furbacchione: non è uno che frega o se ne approfitta, per intenderci, ma semplicemente uno che da anni e anni è molto attento a quello che accade nel mondo musicale. Sente, percepisce, intuisce, riprende, rimastica, ripropone con varianti. Tanto di cappello, eh, mica stiamo sempre a cercare l’originalità assoluta (un concetto, peraltro, che nel 2010 lascia davvero il tempo che trova).
Un altro grande furbastro è, da sempre, David Bowie. Anche lui, soprattutto negli ultimi trent’anni, è stato fondamentalmente con le orecchie ben tese su quello che accadeva in ambito musicale nel mondo, USA e Regno Unito principalmente, per cogliere poi i frutti appena sbocciati delle nuove tendenze e personalizzarli.
Perché mettere insieme questi due personaggi, apparentemente non così vicini? Perché il concerto di Ferrara degli LCD Soundsystem ha confermato quello che io (e altri) abbiamo sentito non appena è giunto alle nostre orecchie This is happening, l’ultimo album dei newyorkesi: c’è un sacco di Bowie negli LCD Soundsystem, soprattutto del Bowie della trilogia berlinese, di quei brani più lenti e ipnotici, che sfruttano armonizzazioni vocali e tappeti di sintetizzatori.
 Assistendo allo splendido spettacolo di Ferrara, inoltre, si è sentita questa influenza, o richiamo, in tanti altri brani della scaletta, anche dei dischi vecchi. Non si è trattato di allucinazioni uditive, per carità, ma di alcuni attimi, suggestioni e brani che, effettivamente, mi hanno riportato alla mente alcuni arrangiamenti dei pezzi di Low, Lodger e “Heroes“. L’altra sorpresa è stata il notare le grandi doti di cantante di Murphy: una voce profonda, quasi da crooner, che non aveva paura allo stesso tempo di sfidare registri più acuti, rimanendo sempre in totale controllo. Anche qui non riesco a non pensare alla versatilità vocale di Bowie, che ci posso fare? E, infine, l’attenzione a quello che accade oggi nel mondo musicale di cui si parlava sopra: il finale del concerto degli LCD è stato esemplare, com la splendida “New York I Love You” che è sfociata in una versione piano e voci di “Empire State of Mind”, spogliata del tutto dall’iperproduzione di Jay-Z e, in qualche modo, rifatta lì, dal vivo, davanti ai nostri occhi, come se James Murphy l’avesse scritta e ce la restituisse come lui la intendeva. E pazienza se la mania di controllo totale del musicista lo rendesse quasi ridicolo, per il continuo comunicare col fonico di palco e per l’aggiustamento senza sosta di aste e microfoni: tanto più che tutto questo perfezionismo è stato spazzato via da un blackout dell’impianto di diffusione, con il pubblico che non sentiva più niente mentre la band, assordata dai volumi dei monitor sul palco continuava a suonare come se nulla fosse accaduto. Pazienza, perché il concerto dell’altra sera è stata l’ennesima prova della statura di Murphy. Staremo a vedere, quindi, che ne sarà di lui, con o senza LCD Soundsystem. Che possa convincere Bowie a tornare sulle scene? Fantasie da inizio settimana…
Assistendo allo splendido spettacolo di Ferrara, inoltre, si è sentita questa influenza, o richiamo, in tanti altri brani della scaletta, anche dei dischi vecchi. Non si è trattato di allucinazioni uditive, per carità, ma di alcuni attimi, suggestioni e brani che, effettivamente, mi hanno riportato alla mente alcuni arrangiamenti dei pezzi di Low, Lodger e “Heroes“. L’altra sorpresa è stata il notare le grandi doti di cantante di Murphy: una voce profonda, quasi da crooner, che non aveva paura allo stesso tempo di sfidare registri più acuti, rimanendo sempre in totale controllo. Anche qui non riesco a non pensare alla versatilità vocale di Bowie, che ci posso fare? E, infine, l’attenzione a quello che accade oggi nel mondo musicale di cui si parlava sopra: il finale del concerto degli LCD è stato esemplare, com la splendida “New York I Love You” che è sfociata in una versione piano e voci di “Empire State of Mind”, spogliata del tutto dall’iperproduzione di Jay-Z e, in qualche modo, rifatta lì, dal vivo, davanti ai nostri occhi, come se James Murphy l’avesse scritta e ce la restituisse come lui la intendeva. E pazienza se la mania di controllo totale del musicista lo rendesse quasi ridicolo, per il continuo comunicare col fonico di palco e per l’aggiustamento senza sosta di aste e microfoni: tanto più che tutto questo perfezionismo è stato spazzato via da un blackout dell’impianto di diffusione, con il pubblico che non sentiva più niente mentre la band, assordata dai volumi dei monitor sul palco continuava a suonare come se nulla fosse accaduto. Pazienza, perché il concerto dell’altra sera è stata l’ennesima prova della statura di Murphy. Staremo a vedere, quindi, che ne sarà di lui, con o senza LCD Soundsystem. Che possa convincere Bowie a tornare sulle scene? Fantasie da inizio settimana…
 Ok, ora sono in onda, ma tra qualche ora sarò a Ferrara per il concerto dei Pixies. In occasione della prima data all’aperto di Ferrara sotto le stelle 2010, quei mattacchioni di Ciccsoft distribuiranno un foglio sulla band americana a metà tra il buffo e il nostalgico che si avvale di firme prestigiose, e della mia, anche.
Ok, ora sono in onda, ma tra qualche ora sarò a Ferrara per il concerto dei Pixies. In occasione della prima data all’aperto di Ferrara sotto le stelle 2010, quei mattacchioni di Ciccsoft distribuiranno un foglio sulla band americana a metà tra il buffo e il nostalgico che si avvale di firme prestigiose, e della mia, anche.
Vasco Brondi, Enzo, Accento Svedese e Simone sono stati chiamati a raccontare chi sono i Pixies per loro. Io ho usato la parola “sbilenco”, più di una volta. Se non siete in piazza Castello stasera, potete scaricare il tutto qua.
Grazie a voi che leggete e ai Ciccsoft boys per la preferenza.

Come da tradizione, Trent e la parola gratis vanno a braccetto! Qui sotto potete ascoltare un brano dell’ep del nuovo progetto di Reznor How to Destroy Angels; qua, invece, potete scaricare il disco senza spendere alcunché.
Un tempo si poteva ascoltare, ma i link muoiono…