Dagli archivi: Bombino + Above the Tree & Drum Ensemble Du Beat, Locomotiv Club, Bologna, 13 febbraio 2014
Una serata all’insegna di musiche ancestrali e desertiche, dei loro mescolamenti e delle loro naturali proiezioni, quella di giovedì 13 febbraio al Locomotiv Club di Bologna: due set del musicista tuareg, uno acustico e uno elettrico, e la nuova incarnazione di Above the Tree per oltre due ore di musica di buonissima qualità.
“È molto bello suonare in Italia”, dice Omara Moctar e forse il ringraziamento sentito del musicista va oltre il cliché, visto che il nome d’arte Bombino è la storpiatura del nostro “bambino”: Omara in effetti ha un viso giovanissimo, luminoso e felice, che pare non soffra il caldo del club che ospita una delle date italiane del tour invernale di Nomad, uscito l’anno scorso per la Nonesuch.
Prima dei musicisti tuareg, però, c’è spazio per un support act di tutto rispetto: Marco Bernacchia, cioè Above the Tree, presenta il nuovo album Cave_Man insieme a Enrico “Mao” Bocchini e Edoardo Grisogani. Above the Tree & Drum Ensemble Du Beat affascina il pubblico mischiando con intelligenza percussioni “primitive”, suggestioni tribali, linee di elettronica e chitarra, risultando originale e personale, antico e modernissimo allo stesso tempo.
Non poteva esserci introduzione migliore ai set di Bombino: insieme ai suoi tre musicisti, Moctar sale sul palco per un raffinato live acustico che mostra subito la padronanza che il nostro ha del suo strumento. Una chitarra che, già nell’introduzione al secondo brano, scivola verso il blues: il concerto svela da subito il leit motiv della serata, banalissimo a parole, ma non nei fatti. E cioè che dobbiamo all’Africa la stragrande maggioranza della musica che ascoltiamo.
Se, infatti, il primo set è più tradizionale, quando gli strumenti (due chitarre, basso, batteria) vengono collegati agli amplificatori, veniamo trasportati in un vortice che si allontana e torna continuamente al Sahara, sporcandosi di reggae e garage e, talvolta, diventando quel misto di blues e rock che ha fatto andare in brodo di giuggiole Dan Auerbach, produttore di Nomad, da cui proviene una buona parte dei brani in scaletta. I pezzi, rispetto al disco, si allargano e viaggiano liberi, vanno da ritmi in battere a quelli in levare; la chitarra di Bombino chiacchiera, urla, sputa grappoli di note che vibrano tra la musica tradizionale tuareg e tutte le contaminazioni attuate e subite in secoli di storia e migrazioni.
Talvolta, forse, c’è troppa indulgenza in alcune code o passaggi, ma quando uno è bravissimo a suonare è facile perdonare che possa provare piacere e divertimento nell’ascoltarsi tanto quanto chi lo acclama sotto il palco.
Recensione pubblicata originariamente sul numero di marzo 2014 de Il Mucchio Selvaggio


 Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista.
Il 18 gennaio 2008 Damo Suzuki si esibiva, con il suo progetto Damo Suzuki Network, al Locomotiv Club di Bologna. Quel pomeriggio ho avuto la possibilità di ospitarlo in Maps, la trasmissione musicale pomeridiana di Radio Città del Capo. In occasione della recente scomparsa del musicista, ho trascritto e tradotto l’intervista. Quasi vent’anni fa pubblicavo sul blog
Quasi vent’anni fa pubblicavo sul blog  Ogni volta che riascolto dall’inizio alla fine l’ultimo disco dei Thee Silver Mt. Zion ho una reazione fisica: un brivido che sale per scoppiare puntuale intorno al secondo minuto e mezzo della penultima traccia, “
Ogni volta che riascolto dall’inizio alla fine l’ultimo disco dei Thee Silver Mt. Zion ho una reazione fisica: un brivido che sale per scoppiare puntuale intorno al secondo minuto e mezzo della penultima traccia, “
 Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”.
Nel dicembre 2010 TomDicillo scrive sul suo blog: “Quando mi sono svegliato stamane ho scoperto che When You’re Strange ha ricevuto una candidatura ai Grammy. La categoria è video di lungo formato (dvd), il che va bene, sebbene sia stato concepito, prodotto e distribuito come film”. Una delle band più importanti e influenti della storia dell’hardcore celebra nel 2011 due anniversari: trentacinque anni dalla fondazione e dieci dallo scioglimento. Stiamo parlando dei Black Flag, che nel lasso intercorso tra il 1976 e il 1986 diedero davvero una spinta notevolissima all’undereground culturale statunitense e non solo.
Una delle band più importanti e influenti della storia dell’hardcore celebra nel 2011 due anniversari: trentacinque anni dalla fondazione e dieci dallo scioglimento. Stiamo parlando dei Black Flag, che nel lasso intercorso tra il 1976 e il 1986 diedero davvero una spinta notevolissima all’undereground culturale statunitense e non solo.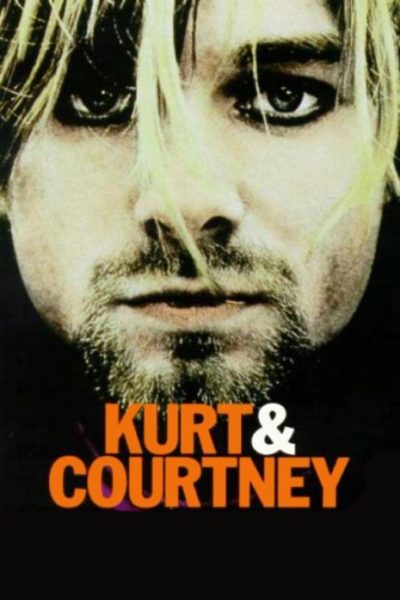 Il regista e giornalista inglese Nick Broomfield ha diretto nel 1998 Kurt and Courtney. Stimolato dai misteri legati alla fine del leader dei Nirvana, Broomfield va per conto della BBC negli Stati Uniti occidentali, tra California e Washington, per capire che è successo davvero.
Il regista e giornalista inglese Nick Broomfield ha diretto nel 1998 Kurt and Courtney. Stimolato dai misteri legati alla fine del leader dei Nirvana, Broomfield va per conto della BBC negli Stati Uniti occidentali, tra California e Washington, per capire che è successo davvero. Nel 2004, invece, nel decennale della morte, esce il cofanetto With the Lights Out: in tre cd e un dvd si mette in luce il lato inedito della musica dei Nirvana.
Nel 2004, invece, nel decennale della morte, esce il cofanetto With the Lights Out: in tre cd e un dvd si mette in luce il lato inedito della musica dei Nirvana.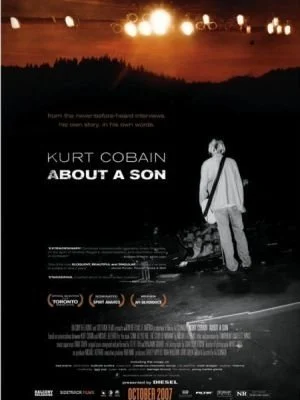 Infine, Kurt Cobain: about a son. Diretto da A.J. Schnack nel 2006, è un documentario bellissimo.
Infine, Kurt Cobain: about a son. Diretto da A.J. Schnack nel 2006, è un documentario bellissimo. Look up here, I’m in heaven
Look up here, I’m in heaven