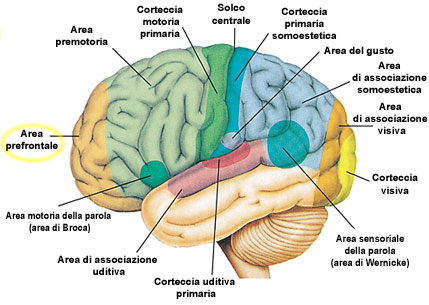Neighbours 12
 Qualche tempo fa la vicina dell’appartamento di sopra, N., se n’è andata cercar la fortuna in giro per il mondo. “Affitterò l’appartamento a qualcuno”, mi aveva detto. “Fammi sapere”, avevo replicato io, dimenticandomi poi della cosa. Qualche mese fa ho iniziato a sentire dei rumori provenire dal piano di sopra. Passi pesanti, che facevano scricchiolare lievemente anche alcune cose intorno a me.
Qualche tempo fa la vicina dell’appartamento di sopra, N., se n’è andata cercar la fortuna in giro per il mondo. “Affitterò l’appartamento a qualcuno”, mi aveva detto. “Fammi sapere”, avevo replicato io, dimenticandomi poi della cosa. Qualche mese fa ho iniziato a sentire dei rumori provenire dal piano di sopra. Passi pesanti, che facevano scricchiolare lievemente anche alcune cose intorno a me.
“Sono i solai di legno: materiale elastico, e quindi con capacità ottime di trasmissione delle vibrazioni, senza incorrere in deformazioni”, pensavo aggrappandomi a brandelli di nozioni di educazione tecnica delle medie e fisica delle superiori. “Qualcuno c’è” concludevo, “ma non è detto che sia un ciccione: gli stessi tonfi li sentivo quando N. si muoveva nel suo appartamento, e N. non è di certo una cicciona.”
Poi ho scambiato due parole con N. su Skype.
“Sì, c’è un nuovo inquilino, ho affittato l’appartamento”, mi ha detto. “Non si è presentato?”
“Veramente no”, le ho scritto io, pensando che continuo a conoscere pochissime delle persone che vivono nel palazzo dove abito.
“Gli dirò di farsi vivo”, mi ha assicurato lei. Nessuno si è ancora presentato, almeno fisicamente alla mia porta. Perché ormai le abitudini del misterioso vicino del piano di sopra sono ormai assodate, soprattutto nelle ore notturne. Ama guardare la televisione, forse a letto, un tempo a volumi più alti di ora, sempre tra mezzanotte e l’una. Poi, presumo, spegne televisore e abat-jour e si mette a dormire. Per qualche minuto c’è silenzio. Poi, nella quiete della notte che ci può essere in una viuzza del centro storico di Bologna, si sente yyaaaaawwwwnnn. Uno sbadiglio quasi ferino, ma che ha in sè anche il godimento dell’aver raggiunto il riposo dopo una giornata faticosa. Lo sbadiglio che vorrei fare io, ma che non mi viene. “Perché?”, mi chiedo. Ma nel frattempo sento che il mio vicino si addormenta e anche io decido che posso assopirmi.

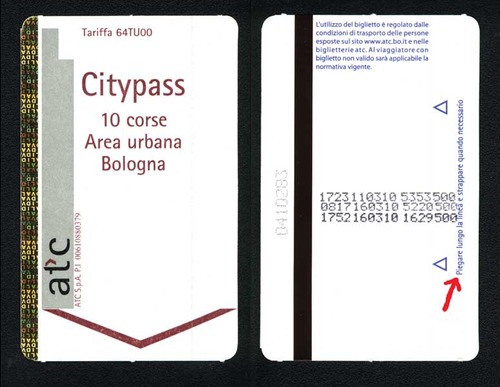 L’autobus che mi ha riportato a casa venerdì pomeriggio mi ha visto stanco, troppo stanco per reagire a quello che ho visto e sentito.
L’autobus che mi ha riportato a casa venerdì pomeriggio mi ha visto stanco, troppo stanco per reagire a quello che ho visto e sentito. L’altro giorno entro in un tabacchino: aspettavo un amico che non arrivava e ho deciso di comprarmi delle gomme da masticare e ripararmi dalla pioggia. Appena varco la soglia del negozio, un cliente mi dice: “Torna subito”. Immagino si riferisca al proprietario dell’esercizio, che poco dopo fa la sua comparsa. L’uomo si presenta urlando, ma con aria divertita, ed esclama senza indugi: “A quei tre stronzi, la prossima volta, gliela faccio vedere io. Mi tiro giù le braghe, mi metto carponi, e gli faccio parcheggiare la bicicletta tra le mie chiappe.” I pochi clienti nel locale non reagiscono, ma il silenzio viene di nuovo riempito dal vocione dell’uomo, che ripete la questione. “Quanti sono? Ah, ma vedono: giù le braghe e che mi mettano la bicicletta nel solco del culo.”
L’altro giorno entro in un tabacchino: aspettavo un amico che non arrivava e ho deciso di comprarmi delle gomme da masticare e ripararmi dalla pioggia. Appena varco la soglia del negozio, un cliente mi dice: “Torna subito”. Immagino si riferisca al proprietario dell’esercizio, che poco dopo fa la sua comparsa. L’uomo si presenta urlando, ma con aria divertita, ed esclama senza indugi: “A quei tre stronzi, la prossima volta, gliela faccio vedere io. Mi tiro giù le braghe, mi metto carponi, e gli faccio parcheggiare la bicicletta tra le mie chiappe.” I pochi clienti nel locale non reagiscono, ma il silenzio viene di nuovo riempito dal vocione dell’uomo, che ripete la questione. “Quanti sono? Ah, ma vedono: giù le braghe e che mi mettano la bicicletta nel solco del culo.”









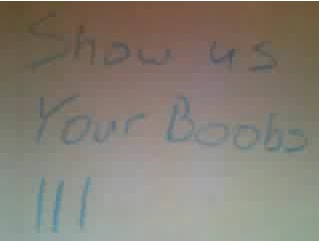
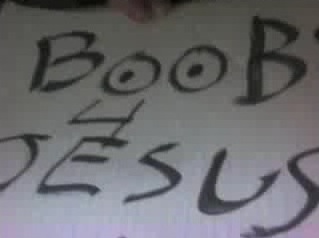








 “Oggi me ne vado via prima”, aveva detto ai colleghi. “Eh, già”, l’aveva canzonato uno di loro. “Oggi ti porti a casa la dottoressa…”. Gli altri avevano riso, e anche lui si era lasciato andare a una risatina. Perché lo sapeva che era invidia, la loro. Gliel’aveva letto in faccia quando lei era andata al banco per la prima volta, e si era fatta servire di totani e sarde da lui, e da nessun altro. Avevano parlato, mentre lui puliva rapidamente i pesci davanti ai suoi occhi: era in paese per occuparsi dell’apertura di una nuova galleria d’arte. “Arte”, aveva detto lui. “Contemporanea”, aveva aggiunto lei. “Anche se mi sono laureata in storia dell’arte medievale”, aveva concluso. Non gli staccava gli occhi di dosso. Per carità, Salvatore piaceva alle donne, ma… a una laureata? Che cosa mai avrebbe potuto trovarci in uno come lui? E invece la dottoressa, così l’avevano nominata da subito gli altri pescatori, era tornata altre volte, e, tra un foglio di giornale arrotolato e una testa di pesce che guizzava, staccata di netto dal corpo con un colpo secco di coltello, lei e Salvatore parlavano, sorridevano e si guardavano.
“Oggi me ne vado via prima”, aveva detto ai colleghi. “Eh, già”, l’aveva canzonato uno di loro. “Oggi ti porti a casa la dottoressa…”. Gli altri avevano riso, e anche lui si era lasciato andare a una risatina. Perché lo sapeva che era invidia, la loro. Gliel’aveva letto in faccia quando lei era andata al banco per la prima volta, e si era fatta servire di totani e sarde da lui, e da nessun altro. Avevano parlato, mentre lui puliva rapidamente i pesci davanti ai suoi occhi: era in paese per occuparsi dell’apertura di una nuova galleria d’arte. “Arte”, aveva detto lui. “Contemporanea”, aveva aggiunto lei. “Anche se mi sono laureata in storia dell’arte medievale”, aveva concluso. Non gli staccava gli occhi di dosso. Per carità, Salvatore piaceva alle donne, ma… a una laureata? Che cosa mai avrebbe potuto trovarci in uno come lui? E invece la dottoressa, così l’avevano nominata da subito gli altri pescatori, era tornata altre volte, e, tra un foglio di giornale arrotolato e una testa di pesce che guizzava, staccata di netto dal corpo con un colpo secco di coltello, lei e Salvatore parlavano, sorridevano e si guardavano.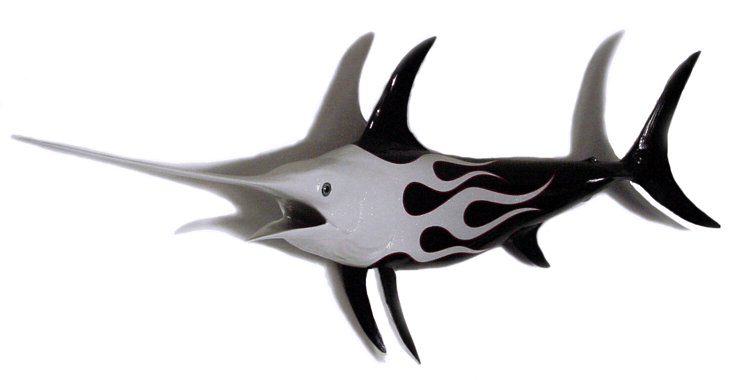 Fino a che, qualche giorno prima, lei l’aveva spiazzato. “Vieni a cenare da me? Ma cucini tu, che ne dici?” gli aveva chiesto. L’ultima volta che Salvatore era arrossito faceva le elementari: se lo ricordava benissimo. Maria, la prima della classe, gli aveva detto, davanti a tutti, che era innamorata di lui e che da quel momento lui era il suo ragazzo. Avere voti alti, evidentemente, era un passe-partout invincibile. Lui, allora, aveva abbassato gli occhi senza dire nulla. Di fronte alla richiesta della dottoressa, gli occhi di Salvatore si erano abbassati di nuovo, mentre mormorava un “Magari andiamo a cena da qualche parte?”, abbastanza piano perché lei non sentisse nulla, ma non abbastanza perché un “Sì, vabbè” di risposta non arrivasse da qualcuno dei suoi compagni. “Come?” aveva detto lei. “No, dicevo che porto il pesce spada”, aveva detto lui. Si erano guardati a lungo, prima di accordarsi e dopo, e poi se n’era andata.
Fino a che, qualche giorno prima, lei l’aveva spiazzato. “Vieni a cenare da me? Ma cucini tu, che ne dici?” gli aveva chiesto. L’ultima volta che Salvatore era arrossito faceva le elementari: se lo ricordava benissimo. Maria, la prima della classe, gli aveva detto, davanti a tutti, che era innamorata di lui e che da quel momento lui era il suo ragazzo. Avere voti alti, evidentemente, era un passe-partout invincibile. Lui, allora, aveva abbassato gli occhi senza dire nulla. Di fronte alla richiesta della dottoressa, gli occhi di Salvatore si erano abbassati di nuovo, mentre mormorava un “Magari andiamo a cena da qualche parte?”, abbastanza piano perché lei non sentisse nulla, ma non abbastanza perché un “Sì, vabbè” di risposta non arrivasse da qualcuno dei suoi compagni. “Come?” aveva detto lei. “No, dicevo che porto il pesce spada”, aveva detto lui. Si erano guardati a lungo, prima di accordarsi e dopo, e poi se n’era andata. Salvatore si era tolto il grembiule e aveva salutato tutti, ma un urlo lo fece tornare indietro. “‘U pisci“, aveva sbraitato uno, agitando un cartoccio con dentro la cena di quella sera. “Grazie”, aveva mormorato Salvatore. “E prego”, aveva detto di rimando quello. “E salutaci tanto la dottoressa, eh”. Salvatore se ne andò sorridendo, ma era attanagliato dalla mattina da un dubbio. Come cucinare quel pescespada? Doveva trovare una ricetta in grado di stupirla, non le solite cose. Qualcosa che lo ponesse sul suo livello, almeno a tavola. Qualcosa di… Ecco, di “contemporaneo”, come aveva detto lei. Ma forse anche qualcosa di più. Rimase a lungo sotto la doccia, fintanto che la puzza di pesce si attenuò per diventare una parte dell’odore della sua pelle, tutt’altro che sgradevole. Poi, vestito con un asciugamano addosso, si mise al computer. Rimase sul pescespada, ma deviò dal “contemporaneo”, andando a casaccio, inserendo parole nel motore di ricerca, senza trovare nulla di convincente, perdendosi tra pagine e pagine che parlavano di tutto, tranne che di cucina di alto livello, per laureati. Si rese conto d’improvviso che era tardi, doveva andare. Ma che fare?
Salvatore si era tolto il grembiule e aveva salutato tutti, ma un urlo lo fece tornare indietro. “‘U pisci“, aveva sbraitato uno, agitando un cartoccio con dentro la cena di quella sera. “Grazie”, aveva mormorato Salvatore. “E prego”, aveva detto di rimando quello. “E salutaci tanto la dottoressa, eh”. Salvatore se ne andò sorridendo, ma era attanagliato dalla mattina da un dubbio. Come cucinare quel pescespada? Doveva trovare una ricetta in grado di stupirla, non le solite cose. Qualcosa che lo ponesse sul suo livello, almeno a tavola. Qualcosa di… Ecco, di “contemporaneo”, come aveva detto lei. Ma forse anche qualcosa di più. Rimase a lungo sotto la doccia, fintanto che la puzza di pesce si attenuò per diventare una parte dell’odore della sua pelle, tutt’altro che sgradevole. Poi, vestito con un asciugamano addosso, si mise al computer. Rimase sul pescespada, ma deviò dal “contemporaneo”, andando a casaccio, inserendo parole nel motore di ricerca, senza trovare nulla di convincente, perdendosi tra pagine e pagine che parlavano di tutto, tranne che di cucina di alto livello, per laureati. Si rese conto d’improvviso che era tardi, doveva andare. Ma che fare?