La lingua e la terra
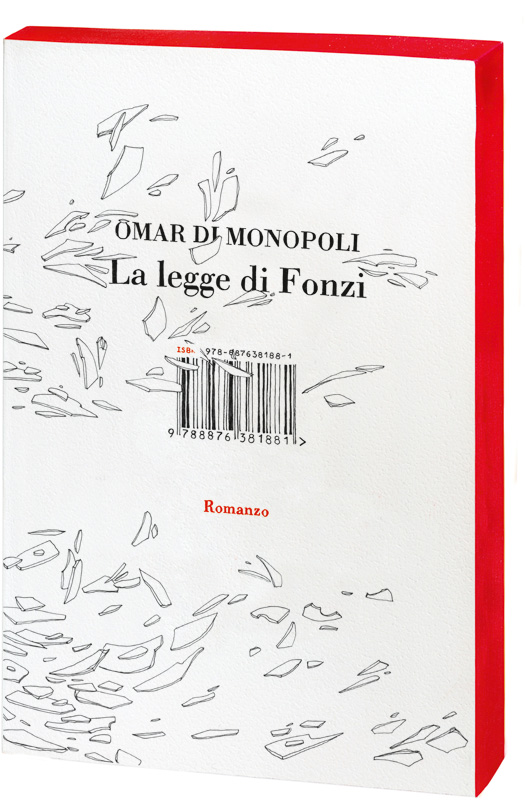 Ogni volta che leggo un libro di Omar Di Monopoli rimango avvinto, oltre che dalla trama, dal modo che Omar ha di raccontare. Questo terzo romanzo edito per ISBN, La legge di Fonzi, non è da meno. La storia, ambientata in una Puglia cruda, selvaggia e cattiva, assai diversa da come l’ente turismo e i giornali ce la vogliono mostrare, è una vicenda violenta, di delitti e vendette, con dei personaggi che non possono scappare dal loro destino di colpa: non si salva nessuno. Ma è il modo di narrare che affascina: il lessico di Di Monopoli è ricchissimo di sfumature, si contagia e sfocia talvolta nel dialetto vero e proprio, con imprechi smozzicati, commistioni con un improbabile italiano, senza in questo essere minimamente ammiccante. Non si tratta, qui, di un’etnicità da salotto, ma di una lingua dura come la terra arsa dal sole, che esclude chi non la capisce, che non fa sconti né regali, come i personaggi che la parlano. Le parole e le espressioni che l’autore sceglie riescono ad essere sinestetiche, multisensoriali: il suono di certe consonanti sfrega sulla pagina come le macchine che sgommano sull’asfalto arso, le maledizioni che lo sfasciacarrozze Skùppetta lancia rimangono appiccicate sul foglio come i suoi scaracchi, si riesce a percepire la povertà delle case e la disperazione. C’è un’attenzione rara alla lingua, insomma, che di per sè varrebbe il prezzo del libro, senza che, tuttavia, il romanzo si riduca a un esercizio di stile.
Ogni volta che leggo un libro di Omar Di Monopoli rimango avvinto, oltre che dalla trama, dal modo che Omar ha di raccontare. Questo terzo romanzo edito per ISBN, La legge di Fonzi, non è da meno. La storia, ambientata in una Puglia cruda, selvaggia e cattiva, assai diversa da come l’ente turismo e i giornali ce la vogliono mostrare, è una vicenda violenta, di delitti e vendette, con dei personaggi che non possono scappare dal loro destino di colpa: non si salva nessuno. Ma è il modo di narrare che affascina: il lessico di Di Monopoli è ricchissimo di sfumature, si contagia e sfocia talvolta nel dialetto vero e proprio, con imprechi smozzicati, commistioni con un improbabile italiano, senza in questo essere minimamente ammiccante. Non si tratta, qui, di un’etnicità da salotto, ma di una lingua dura come la terra arsa dal sole, che esclude chi non la capisce, che non fa sconti né regali, come i personaggi che la parlano. Le parole e le espressioni che l’autore sceglie riescono ad essere sinestetiche, multisensoriali: il suono di certe consonanti sfrega sulla pagina come le macchine che sgommano sull’asfalto arso, le maledizioni che lo sfasciacarrozze Skùppetta lancia rimangono appiccicate sul foglio come i suoi scaracchi, si riesce a percepire la povertà delle case e la disperazione. C’è un’attenzione rara alla lingua, insomma, che di per sè varrebbe il prezzo del libro, senza che, tuttavia, il romanzo si riduca a un esercizio di stile.
In tutto questo, però, La legge di Fonzi non racconta di un mondo atemporale, ma di qualcosa che è ben radicato nei modi d’oggi: a differenza delle altre due, quest’ultima parte di una possibile trilogia è quella in cui il mondo esterno penetra di più nelle vicende. Un mondo che vorrebbe essere luccicante, dell’immagine edulcorata e sorridente, dei VIP, del potere. Un mondo che cozza con il paese di Monte Svevo dove il romanzo è ambientato, e in cui pare che ci sia quasi una forza soprannaturale che tende a mantenere tutto così com’è, rigettando con impeto tutto quello che di nuovo, giovane e pulito possa arrivare, e facendo letteralmente deflagrare ogni tentativo di includere la sua comunità in un contesto più ampio. Come suggello a questa immobilità, Di Monopoli fa campeggiare nei dintorni del paese un cavalcavia, parte di una superstrada mai completata, che incombe come monito sugli abitanti di Monte Svevo.
E nemmeno se lo volessi potrei spiegarle quanta disperazione ci sta, negli occhi di quelle persone [gli abitanti di Monte Svevo, n.d.r.]. Brava gente che magari ha sacrificato una vita per far studiare i propri ragazzi pensando di offrire loro un futuro. E invece quel futuro semplicemente non c’è. Non qui. E non per loro. (…) Quando mi hanno mandato qui, tutti non facevano che ripetermi che la Sacra Corona Unita sarebbe stata l’ultima delle mie preoccupazioni. Lo Stato è intervenuto, dicevano, e l’organizzazione smantellata. Eppure in giro vedo tante di quelle storture, tanto di quel veleno, che a volte penso che quella era solo una sigla, niente di più. Un nome di comodo a uso e consumo dei giornali. (…) Non importa il nome che le diamo, quaggiù il problema più grosso tutta questa rabbia che resta in circolo è, perché come una giostra non fa altro che farci girare su noi stessi, a vuoto, senza arrivare mai da nessuna parte…
(Omar Di Monopoli, La legge di Fonzi, ISBN Edizioni, Milano, 2010, pp. 124-125)
(Domani intervisterò Omar Di Monopoli in diretta a Maps: se volete ascoltare qualcosa sui suoi libri precedenti, cliccate qua e qua).

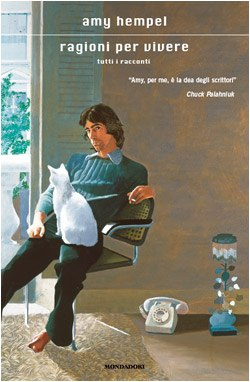 Devo ringraziare
Devo ringraziare  Ok, ora sono in onda, ma tra qualche ora sarò a Ferrara per il concerto dei Pixies. In occasione della prima data all’aperto di
Ok, ora sono in onda, ma tra qualche ora sarò a Ferrara per il concerto dei Pixies. In occasione della prima data all’aperto di 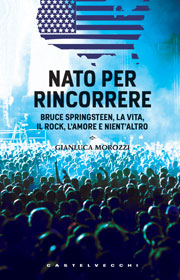 È appena uscito nelle librerie italiche l’ultimo libro di Gianluca Morozzi: si intitola Nato per rincorrere ed è edito da
È appena uscito nelle librerie italiche l’ultimo libro di Gianluca Morozzi: si intitola Nato per rincorrere ed è edito da  Inutile negare che devo molto a
Inutile negare che devo molto a 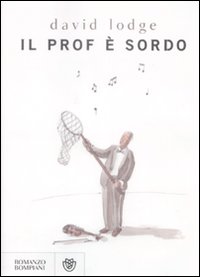
 Se ne è parlato tanto anche su altri blog, e io, appena appresa la notizia, l’ho diffusa come potevo. In sintesi la questione è che Maurizio Costanzo è diventato direttore responsabile dei Gialli Mondadori. Una collana storica, che ha compiuto da poco 80 anni. E fin qui nulla di strano: è solo
Se ne è parlato tanto anche su altri blog, e io, appena appresa la notizia, l’ho diffusa come potevo. In sintesi la questione è che Maurizio Costanzo è diventato direttore responsabile dei Gialli Mondadori. Una collana storica, che ha compiuto da poco 80 anni. E fin qui nulla di strano: è solo  Con la presentazione di La guerra in cucina che terrò domani alle 16 alla
Con la presentazione di La guerra in cucina che terrò domani alle 16 alla