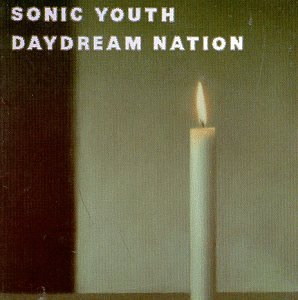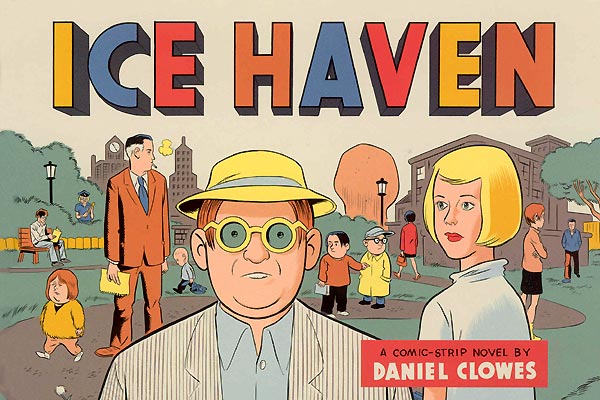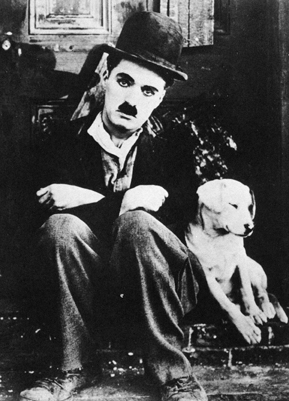Parole di diamante
 Ho incontrato le parole di Olivier Adam per caso, l’anno scorso, quando ho letto la sua prima raccolta di racconti apparsa in Italia, Passare l’inverno: era da molto tempo che non leggevo dei racconti così gelidi, freddi e perfetti, e ho iniziato a consigliare e regalare quella raccolta a tutti. I racconti di Adam erano per me paragonabili a quelli di Carver, ma non semplicemente come accostamento, ma dal punto di vista qualitativo. Un uso delle parole puntuale, le frasi che finivano sempre al punto giusto, un equilibrio della narrazione magistrale. Per questo ho sempre associato la scrittura di Adam all’arte prodigiosa del racconto, un genere che amo moltissimo, ma che, ahimè, pare che in questo paese sia – come il cortometraggio nel cinema – semplicemente una prova necessaria per giungere all’Opera Lunga (romanzo o film).
Ho incontrato le parole di Olivier Adam per caso, l’anno scorso, quando ho letto la sua prima raccolta di racconti apparsa in Italia, Passare l’inverno: era da molto tempo che non leggevo dei racconti così gelidi, freddi e perfetti, e ho iniziato a consigliare e regalare quella raccolta a tutti. I racconti di Adam erano per me paragonabili a quelli di Carver, ma non semplicemente come accostamento, ma dal punto di vista qualitativo. Un uso delle parole puntuale, le frasi che finivano sempre al punto giusto, un equilibrio della narrazione magistrale. Per questo ho sempre associato la scrittura di Adam all’arte prodigiosa del racconto, un genere che amo moltissimo, ma che, ahimè, pare che in questo paese sia – come il cortometraggio nel cinema – semplicemente una prova necessaria per giungere all’Opera Lunga (romanzo o film).
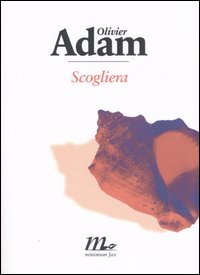 Sono rimasto sorpreso, quindi, quando ho iniziato a leggere Scogliera, uscito qualche mese fa: un romanzo, uno dei tre che Adam ha scritto. Ma la sorpresa si è esaurita nel momento in cui ho cominciato la lettura. Eccole, le parole di Adam, ecco il suo modo unico di raccontare e rappresentare la tristezza e il dolore, sentimenti abusati in ogni modo e con ogni mezzo, ma che con la scrittura dell’autore francese assumo nuova forma, quella gelida, perfetta, preziosa e naturale del diamante. Percorrendo nelle pagine del libro la vita del protagonista non si viene mai colti dal sospetto che Adam voglia catturarci con qualche trucco: tutto è assolutamente sincero, spontaneo, francese e allo stesso tempo universale, esattamente come, leggendo Carver, ci sembra che i luoghi e le persone che descrive, così distanti culturalmente e geograficamente, facciano in realtà sempre parte della nostra vita. Noi, lettori e protagonista del romanzo, ci immergiamo nella memoria, nel passato, per provare a ritrovarci, ben sapendo che alcune cose sono e saranno perse per sempre.
Sono rimasto sorpreso, quindi, quando ho iniziato a leggere Scogliera, uscito qualche mese fa: un romanzo, uno dei tre che Adam ha scritto. Ma la sorpresa si è esaurita nel momento in cui ho cominciato la lettura. Eccole, le parole di Adam, ecco il suo modo unico di raccontare e rappresentare la tristezza e il dolore, sentimenti abusati in ogni modo e con ogni mezzo, ma che con la scrittura dell’autore francese assumo nuova forma, quella gelida, perfetta, preziosa e naturale del diamante. Percorrendo nelle pagine del libro la vita del protagonista non si viene mai colti dal sospetto che Adam voglia catturarci con qualche trucco: tutto è assolutamente sincero, spontaneo, francese e allo stesso tempo universale, esattamente come, leggendo Carver, ci sembra che i luoghi e le persone che descrive, così distanti culturalmente e geograficamente, facciano in realtà sempre parte della nostra vita. Noi, lettori e protagonista del romanzo, ci immergiamo nella memoria, nel passato, per provare a ritrovarci, ben sapendo che alcune cose sono e saranno perse per sempre.
Ciò che si cancella dal nostro cervello si cancella anche dal nostro corpo, dal nostro sangue, dalla nostra vita, non lascia alcuna traccia, alcun segno, se non quello di un vuoto assoluto, freddo e vertiginoso
(Olivier Adam, Scogliera, minimum fax, Roma, 2007, p. 164 – traduzione di Maurizia Balmelli)