Quadri e quadretti: Pearl Jam – Palamalaguti, Bologna, 14 settembre 2006
 La cassetta su cui avevo registrato Ten, il primo disco dei Pearl Jam, è una Sony HF 60, infilata in una custodia di un’altra cassetta: quelle della Sony sono trasparenti, mentre quella è nera, di plastica. I titoli delle canzoni sono scritti con un pennarello nero su un foglio tratto da un quaderno a quadretti. Credo di avere quella cassetta dal 1992, più o meno l’anno in cui comprai la mia prima camicia a quadri, di flanella, di quelle che si vedevano addosso ai vari gruppi grunge dell’epoca. L’anno dopo, credo, iniziai a lasciarmi crescere i capelli (“capelli lunghi non porto più, ma suono la chitarra”: scusate, è che quell’altro concerto…), che all’inizio avevano più o meno la lunghezza di quelli di Eddie Vedder all’epoca.
La cassetta su cui avevo registrato Ten, il primo disco dei Pearl Jam, è una Sony HF 60, infilata in una custodia di un’altra cassetta: quelle della Sony sono trasparenti, mentre quella è nera, di plastica. I titoli delle canzoni sono scritti con un pennarello nero su un foglio tratto da un quaderno a quadretti. Credo di avere quella cassetta dal 1992, più o meno l’anno in cui comprai la mia prima camicia a quadri, di flanella, di quelle che si vedevano addosso ai vari gruppi grunge dell’epoca. L’anno dopo, credo, iniziai a lasciarmi crescere i capelli (“capelli lunghi non porto più, ma suono la chitarra”: scusate, è che quell’altro concerto…), che all’inizio avevano più o meno la lunghezza di quelli di Eddie Vedder all’epoca.
Lo dicevo sempre: se potessi scegliere che voce avere, vorrei poter cantare come il cantante dei Pearl Jam. Chiamatemi scemo.
Ma intanto, i Pearl Jam, non li avevo ancora visti dal vivo. Continuavo a registrare cassettine con live, e poi a comprare o masterizzare dei bootleg ufficiali, e a cantare guardando lo stereo. Non come Eddie Vedder.
 Sono passati quattordici anni, e finalmente ce l’ho fatta a vedere i Pearl Jam in concerto, nonostante un’attesa sfiancante (per molti versi) sotto la pioggia, che ho preso tutta addosso: vi pare che un quindicenne ad un concerto si porti l’ombrello? Il quindicenne, completamente bagnato, nonostante quella cassetta e quella camicia siano nella casa natale, ormai, a scambiarsi quadri e quadretti, ha potuto cantare a squarciagola le canzoni di quella cassetta. “Even Flow”. “Porch”. “Why Go”.
Sono passati quattordici anni, e finalmente ce l’ho fatta a vedere i Pearl Jam in concerto, nonostante un’attesa sfiancante (per molti versi) sotto la pioggia, che ho preso tutta addosso: vi pare che un quindicenne ad un concerto si porti l’ombrello? Il quindicenne, completamente bagnato, nonostante quella cassetta e quella camicia siano nella casa natale, ormai, a scambiarsi quadri e quadretti, ha potuto cantare a squarciagola le canzoni di quella cassetta. “Even Flow”. “Porch”. “Why Go”.
“Black” (e i suoi cieli di altri, che all’epoca erano così platonici, adesso, invece, sono così concreti, reali e distanti in maniera quasi rassicurante, anche se la tinta rimane presente. Un pezzo che è la parte disperata e riflessiva della mia adolescenza*, e non solo. E anche di molti altri, mi sa, a sentire come la cantava il pubblico di ieri).
“Alive”.
Nonostante tutto.
La scaletta di ieri, tratta da www.pearl-jam.it: Elderly Woman Behind a Counter in a Small Town, Do The Evolution, Animal, Severed Hand, Given To Fly, World Wide Suicide, Save You, Even Flow, I Am Mine, Marker In The Sand, Green Disease, Daughter / (It’s OK), Alone, Whipping, Present Tense, Comatose, Porch
bis 1: Black, Better Man, Life Wasted, Alive
bis 2: Bu$hleaguer, Why Go, Baba O’Riley, Indifference
No, per dire. Che concerto meraviglioso.
* “Smells Like Teen Spirit”, invece, è la parte disperata e violenta della mia adolescenza. Oh, mi verrete mica a dire che avete avuto un’adolescenza felice? Per contratto la felicità innocente e pura finisce con la prima presa per il culo in prima media.











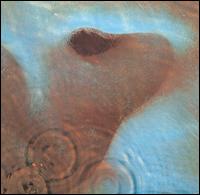




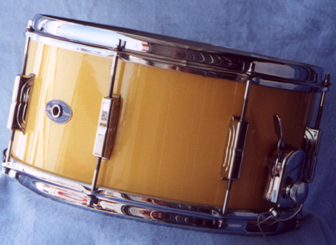

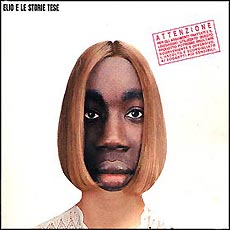

 Brian Wilson non ce la fa. E qui scatta la commozione, perché uno dei veri geni della musica americana non ce la fa più, nonostante sia coetaneo di McCartney, Bowie, Jagger, gente che salta, canta, balla. Lui non ce la fa, e si vede. Sta seduto, agita le mani come farebbe un vecchio nonno un po’ rimbambito, legge le parole sugli schermi che ha davanti.
Brian Wilson non ce la fa. E qui scatta la commozione, perché uno dei veri geni della musica americana non ce la fa più, nonostante sia coetaneo di McCartney, Bowie, Jagger, gente che salta, canta, balla. Lui non ce la fa, e si vede. Sta seduto, agita le mani come farebbe un vecchio nonno un po’ rimbambito, legge le parole sugli schermi che ha davanti. prima, probabilmente, per il peso di un padre-padrone-manager ossessivo. Poi, per i Beatles: diciamocelo, ma vi rendete conto, soffrire per i Beatles? Voglio dire, hanno provato questo lui, Pete Best (il loro primo batterista) e Stuart Sutcliffe (mollato prima di incidere il primo disco). Wilson soffre perché sente che, dall’altra parte dell’oceano, c’è qualcuno che fa musica in maniera geniale. Esce Rubber Soul, nel 1965, e lui dice: “Minchia!” (probabilmente). E poi aggiunge: “Adesso vi faccio vedere io.” E sforna quel capolavoro che è Pet Sounds. Tre mesi dopo i Beatles fanno uscire Revolver. Dieci mesi dopo ancora, Sgt. Pepper’s. E Brian crolla, letteralmente.
prima, probabilmente, per il peso di un padre-padrone-manager ossessivo. Poi, per i Beatles: diciamocelo, ma vi rendete conto, soffrire per i Beatles? Voglio dire, hanno provato questo lui, Pete Best (il loro primo batterista) e Stuart Sutcliffe (mollato prima di incidere il primo disco). Wilson soffre perché sente che, dall’altra parte dell’oceano, c’è qualcuno che fa musica in maniera geniale. Esce Rubber Soul, nel 1965, e lui dice: “Minchia!” (probabilmente). E poi aggiunge: “Adesso vi faccio vedere io.” E sforna quel capolavoro che è Pet Sounds. Tre mesi dopo i Beatles fanno uscire Revolver. Dieci mesi dopo ancora, Sgt. Pepper’s. E Brian crolla, letteralmente. Tutto questo, badate bene, scrivendo canzoni che, perdonatemi la banalità, appena iniziano fanno spuntare sorrisi e bermuda a chiunque.
Tutto questo, badate bene, scrivendo canzoni che, perdonatemi la banalità, appena iniziano fanno spuntare sorrisi e bermuda a chiunque.