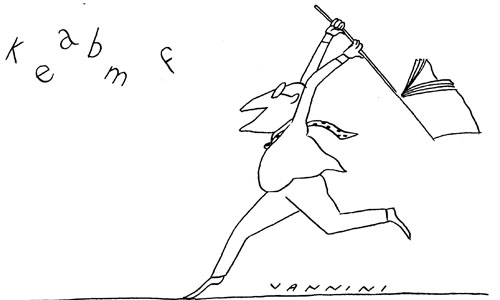Narrare il mistero: i racconti di Flannery O’Connor

Il volume Tutti i racconti di Flannery O’Connor mi ha accompagnato per sei mesi. Doveva essere una lettura estiva, e in effetti ho cominciato durante le vacanze questo meraviglioso viaggio di scoperta di una delle più grandi autrici di sempre.
Ma la lettura è stata interrotta da altre cose più urgenti, il libro è stato travolto da un’onda inaspettata sulle coste croate e, soprattutto, ognuno dei trentuno racconti che compone la raccolta (davvero mirabile per completezza, un po’ meno per la traduzione non sempre eccellente delle pur esperte Marisa Caramella e Ida Ombroni, che si lasciano sfuggire – tanto per fare un esempio – un’improbabile “arpa” per rendere il sostantivo “harp”, che sta per armonica a bocca) è denso e folgorante al tempo stesso.
La O’Connor racconta gli Stati Uniti meridionali degli anni ’50: una sorta di Paese nel Paese, dove la schiavitù tutto sommato è tollerata, sebbene si inizino a percepire i primi segni di cambiamento. Un Paese nel Paese agricolo, con pochi conglomerati urbani, che ha come controcampo quella New York vista sempre come un posto caotico, lontano, pericoloso, crudele e soprattutto senza dio.
Insieme, infatti, a campi, vacche e braccianti afroamericani, in ogni pagina di questi racconti c’è la religione a dominare la trama e i personaggi che la popolano. Molto spesso l’autrice mette a confronto la fede con la razionalità, creando una specie di ragionamento per assurdo: molti dei caratteri che troviamo nelle storie hanno infatti le migliori intenzioni nei confronti del mondo o di qualcun altro, ma sono lontani dalla religione, bollata spesso come una credenza dalla quale stare alla larga o, quanto meno, da osservare con sospetto.
Eppure, sebbene la O’Connor non faccia sconti sugli atteggiamenti bigotti o estremamente ortodossi degli uomini e delle donne di fede, ci mostra quanto e come la ragione possa fallire, e con essa le buone maniere, la rispettosità, l’0nore.
Ogni volta che si conclude la lettura di un racconto della raccolta si rimane davvero colpiti dalla violenza improvvisa che hanno alcune chiusure, resa ancor di più tale dalla maestria che la scrittrice ha nel portarci all’interno della storia. Raramente ho visto usare le parole (spesso declinate in fiammeggianti similitudini) in maniera così efficace: basta pochissimo e ci pare di conoscere volti, luoghi, sapori e odori.
Possiamo percepire la pigrizia e l’indolenza di alcuni personaggi, avvicinarci maggiormente ad altri, vivere con loro negli ambienti spartani ma rispettabili in cui questi agiscono. Nel giro di un paio di pagine abitiamo quelle case e riconosciamo i loro abitanti. Contemporaneamente a questa penetrazione si pone il problema dell’identificazione: come si diceva, la O’Connor non fa sconti a nessuno, ma sa che il suo lettore è tendenzialmente lontano dalle posizioni religiose.
A fatica, quindi, prendiamo le parti di chi “ragiona col proprio cervello” e proseguiamo nella lettura, fino alla conclusione, appunto, che la maggior parte delle volte è spiazzante. Dopo l’ultima parola rimaniamo immobili, talvolta agghiacciati, a riflettere su quello che abbiamo letto, ma soprattutto su quello che credevamo di avere compreso e che invece non abbiamo neanche intuito e ci viene il dubbio che esista qualcosa davvero al di là di ogni possibile comprensione.
“Credo che uno scrittore serio descriva l’azione solo per svelare un mistero. Naturalmente, può essere che lo riveli a se stesso, oltre che al suo pubblico. E può anche essere che non riesca a rivelarlo nemmeno a se stesso, ma credo che non possa fare a meno di sentirne la presenza.” (dall'”Introduzione” di Marisa Caramella, in Flannery O’Connor, Tutti i racconti, Milano, Bompiani, 2009, p. VII)