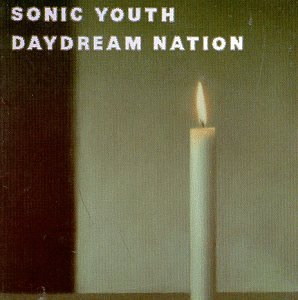Machine Gun
“Do we exchange cards?”, mi chiede la potentissima agente giapponese, alla fine della riunione.
Una riunione che mi ha visto – in quanto soggetto nuovo, inedito, sconosciuto, occidentale, italiano – oggetto di domande indiscrete nei contenuti tanto quanto impeccabili e gentili nella forma.
E io non ho un biglietto da visita con cui concludere degnamente la riunione.
Una riunione in cui l’agente e un suo collaboratore chiedevano, discutevano, confabulavano tra loro, mentre io cercavo di cavarmela. E mentre un’altra giapponese scriveva tutto quello che ci dicevamo, e un agente se possibile ancora più potente della mia interlocutrice ascoltava, suggeriva domande, commentava. In giapponese.
Vengo a sapere che il biglietto da visita viene dato con due mani. “È una questione zen, di ying e yang”, mi dice I. E io, che di zen non so nulla, e diffido senza sapere, non ho un biglietto da visita da porgere con due mani.
Usciamo.
Mi si chiede di essere una mitragliatrice, ultimamente. E allo stesso tempo di esserne il bersaglio, un omino-sempre-in-piedi.
Ed è forse per questo che mi sono completamente distaccato da tutto l’altroieri, a Firenze, quando sono andato a vedere i Portishead. Un concerto perfetto, impeccabile, con Beth Gibbons che pareva sollevare tutto il dolore del mondo ad ogni nota.
Mi viene richiesto di continuare, di non abbattermi, di non pensarci, di andare avanti, con o senza biglietti da visita. Di fare bene, fare tutto, sorridere, calcolare, rispondere, prendere decisioni, essere efficiente. È una guerra, ma se ne accorge qualcuno?
In questi momenti, in cui sembra di fare, fare, fare, avendo così poco (se non niente) indietro, è stato un piacere abbandonarmi alla band inglese, che ha suonato solo per me. Che sia stato un caso che l’unico brano che abbia ripreso, dopo decine di foto scattate, sia stato “Roads”?
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=DQ9YG6WCu98&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999&hl=it]







 Comunque. Era la prima volta che vedevo la Donà dal vivo, e avevo nelle orecchie solo voci di gente che mi diceva delle gag che faceva dal vivo. Ora, mi era stata molto simpatica quando era venuta in radio (
Comunque. Era la prima volta che vedevo la Donà dal vivo, e avevo nelle orecchie solo voci di gente che mi diceva delle gag che faceva dal vivo. Ora, mi era stata molto simpatica quando era venuta in radio ( Ed è andata così fino alla fine. Ecco, quando un’artista riesce a parlare in maniera intima e scanzonata allo stesso tempo, per me raggiunge qualcosa che molti altri musicisti che ho visto su quel palco e in tanti altri posti non sfiorano neanche. La consapevolezza di sè, della propria bravura e dei propri limiti, ti porta davvero dentro la musica che sta suonando. E si svolazza tutti insieme, ben sapendo che, anche se si dovesse atterrare di culo, ci sarebbe una risata a separarci dal prossimo decollo.
Ed è andata così fino alla fine. Ecco, quando un’artista riesce a parlare in maniera intima e scanzonata allo stesso tempo, per me raggiunge qualcosa che molti altri musicisti che ho visto su quel palco e in tanti altri posti non sfiorano neanche. La consapevolezza di sè, della propria bravura e dei propri limiti, ti porta davvero dentro la musica che sta suonando. E si svolazza tutti insieme, ben sapendo che, anche se si dovesse atterrare di culo, ci sarebbe una risata a separarci dal prossimo decollo.


 Uno si rende conto di come passi veloce il tempo quando nota che ha parlato di questa data dei Police
Uno si rende conto di come passi veloce il tempo quando nota che ha parlato di questa data dei Police 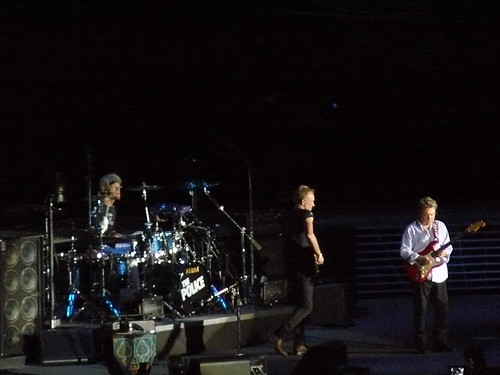 Insomma, alla fine i Police sono saliti sul palco allestito al “Delle Alpi” davanti a 65000 persone. Solo il pubblico, visto dall’alto delle tribune, era uno spettacolo. Scaletta ben congegnata, con pezzi più soft per prendere fiato alternati ad altri brani suonati veramente con indole rock: e le età dei tre, sommate, arrivano quasi a 180 anni. Molti brani sono stati riarrangiati, con un picco in una meravigliosa versione di “Wrapped Around Your Finger”, veramente emozionante. Schermi giganti e giochi di luce hanno esaltato una scenografia comunque sobria. E poi, che dire della scaletta? Un successo dopo l’altro, dai cinque dischi usciti in poco più di cinque anni. “Roxanne” ci ha invaso di luci rosse, Sting non si è risparmiato, Stewart Copeland ha percosso ogni cosa, Andy Summers ha fatto il suo (e si anche messo una giacchetta, ad un certo punto: si sa, a volte basta un colpo di freddo…). E’ stato un concerto divertente, ben suonato, che ha coinvolto il pubblico più enorme che mi sia capitato di vedere finora. E alla fine, dopo una versione davvero tirata del primo pezzo di Outlandos d’amour, “Next to You”, tutti a casa sorridenti, dai quindicenni che hanno spulciato nei dischi di papà, ai papà, appunto. E la sensazione di avere visto un mito, sì, venticinque anni dopo, ma pur sempre mito.
Insomma, alla fine i Police sono saliti sul palco allestito al “Delle Alpi” davanti a 65000 persone. Solo il pubblico, visto dall’alto delle tribune, era uno spettacolo. Scaletta ben congegnata, con pezzi più soft per prendere fiato alternati ad altri brani suonati veramente con indole rock: e le età dei tre, sommate, arrivano quasi a 180 anni. Molti brani sono stati riarrangiati, con un picco in una meravigliosa versione di “Wrapped Around Your Finger”, veramente emozionante. Schermi giganti e giochi di luce hanno esaltato una scenografia comunque sobria. E poi, che dire della scaletta? Un successo dopo l’altro, dai cinque dischi usciti in poco più di cinque anni. “Roxanne” ci ha invaso di luci rosse, Sting non si è risparmiato, Stewart Copeland ha percosso ogni cosa, Andy Summers ha fatto il suo (e si anche messo una giacchetta, ad un certo punto: si sa, a volte basta un colpo di freddo…). E’ stato un concerto divertente, ben suonato, che ha coinvolto il pubblico più enorme che mi sia capitato di vedere finora. E alla fine, dopo una versione davvero tirata del primo pezzo di Outlandos d’amour, “Next to You”, tutti a casa sorridenti, dai quindicenni che hanno spulciato nei dischi di papà, ai papà, appunto. E la sensazione di avere visto un mito, sì, venticinque anni dopo, ma pur sempre mito. Andando all’Arena Parco Nord, mercoledì, mi dicevo: “Pubblicherò sul blog qualcosa a proposito del concerto, ma sarà la terza volta che parlo di Elio e le storie tese. Mi limiterò a delle foto.”
Andando all’Arena Parco Nord, mercoledì, mi dicevo: “Pubblicherò sul blog qualcosa a proposito del concerto, ma sarà la terza volta che parlo di Elio e le storie tese. Mi limiterò a delle foto.” L’
L’ I NIN hanno seguito più o meno le scalette dei concerti del tour di Year Zero. La scaletta di Milano è stata più ricca di classici (ricordo ancora, allora, una “Reptile” da brividi), ma si sono superati in quanto ad allestimento del palco. Il vero motivo, a parte l’età che avanza, per cui mi sono messo a una certa distanza dal palco è stato proprio quello di vedere le luci e gli effetti sul palco dei Nine Inch Nails. Nel loro ultimo dvd, Beside You In Time, è possibile rendersi conto dell’apparato scenico che accompagna alcuni pezzi: è sbalorditivo il lavoro che viene fatto e la precisione con cui lo staff di Reznor e soci agisce sul palco, in perfetta coordinazione con dei musicisti pazzeschi. Ho letto di sospetti di playback, ma sinceramente non credo siano fondati. Reznor è un perfezionista e difficilmente si accontenta di performance mediocri da parte di musicisti e tecnici. Ecco spiegata l’enorme livello della performance dei NIN. E poi hanno fatto “Dead Souls”!
I NIN hanno seguito più o meno le scalette dei concerti del tour di Year Zero. La scaletta di Milano è stata più ricca di classici (ricordo ancora, allora, una “Reptile” da brividi), ma si sono superati in quanto ad allestimento del palco. Il vero motivo, a parte l’età che avanza, per cui mi sono messo a una certa distanza dal palco è stato proprio quello di vedere le luci e gli effetti sul palco dei Nine Inch Nails. Nel loro ultimo dvd, Beside You In Time, è possibile rendersi conto dell’apparato scenico che accompagna alcuni pezzi: è sbalorditivo il lavoro che viene fatto e la precisione con cui lo staff di Reznor e soci agisce sul palco, in perfetta coordinazione con dei musicisti pazzeschi. Ho letto di sospetti di playback, ma sinceramente non credo siano fondati. Reznor è un perfezionista e difficilmente si accontenta di performance mediocri da parte di musicisti e tecnici. Ecco spiegata l’enorme livello della performance dei NIN. E poi hanno fatto “Dead Souls”!