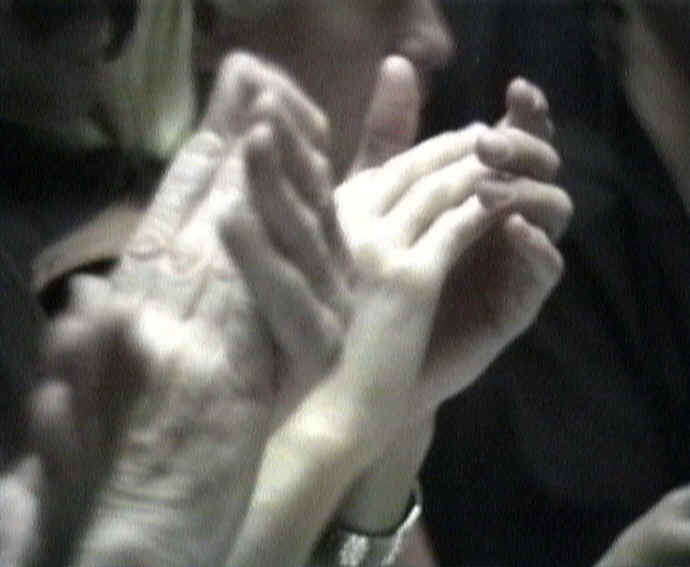Note psichiatriche
L’industria musicale e i suoi esponenti maggiori stanno agonizzando, andando verso la pazzia più completa. Due esempi per dimostrarlo.
 Antonello Venditti: basta rubare i titoli delle mie canzoni. Il popolare cantore romano si è lamentato, qualche giorno fa, che alcuni suoi titoli erano sfruttati senza che lui ricevesse i diritti per “Buona domenica”, “Notte prima degli esami”, “Ricordati di me”. (ANSA, che scrive nell’agenzia “Ricordati di te“)
Antonello Venditti: basta rubare i titoli delle mie canzoni. Il popolare cantore romano si è lamentato, qualche giorno fa, che alcuni suoi titoli erano sfruttati senza che lui ricevesse i diritti per “Buona domenica”, “Notte prima degli esami”, “Ricordati di me”. (ANSA, che scrive nell’agenzia “Ricordati di te“)
Si apriranno presto i processi che vedono coinvolto Paolo Conte contro il cielo (“Azzurro”), l’Unione Dolciaria Italiana (“Gelato al limon”) e la FIAT (“La topolino amaranto”), l’atteso match di Pieroa Pelùa contro Capitan Uncino (“Pirata”) contro Edoardo Bennato contro Collodi contro Walt Disney contro le rappresentanze sindacali dei sorci.
 OLGA costretto a chiudere. L’Online Guitar Archive, un enorme sito in cui sono archiviati testi e accordi di milioni di canzoni, ha chiuso per la pressione delle case discografiche, che accusano i webmaster di violazione di diritto d’autore.
OLGA costretto a chiudere. L’Online Guitar Archive, un enorme sito in cui sono archiviati testi e accordi di milioni di canzoni, ha chiuso per la pressione delle case discografiche, che accusano i webmaster di violazione di diritto d’autore.
Nello stesso giorno Alberto Scafagna, un pensionato di Velletri, è stato arrestato per avere fischiettato una canzone di Mina senza avere pagato la SIAE. A nulla è valsa la difesa dello Scafagna, che, sotto suggerimento del suo avvocato, si è dichiarato stonato pur di sfuggire alla morsa della giustizia.
E vaffanculo: ecco una serie di siti interessanti, se non li conoscete:
– Mp3Maniaco
– Regnyouth Archives
– Mp33pm
Tanto, in questo mondo di ladri… Ops. Vado a dare qualche centesimo ad Antonello.