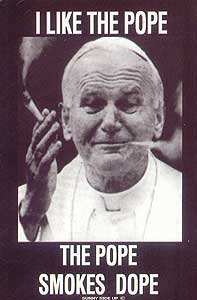2.0
 E quindi, per la prima volta dal gennaio di quest’anno (escludendo la pausa di agosto) non ho postato quotidianamente sul blog, anche perché ero impegnato a rimetterlo a posto.
E quindi, per la prima volta dal gennaio di quest’anno (escludendo la pausa di agosto) non ho postato quotidianamente sul blog, anche perché ero impegnato a rimetterlo a posto.
Più di novecento articoli non sono uno scherzo, né dal punto di vista del tempo speso (in un frangente della mia vita in cui il lavoro mi ha letteralmente sommerso), né per quanto riguarda l’impatto psicologico di rileggersi interamente otto anni di post (per taggarli, associarli a categorie, eccetera) in ordine cronologico. Mi sono ovviamente divertito, arrabbiato, compatito, criticato e preso per il culo.
Ed è stato trasferito e salvato anche quello che chiamavo (ed è) “L’inutile fotoblog di A Day in the Life”: da Splinder è passato a Flickr. E anche il lavoro fatto su quel centinaio di foto è stato stimolante, dal punto di vista emotivo e psicologico. Mi sono accorto di fare una nuova psicanalisi (dopo le parole, usando le immagini) quando ho notato che, mentre mettevo a posto le foto, l’ora di lavoro era in realtà di cinquanta minuti e costava tantissimo.
Il tutto è accaduto in un periodo per certi versi logorante e di sicuro denso di cambiamenti dal microscopico all’internazionale; talmente esagitato che, se oggi fosse il 20 dicembre 2012, starei leggendo da un pezzo La religione Maya for Dummies, sottotitolo: “Un dio vale l’altro, ma intanto salvati il culo”. E invece no: tutto ciò è solo la preparazione per un anno che ci vedrà saltare come pop corn in una padella, ne sono certo. Speriamo almeno che, dopo, il film sia decente.
Comunque, ora posso dirlo, ecco a voi il nuovo blog. Oltre al solito profluvio di parole più o meno inutili e senza senso, ci troverete le interviste fatte nelle vecchie trasmissioni Sparring Partner e Monolocane e altro materiale audio.
Adesso si ricomincia cercando di essere un po’ più leggeri e sfrontati degli ultimi tempi. Ero più divertente, a metà anni 2000, ammettiamolo. Ma avevo un gusto pessimo nello scegliere le immagini da associare ai post. La nuova scelta stilistica (che attende i vostri pareri) è all’insegna della sobrietà e della maggiore qualità rispetto alla quantità. Insomma: una foto per post, anche non tutti i giorni, però un po’ di sostanza, per dio.
E comincio, quindi, contraddicendomi. Foto a parte.



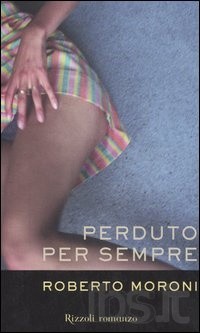



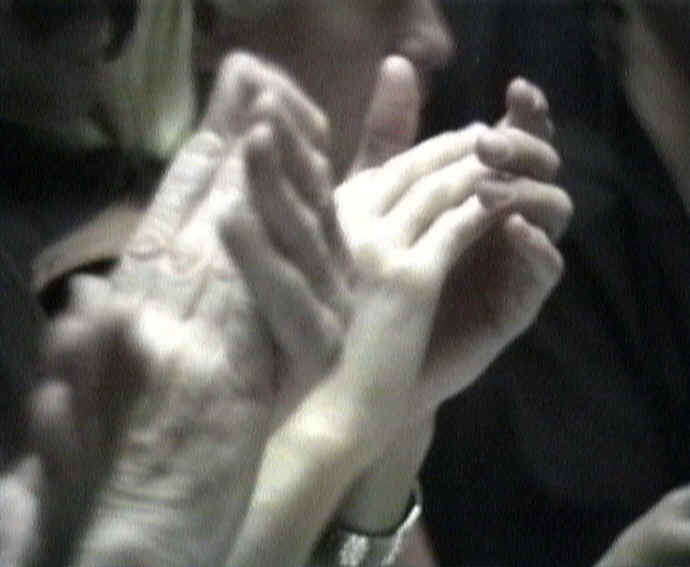
 No, giusto una breve nota per dirvi che domani a
No, giusto una breve nota per dirvi che domani a