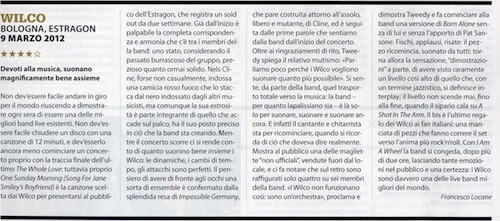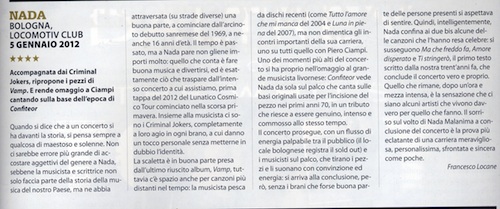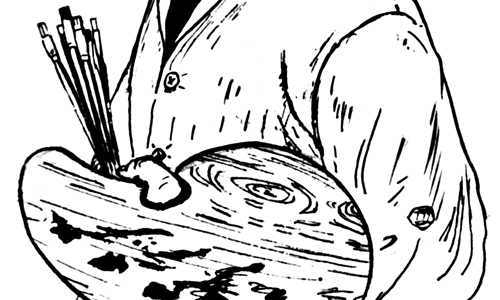I due volti della bellezza – 1. Bon Iver a Ferrara
L’edizione 2012 di Ferrara sotto le stelle, un festival di cui spesso ho parlato in queste pagine, è stata particolare. La causa primaria della sua peculiarità è relativa ai terremoti di maggio, che hanno portato alla scelta di trasferire i live (quando non sono stati annullati, come nel caso della Gainsbourg) da piazza Castello al Motovelodromo e dal Cortile Estense al parco Massari.
Ma non è stato solo il terremoto a influire sulla manifestazione: ci ha messo lo zampino anche la crisi economica o, molto più prosaicamente, il fatto che la gente abbia meno soldi da spendere in genere.
I biglietti (che andavano dai 13 ai 30 euro), quindi, sono diventati irraggiungibili per molti, che hanno preferito le numerose offerte musicali dal vivo gratuite organizzate in varie città sulle quali la manifestazione “gravita”.
Il risultato è che quest’anno di Ferrara sotto le stelle si è parlato meno degli anni scorsi, si è sentito di meno nell’aria, forse è andata ai concerti meno gente di quanta se ne aspettassero gli organizzatori. Ciononostante, anche questa edizione mi ha regalato due concerti meravigliosi, una sera dopo l’altra.
Di Bon Iver mi sono invaghito (come molti) quando sentii il dolente For Emma, Forever Ago, qualche anno fa. Ho continuato a seguirlo, ascoltando e apprezzando i successivi ep e album, ma sono rimasto incuriosito soprattutto da un disco uscito nel 2009 che vede Justin Vernon insieme alla big band della sua scuola di Eau Claire alle prese con un repertorio che spazia dai suoi brani a standard di Ellington, Nina Simone e Ella Fitzgerald.
Avendo ascoltato Eau Claire Memorial Jazz I poco più di un anno dopo l’esordio di Bon Iver, sono rimasto colpito: che avevano a che fare le canzoni scritte nella fredda baita per dimenticare una ragazza con quel jazz? Ci è voluto il concerto di Ferrara per capirlo.
Sul palco del Motovelodromo, giovedì scorso, sono saliti nove musicisti: oltre a Vernon, due batteristi, un violinista, suonatori di fiati e un paio di polistrumentisti, per non farci mancare nulla. Davanti a ogni membro (a parte uno dei due batteristi) un microfono per la voce. Dalla traccia di apertura “Perth”, fino a quella che ha chiuso il bis, un’ora e mezza dopo, il live è stato un esempio perfetto di riarrangiamento polistrumentale e polivocale.
Le armonie di voce hanno coinvolto fino a otto musicisti insieme e, in genere, il ripensamento dei brani (originariamente così scarni e spogli) è stato incredibilmente fedele, nonostante coinvolgesse così tanti timbri e colori in più rispetto alle incisioni originali.
Il miracolo è stato che mai nel concerto è parso che qualcosa fosse di troppo, che una parte fosse messa là per impressionare il pubblico, che ci fossero trucchi, insomma. Non solo: Justin Vernon, vincitore di due Grammy, ha chiacchierato col pubblico, con modestia e ironia, come di rado capita di sentire.
Intendiamoci: non si è trattato di concioni infinite, ma di parole giuste al momento giusto, senza che queste sembrassero preparate ad hoc. E la musica: ha fluttuato da atmosfere personali e emotivamente struggenti a momenti di coinvolgimento totale, con un totale cambio di dinamica rispetto ad altri frangenti.
Insomma, un godimento, creato da musicisti fantastici che hanno trovato il modo giusto di proporre uno spettacolo (perché di questo si tratta) non negandolo, ma convogliandolo in maniera naturale, spontanea e comunque perfetta.
Una gioia assoluta, condivisa con i tremila presenti al Motovelodromo che è riuscito a diventare un posto intimo quasi come piazza Castello, dove era previsto si tenesse il concerto.
continua