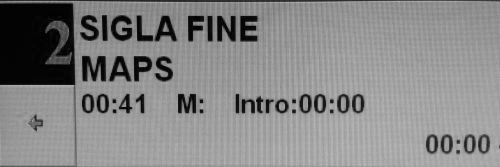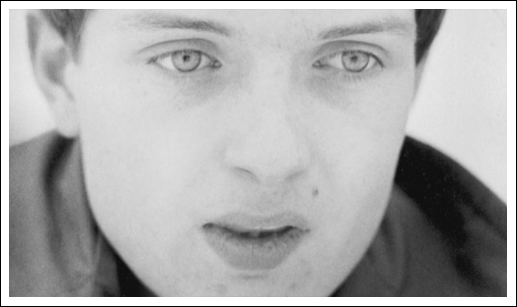Dal Nilo al Tamigi: intervista con i Melt Yourself Down

Una delle cose più belle che mi può capitare quando ascolto un disco nuovo, estratto dai pacchi di cd che arrivano, è metterlo nel lettore, magari dando le spalle alle casse o facendo altro e, dopo qualche secondo di musica, venire rapito al punto da lasciare ogni altra attività e rivolgere l’attenzione (anche posturalmente) alla musica. Il debutto dei Melt Yourself Down, band nata da Pete Wareham degli Acoustic Ladyland e formata da membri di Sons Of Kemet, Hello Skinny, Zun Zun Egui, Transglobal Underground e da musicisti che suonano con Fela Kuti e Mulatu Astakte, ha avuto su di me esattamente questo effetto: mi sono letteralmente innamorato del mescolamento di afro ed elettronica del gruppo britannico e sono andato a vederli dal vivo a Londra, in agosto. Su una panchina vicina al Tamigi ho intervistato il sassofonista Pete Wareham.
Come è nata la band? È iniziato tutto per caso o c’era da subito l’intenzione di fare un disco?
No, non ero intenzionato a fare un disco all’inizio, ma solo a creare quel tipo di musica. Con gli Acoustic Ladyland ogni volta andava così: facciamo un disco, registriamo qua, facciamo quest’altra cosa, avevo sempre delle scadenze. Ho scritto un disco, non ha funzionato, non l’abbiamo pubblicato e ho capito che il problema erano proprio le scadenze. Ho sempre pensato di essere bravo con le scadenze, ma poi mi sono reso conto che non lo ero. Quindi stavolta ho pensato: non avrò scadenze né progetti di pubblicazione; mi limiterò a scrivere della musica, mettere insieme una band e vedere cosa succede. Ecco come sono andate le cose. E solamente qualche mese dopo l’inizio di tutto ho pensato che potevamo registrare qualcosa.
Come hai trovato i ragazzi della band?
Ho dato loro un colpo di telefono.
Eravate amici?
Sì, persone che conoscevo e con cui lavoravo da tempo.
Qualcuno che hai chiamato ha iniziato e poi se n’è andato o anche non era interessato dall’inizio?
No, hanno detto tutti di sì.
Quindi hai trovato subito le persone giuste!
Sì, in realtà non è che li abbia chiamati dicendo loro “Ti va di fare parte della band?” o cose del genere. Ho solo chiesto se volevano suonare. Hanno detto “Certo che sì” e poi gli è piaciuto farlo ancora, sempre in maniera rilassata, più come un ritrovo che come le prove per una nuova band.
L’album è un viaggio tra Africa e Europa: quali sono i suoi riferimenti musicali?
La musica nubiana, quella relativa all’Egitto. Ne ascoltavo molta e volevo rifare quel suono. Anche la musica algerina. Quindi praticamente la musica nordafricana in generale. Volevo fare passare questa sensazione, ed ecco perché ho messo insieme questa lineup, che è simile a quella usata da Ali Hassan Kuban. C’è un suo pezzo, “Habibi”, che mi ha fatto pensare che volevo lo stesso tipo di suono. Ci sono gli stessi tipi di strumenti che ha una tipica band nubiana, fiati e percussioni. Volevo fare qualcosa con un sacco di fiati e percussioni. All’inizio c’eravamo solo io e Shabaka [Hutchings, altro sassofono della band, ndr]: abbiamo trovato il cantante più tardi.
Hai pensato di usare anche strumenti antichi e tradizionali, che non fossero percussioni e fiati?
Sì, ci ho pensato e magari ci sarà spazio per loro, ma mi piace l’idea di non fare capire facilmente da dove veniamo e cosa facciamo. Diventa un misto di cose diverse, una sorta di geografia della psiche: mi piace fare le cose a modo mio. Io vivo a Londra, be’, un po’ fuori, ma insomma: sono britannico e non sono mai stato là. Non voglio fare un omaggio a quel tipo di musica, ma suonare la mia. Se usassimo gli strumenti tradizionali, ci legheremmo troppo a quel genere e sarebbe qualcosa di troppo definito. Ma magari in futuro…
Mi racconti della produzione e della registrazione del disco? C’è stato spazio per improvvisazioni che poi sono finite, in qualche modo aggiustate, sul disco, per esempio?
Ho registrato le canzoni sul mio computer, inizialmente usando strumenti midi, campioni e loop, suonando il sassofono, cantando e giocandoci un po’. Poi ho trascritto le partiture, ho messo insieme la band, gliele ho date, le abbiamo suonate, abbiamo registrato le prove. Quindi me le sono riportate a casa, ho editato queste prove, aggiungendovi più fiati e altre cose, le ho riportate alla band… e avanti così.
Il disco è sperimentale, suona fresco e, allo stesso tempo, richiede attenzione allo spettatore. Inoltre ha una schietta attitudine “live”: le canzoni sono state create pensando alla loro resa dal vivo?
Non in maniera precisa, a dire il vero, ma siamo tutti musicisti che suonano soprattutto dal vivo: non passiamo la vita in studio, ma sul palco. Poi, ogni tanto, registriamo. Quindi sì, volevo che fosse una cosa entusiasmante da fare dal vivo, ma non perché ho pensato che la gente dovesse rispondere in un certo modo, ma perché volevo suonare così, volevo che la band avesse quel suono.
Parlando sempre di live: visto che provenite da band diverse, non dev’essere facile trovare del tempo libero comune a tutti per fare dei concerti. C’è un tour in vista?
Sì, faremo qualcosa in Belgio, abbiamo un concerto in Francia, al festival Rencontres Trans Musicales di Rennes, una bella manifestazione a cui partecipa un sacco di gente e anche molti promoter, quindi spero che dopo avremo più lavoro all’estero. Diciamo che dove ci vogliono, ci avranno e andremo a suonare per loro. Semplice.
Qual è il ruolo delle parole nelle canzoni? Ci sono dei collegamenti tra i brani, da quel punto di vista?
Kushal [Gaya, il cantante, ndr] ha un approccio alla musica simile al nostro. Talvolta ci improvvisa sopra, lo spezzetta e lo rimette insieme in una canzone, si inventa una sua lingua. È delle Mauritius, quindi parla il creolo, il francese, l’inglese e qualche altra lingua. Si inventa delle parole, ma poi ripete le stesse, non è che improvvisi ogni volta: sono parole, ma non è che devono significare sempre qualcosa. Quello che mi piace di molta della musica nubiana che mi aveva ispirato all’inizio è che è parte del desiderio di preservare la civiltà nubiana. Quel popolo, infatti, inizia a essere disperso anche a causa della diga di Assuan: molti sono andati a vivere al Cairo e c’è una buona possibilità che quella cultura sparisca. Quindi realizzarono molte cose in quella lingua, per preservarla e ovviamente io non la parlo per nulla: di molta della musica che amo non capisco le parole. Non sono parole inglesi su cui costruisco una storia, ma puramente suoni. Quindi mi piace che le parole di Kushal non significhino nulla, perché così la voce ha a che fare con un lato estetico, non con la narrazione. Ma se vuole avere il lusso di usare parole inglesi può farlo: è libero.
Ultimamente molta musica africana è arrivata tramite musicisti anglosassoni: penso alla musica del Mali portata da Damon Albarn, ai Dirtmusic e al lavoro fatto da Dan Auerbach insieme al chitarrista Bombino. Conosci questi dischi?
A dire il vero non ho sentito quasi niente di quelle cose, ho fatto le mie ricerche, ho trovato delle cose per caso, le ho ascoltate e le amate, ma senza pensare di volere fare parte di una certa scena o movimento. Sento musiche che mi piacciono e penso: voglio fare un suono così.
Ti ricordi delle emozioni che hai provato quando, come hai detto tu, sei incappato in queste musiche per la prima volta?
Sì, è stato nel 2000, un bel po’ di tempo fa. In biblioteca ho trovato un cd, la guida di Rough Guide alla world music: c’era un cantante algerino, Dahmane El Harrachi, e una band nubiana contemporanea che vive al Cairo, i Salamat e ho pensato “Wow, incredibili!” e ho continuato da lì.
Quali sono i tuoi cinque dischi dell’isola deserta?
Intendi classici senza tempo della mia vita? A Love Supreme di John Coltrane, Astral Weeks di Van Morrison, e poi… Dio… che domande mi fai! Pink Moon di Nick Drake, Ready To Die, di Notorius B.I.G. e 2001 di Dr Dre. Non c’è musica africana, perché non sono album interi, ma raccolte. Dai, aggiungo anche Walk Like A Nubian di Ali Hassan Kuban.
Un paio d’ore dopo, Pete e i suoi hanno letteralmente infiammato il piccolo palco dell’altrettanto piccolo Propstore, un locale adiacente al National Theatre. Il live è stato uno dei più intensi visti quest’anno (in cui di concerti belli ce ne sono stati proprio tanti). Vedendo la band dal vivo si percepisce qualcosa che sempre più raramente affiora durante un concerto: l’urgenza di suonare. Basterebbe anche solo questo per fare dei Melt Yourself Down una delle band da tenere d’occhio e da non perdere quando saranno in Italia per alcune date nel prossimo dicembre.
Qui l’intervista audio. Qui la galleria fotografica del live al Propstore.
Grazie a Emily Clancy per l’aiuto nella traduzione.