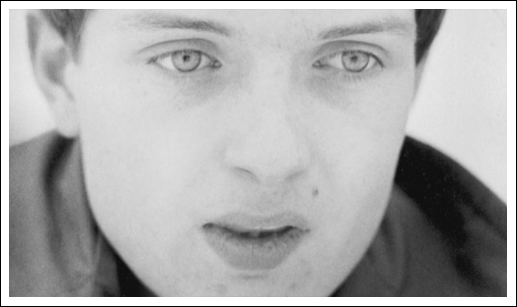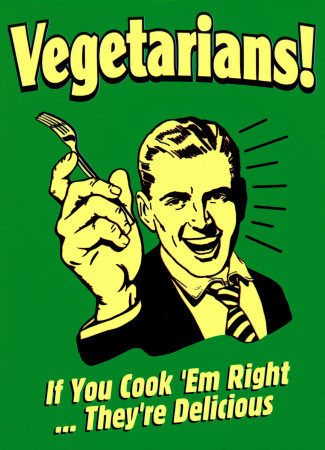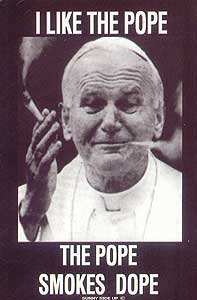Semplicemente rock: intervista ai Drenge

Il 19 agosto scorso ero a Londra: un paio di giorni dopo avere intervistato i Melt Yourself Down avevo appuntamento con i Drenge, che quel giorno facevano uscire il loro album di debutto per la Infectious Records, una delle etichette britanniche più attente alla nuova musica che, ancora una volta, non ha sbagliato. Rory e Eoin Loveless, batteria e voce/chitarra, fanno un rock scarno e crudo, senza ammiccamenti, potente. E, soprattutto, che funziona. Poco prima dello showcase alla Rough Trade (dove buona parte del pubblico era coetaneo, se non più giovane, dei due fratelli ventenni di Sheffield) ho chiacchierato con la band, arrivata all’appuntamento in notevole ritardo e con l’imbarazzo di due ragazzi che hanno scazzato di fronte a Pat, il capo dell’etichetta, e al secondo giornalista italiano con cui avevano avuto mai a che fare fino ad allora. Eoin, il più grande, aveva l’aria più spavalda. Il batterista (come molti batteristi?) era più introverso e vagamente vittima del maggiore. Ma entrambi hanno dimostrato qualità che si percepiscono anche nella loro musica: sono sinceri e diretti. Quale band “hype” ammetterebbe di avere suonato cover dei Keane e dei Razorlight?
Come avete cominciato a suonare? Qual è la storia della band ad oggi?
Rory. I nostri genitori ci hanno spinto a imparare il piano quando eravamo piccoli, suonavamo insieme, ma non ci piaceva il piano. Quindi io ho cominciato a suonare la batteria e Eoin la chitarra. Alla fine abbiamo fatto altre lezioni, suonato insieme e imparato delle cover. Quindi, un paio d’anni dopo, abbiamo scritto le nostre prime canzoni…
Che anno era?
R. Circa il 2011…
Eoin. 2010.
R. Nel 2010. E abbiamo iniziato a fare qualche concerto a Sheffield e diciamo che tutto è cominciato da lì. Abbiamo poi fatto un concerto a Londra, quindi a Manchester, a Leeds e poi in tutto il Regno Unito. Abbiamo continuato, registrato qualcosa, quattro pezzi due anni fa, a settembre, e altri tre o quattro un anno dopo. Il contratto discografico è arrivato a dicembre 2012 e quindi abbiamo registrato alcune cose per metterle insieme e fare il disco… che è uscito oggi!
E. Da quelle sessioni abbiamo fatto tanti altri concerti…
Guidando avanti e indietro da Sheffield! Vi ricordate che cosa suonavate agli inizi, che tipo di jam facevate, o erano cover?
R. Sì, facevamo cover di vari musicisti… I Keane…
E. [un po’ imbarazzato] Era molto tempo fa…
R. Abbiamo anche fatto una specie di cover alla lontana di “What A Wonderful World” di Louis Armstrong. E poi i White Stripes…
E. Anche se è un po’ deprimente ammetterlo… anche i Razorlight.
R. Già, i Razorlight.
Di tutte le band citate mi pare che i White Stripes siano gli unici a cui il vostro suono si avvicina, ma sono curioso della scelta di Louis Armstrong…
E. In realtà posso solo dirti che quella canzone mi piace e mi sono chiesto che ne potevo fare.
Di band con la vostra line-up ce ne sono: se doveste, quindi, definire la vostra caratteristica, la vostra peculiarità, cosa direste?
E. JEFF the Brotherhood sono in due, sono fratelli, ma più vecchi di noi. Potremmo quindi definirci la versione più giovane di quella band. Ecco la nostra peculiarità! In realtà penso che molte di questi duo vengono dagli Stati Uniti, non ci sono molte band britanniche così formate che fanno rock. E inoltre veniamo dalla campagna e abbiamo un gusto musicale molto ampio. Ecco, queste sono nostre caratteristiche che si rispecchiano anche nelle canzoni.
R. Quando abbiamo iniziato a suonarle, tre anni fa, non conoscevamo molti gruppi. La maggior parte dei nostri amici ascoltava dubstep o elettronica, cose così. Ovviamente ora è meno strano perché ne conosciamo di più.
E. Ha senso quello che hai detto?
R. No. [ridono]
La stampa musicale inglese è nota per creare fenomeni ogni settimana e il chiacchiericcio intorno al vostro nuovo album è enorme e non solo nell’ambiente strettamente musicale. Questo vi mette sotto pressione?
R. No, non mi sento sotto pressione.
E. Basta ignorare queste cose e andare avanti. Non è che ti dicono che hai fatto il miglior disco del mondo, dicono che è un disco molto buono e va bene così. Non è un album difficile, appartiene a un genere semplice, basilare, uno dei più vecchi. Non è nulla di complesso o che cambi le carte in tavola: è semplicemente rock. A parte quello che si dice intorno al disco, è un genere diretto che credo noi non suoniamo così male.
Un parlamentare inglese vi ha citati come band da ascoltare, in un’intervista ormai nota. In risposta a questa intervista, però, avete detto (cito) che “sarebbe stato meglio che la gente ci avesse conosciuto in maniera diversa”. Qual è il modo migliore di scoprire la vostra musica?
E. Abbiamo fatto da spalla ad alcune delle nostre band preferite: ecco un buon modo. A me piace chi apre i concerti, cerco sempre di vedere le band di supporto perché spesso si fanno delle belle scoperte. Abbiamo visto gli Splashh, quattro ragazzi che vengono dall’Australia, dalla Nuova Zelanda e da Londra, e c’erano due band con loro, i Wolf Alleys e i Big Deal: davvero bravi. Ci siamo ritrovati spesso nel circolo dei festival e siamo diventati amici.
R. Penso che abbia fatto gioco anche una bella comunità on line: blog e simili. E per gli appassionati di musica c’è una ricchezza di buone informazioni. È un bel modo per farsi conoscere. Perché in fondo se piacciamo a Tom Watson [il parlamentare di cui sopra, ndr], questo ci fa conoscere a un pubblico a cui in realtà della nostra musica non interessa poi molto, e d’altro canto la musica che facciamo non è per loro. Viene accolta in maniera frontale e ignorante da persone a cui non interessa la musica.
Qual è la vostra posizione sul download legale o illegale? Rendereste il vostro disco scaricabile liberamente?
R. Non saprei. Penso sia importante avere la possibilità di ascoltare la musica gratuitamente, ma è altrettanto importante dare un sostegno alle band. La gente lo fa venendo ai concerti. Il modo che ho io di comprare la musica è di ascoltare qualcosa on line e se mi piace la compro su un supporto fisico, anche perché in un certo senso se la pago le do più valore. E’ bello tornare a casa da un tour e mettere su un disco: mi piace più che avere musica costantemente. Ma se non hai i soldi e apprezzi la musica, be’, non farei nulla per impedire che tu possa ascoltare ciò che ti piace.
E. Credo che il punto sia come sfrutti l’artista scaricando musica gratuitamente, se suoni questi pezzi in un dj set o in un club. Abbiamo firmato un contratto per vendere il disco, non perché la gente lo scaricasse. Non sono come Kanye [West, ndr, il cui ultimo disco Yeezus non ha copertina], che pare incoraggi la pirateria. Abbiamo fatto in modo che la versione finale su vinile sia la migliore possibile in assoluto che tu possa comprare. Abbiamo impiegato del tempo per l’artwork, è l’unico formato che ha la stampa in caratteri dorati sul retro… Insomma, è speciale. Abbiamo anche fatto uscire dei singoli su sette pollici e ovviamente puoi anche comprarlo in mp3, ma cerchiamo di spingere la gente verso il lato fisico del disco, con la copertina grande e le stampe colorate.
Accidenti, l’ho appena comprato in cd.
E. Ma va bene lo stesso! È venuto molto meglio di quanto credessi: è stata la prima cosa che abbiamo avuto in mano ed ero colpito dalla stampa delle parole… È davvero bello. Insomma, il cd arriva secondo ma di poco, al fotofinish! (ride)
Parliamo un po’ delle parole delle canzoni: hanno a che fare col posto da dove venite? Ha avuto un’influenza sulla scrittura?
R. Certamente. Eoin ha scritto la maggior parte delle canzoni in un anno di pausa: non faceva niente se non stare seduto a casa e scrivere canzoni. Si è annoiato. C’è molto cinismo, cose buffe senza significato, momenti più rabbiosi…
Sei intervenuto nella scrittura delle parole?
R. Ci ho provato, ma mi ha cacciato via!
E. Sarebbe stato bello condividere anche questo, ma era una specie di frustrazione per me e per lui. Insomma, i compiti ce li dividiamo così.
R. Il posto da dove veniamo è distante e remoto: ci vuole un’ora di autobus per arrivare a Sheffield, il che è molto scocciante. Quando suonavamo a Sheffield dovevamo tornate con l’autobus e non potevamo rimanere a sentire le band dopo di noi. Non potevamo fare nulla! Io sono andato a scuola a Sheffield ed ero stupidamente invidioso dei ragazzi che abitavano là.
Ditemi quali sono i vostri dischi dell’isola deserta: cinque, due a testa e uno che vada bene per tutti e due.
E. Il tuo? No, iniziamo con quello che porteremmo entrambi. Moderno o classico?
R. Io direi classico, perché è sicuramente bello. Forse Highway 61 Revisited di Bob Dylan.
E. Sì, va bene, c’è “Desolation Row”, non è un album da spararsi così, è la canzone lunga alla fine… Highway 61 Revisited per tutti e due. Poi io mi porterei White Blood Cells dei White Stripes e anche Romance Is Boring dei Los Campesinos! O Pearl Mystic degli Hookworms.
R. È una domanda difficile… Probabilmente Solid Air di John Martyn, mi piace un sacco. E Los Angeles di Flying Lotus.
E. Quando pensiamo a questa cosa dell’isola deserta, non credo che vengano fuori i nostri dischi preferiti…
R. … ma quelli a cui pensiamo al momento!
E. No, no… Mi viene da pensare: “Sono bloccato su un’isola deserta con questi dischi, quindi devono essere dischi che ho già amato”.
Grazie a Emily Clancy per l’aiuto nella traduzione. L’intervista viene trasmessa oggi a Maps e potete ascoltarla qua.